SOCIALISM LIFE 27 - EUROPA WETWARE
Alessandro Ceci
giugnoduemilaventiquattro
Olof Palme ripeteva che il
capitalismo è una pecora che va tosata. Solo in questo modo può darci la lana
necessaria per riscaldarci e superare il freddo inverno. Senza questa lana, quindi
senza tosatura, siamo abbandonati ai rigidi rigori del gelo. In altri termini,
se non tosiamo la pecora capitalista, tutti siamo condannati a morire congelati.
La migliore tosatura che conosciamo
è il socialismo, che è riuscito ad equilibrare il mercato senza crollare nel becero
controllo di massa di ogni totalitarismo. La tecnica socialista di tosatura
della società industriale è stata il welfare state, che si è realizzato
solo in Europa e in nessun altro continente al mondo e che ha equilibrato le
relazioni sociali, mantenuto i ritmi di crescita, trasformato la crescita in
sviluppo, accresciuto i diritti, distribuito le responsabilità, ingigantito le
dimensioni della civiltà in termini complessivi di qualità della vita.
A un certo punto, però, questa
sofisticata tecnica di tosatura ha perso ogni sua efficacia ed ogni sua
efficienza.
Perché?
Perché sono cambiate le pecore. Con
l’avvento della società della comunicazione, i capitalisti non sono più stati
quelli che conoscevamo, grazie a Marx, nella società industriale. Dalla
centralità della produzione, proprio grazie alla logica della economia
keynesiana, con la globalizzazione, siamo passati alla centralità del micro-consumo
di massa; dal potere di detenzione dei mezzi di produzione siamo passati al potere
di controllo del marketing non segmentato. E allora la socialdemocrazia
europea, connotato fondamentale della sua stessa identità, non ha saputo più quali
pecore tosare e perché.
L’Unione Europea è stata la più
importante esperienza politica della intera storia dell’umanità per 4 motivi
determinanti: 1 – ha inventato la democrazia nelle sue differenziate
formulazioni, da Atene di Pericle in poi; 2 – ha esteso la sua popolazione e
raddoppiato il territorio integrando diversità senza alcun conflitto ma con
costanti processi di pacificazione condivisa; 3 – proprio grazie al welfare socialdemocratico
si è dedicata alla cura, sia nel senso di sanità sia nel senso di assistenza,
dei suoi cittadini senza che questo si trasformasse in controllo, anzi
estendendo il loro diritto ad avere diritti; 4 – si è integrata seguendo il
metodo marginal-funzionalista (che sarebbe molto utile oggi per la
pacificazione di situazioni esplosive come quelle tipiche del conflitto
israelo/palestinese) che ha generato
istituti di governance estensivi, un apparato governamentale competente e un
governo efficace (leggero ma non debole) dei processi politici moderni.
Nell’evitare un modello di
organizzazione gerarchico-piramidale di tipo westfaliano, l’Europa si è
mostrata finora perfettamente in simbiosi con la dinamica dei trend della
società della comunicazione, più di altre Piattaforme Continentali di Nazionalità
al mondo, perché si è costituita subito come un network a morfologia variabile
(cioè che si clusterizza in relazione ai problemi che, di volta in volta, deve fronteggiare).
Tuttavia, nonostante questi
inequivocabili meriti storici, l’Europa si sente in crisi, soffocata dalla
litania conservatrice che vorrebbe vederla concorre in un teatro di relazioni
internazionali sulla base di una forza apparente che maschera una debolezza
strutturale, fatta di eserciti e di esercizi di dominazione se non addirittura
di supremazia. Sono cognizioni autocratiche che tentano di trasformare l’Unione
in uno Stato, tornando ad un modello gerarchico-piramidale utile per la società
industriale proprio quando la società industriale non c’è più. È il tentativo,
nemmeno troppo velato, di trasformare il network europeo riducendolo ad un
sistema autocratico non più “all’altezza dei tempi”, come diceva Ortega
y Gasset, non più in simbiosi con la dinamica dei trend della società della
comunicazione.
Perché?
Per quale motivo tornare indietro?
Perché, ad esempio, non integrare
le forze armate degli Stati partecipanti all’Unione, clusterizzandole in
network a morfologia variabile nei diversi scenari internazionali in cui ci
sentiamo coinvolti, invece di formare un esercito europeo nuovo e proprio? Perché
non fare lo stesso con la scuola, con le università e con tutti i centri di
ricerca clusterizzati in funzione dei contenuti necessari e opportuni, ad
esempio? Perché non continuare sulla strada già intrapresa, rafforzando la
innovazione europea e la sua connotazione tipica nel mondo, migliorando
semplicemente alcune procedure come la elezione (e non la nomina) della
Commissione o la marginalizzazione del diritto di veto? Perché non continuare
ad essere la prima organizzazione politica in simbiosi con la società della
comunicazione e invece di tornare ad essere il modello che furono gli Stati
nella società industriale, obsoleti nella loro struttura e ormai totalmente
avulsi dalla modernità evolutiva della fenomenologia sociale esistente?
Non si capisce, se non con il
ricorso ad una narrazione stereotipata, fatta di moltissimi cliché e di nessun
archetipo. Si ripete pedissequamente ciò che non si capisce ma che crea una
grande soddisfazione di autoaffermazione. In questo modo, poiché nella società
della comunicazione il potere è affidato alla sintattica e alla semantica del
linguaggio, l’Europa perde ogni giorno la coscienza di essere una “speranza
possibile” e rischia di non saper più trasformare la sua possibilità storica
in probabilità politica.
Per ritrovare i contenuti della sua
narrazione, che siano anche i presupposti della sua condizione, l’Europa ha
bisogno di una nuova socialdemocrazia, che sappia tosate opportunamente le
pecore modificate geneticamente dall’avvento della società della comunicazione.
Non per riformulare un welfare che ormai non c’è più come soluzione politica
alle aspettative dei cittadini; ma per formulare un nuovo wetware
sociale e politico, in grado di costituirsi anche istituzionalmente su
relazioni “entanglement” (vedere il significato in internet) che sono il
presupposto della nuova logica quantistica con cui “l’intelligenza organizza
il mondo organizzando sé stessa”, come diceva Piaget. Le relazioni “entaglement”
sono la base di network a morfologia variabile su cui è storicamente
costituita, con il metodo marginal-funzionalista, la governance europea. La sua
struttura governamentale si è specializzata in questo habitat. Il suo governo
si è impegnato a risolvere in questo modo problemi globali come la pandemia, ad
esempio, ed ora il conflitto per la definizione del confine europeo Russo/Ucraino.
Una Europa wetware significa
continuare a migliorare i network di relazioni “entaglement” su cui l’Europa,
grazie principalmente al suo spirito liberale ed alla sua esperienza
socialdemocratica, si è costituita, integrando ambiente, habitat, tecnologia ed
umano. Il punto di equilibrio di questa integrazione è il wetware, l’elemento
etico di una rete di relazioni sociali, economiche e politiche, che in Europa,
più che in altri continenti al mondo, si è sempre espressa con la determinazione
dei complessi e complessivi diritti di cittadinanza universale.
Un “Socialism life”, una
socialdemocrazia della vita, ancora, dunque, che migliori la propria
connotazione storica: quella di essere stata lo strumento di tutela di ogni
persona e la funzione principale per migliorare la qualità della vita in ogni
nostra epoca storica.
Un conservatore intelligente come
Leo Longanesi ripeteva che gli italiani, alle ristrutturazioni, preferiscono le
inaugurazioni.
Temo che questo vizio, presi dall’ansia
di apparire, stia infettando molti politici europei.
Abbiamo bisogno di un nuovo vaccino.


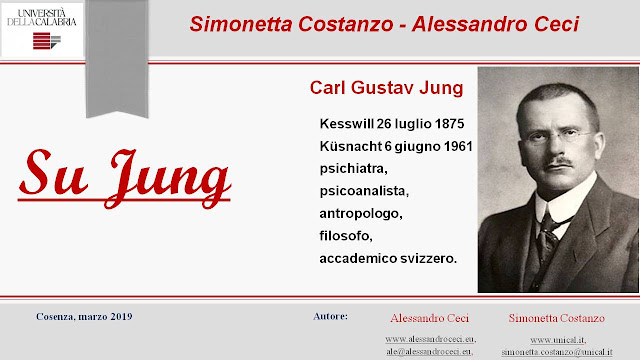
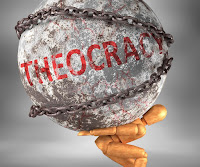

Commenti
Posta un commento