5 - Epistemica e Soteriologia dell'Arte Terapia - di Simone Saccomani
Introduzione
Fin
dall'inizio della vita l'uomo ha cercato di esprimersi in vari modi e anche
grazie al linguaggio artistico ha potuto comprendere meglio il mondo che lo
circondava. Solo gli esseri umani sono capaci di meravigliarsi davanti ad
un'opera d'arte e di rimanere estasiati nel contemplarla, privilegio che gli
animali che agiscono solo per istinto non possiedono. In questo senso l'arte è
il modo che ha l'essere umano di esprimere il materiale e l'immateriale
utilizzando la materia, l'immagine o il suono.
Questa
può essere considerata come un'attività specificamente umana, in cui
l'intenzione può essere posta sia sul fine estetico che sulla sua capacità
comunicativa, essendoci diversi modi di intendere, definire e creare l'arte.
Proprio
come il suono, la pittura, l'espressione corporea, tutte le manifestazioni
artistiche cercheranno e avranno l'inquietudine e il filo creativo di chi, cogliendo
ciò che percepisce, lo trasforma secondo la propria soggettività e la propria
capacità di immaginare forme diverse di creazione.
L’essere
umano è contraddistinto da una capacità unica in tutto il panorama delle specie
animali del pianeta, quella cioè di osservare la volta celeste. L’osservazione
dei fenomeni celesti, del sorgere e tramontare del sole e della luna, delle
periodiche configurazioni dei pianeti e del cielo stellato, possibile una volta
assunta la posizione eretta, diviene senza dubbio parte della vita di Homo
habilis e poi di Homo erectus, almeno un paio di milioni di anni fa.[1] Questa esperienza innesta
una significativa trama di significati, incluso il suo possibile progressivo
dialogo con l’affiorare della coscienza individuale nella specie umana, che
rappresenta un ruolo determinante nella percezione della trascendenza, di cui
il cielo è simbolo, aprendo successivamente la strada alla formulazione di un
pensiero religioso ove l’esperienza del sacro non resta catturata dalla
frammentazione e diversificazione delle forze naturali, ma si dirige con
decisione verso un’esperienza di carattere ontologico, entro cui trova spazio
il riferimento arcaico all’assoluto.[2] L’arte nella sua
dimensione iconologica e iconografica rappresenta uno strumento che favorisce
questa ricerca individuale e collettiva di trascendenza.
Arthur
Schopenhauer nel suo libro Il mondo come volontà di rappresentazione[3] sostiene che l'arte è un
modo per uscire dallo stato di infelicità dell'uomo, essendo la creazione
artistica una delle forme più profonde di conoscenza; è la riconciliazione tra
volontà e coscienza, tra oggetto e soggetto, raggiungendo uno stato di
contemplazione, di felicità.
Nel
corso della storia, l'uomo ha trovato nelle espressioni artistiche un modo per
trasmettere valori, stili di vita, la prospettiva di sé stesso e del suo
ambiente, trovando in queste manifestazioni metaforiche, estetiche e simboliche
un modo per raccontare il mondo, cos'è, cosa è stato, cosa ha vissuto e cosa
crede che sarà.[4]
A
questo proposito Jean Baudrillard, filosofo e sociologo francese, dirà:
“L’arte
può diventare una sorta di testimonianza sociologica, socio-storica o politica.
Diventa una funzione, una sorta di specchio di ciò che è realmente accaduto nel
mondo, di ciò che accadrà, comprese le iniziative virtuali, nelle quali forse
va ancora più in profondità nella verità del mondo e dell'oggetto”. [5]
Secondo
Cornelius Castoriadis l'arte rappresenta una modalità per dare forma al Caos. Nella
visione di tale autore, tutto è caos e ciò che gli individui faranno nel corso
della loro vita, sia attraverso le istituzioni che nella vita di tutti i
giorni, ne costituisce il modellamento che può essere mascherato o nascosto
attraverso un Cosmo che aiuterà l’individuo a sopravvivere. L'arte ci permette
di mostrare il Caos dandogli forma, ed è da questo plasmare che nasce il Cosmo.[6] Una consimile visione si
può rintracciare anche nella narrazione per immagini che si ritrova nella
Stanza della Segnatura per opera di Raffaello: l’esegesi che ne riporta
Marinacci dà infatti conto di una ricostruzione anagogica, nel testo pittorico
dell’Urbinate, che permette di riportare la proteiforme messa in scena dell’intero
ciclo a fresco disteso sulle quattro pareti, nella conoscenza del Bene supremo,
racchiuso nella mezza sfera della cupola.[7]
Per
Friedrich Hegel l'arte, lungi dall'essere un passatempo con viene decorata la
casa, o un'attività che si svolge solo per piacere, comprende uno scopo
metafisico e soteriologico, quello di mostrare agli uomini, grazie alla sfera della
sensibilità e della tangibilità, l'essenza del divino, anziché qualcosa di
puramente razionale e intelligibile.
Figura 1: Gianni Brusamolino – Le mani di Maddalena – 2011.
È
importante evidenziare che Hegel affermerà che tutto il reale è razionale e
tutto il razionale è reale, con ciò intende dire che tutta la realtà è
espressione di una ragione, che si costituisce attraverso quella realtà, cioè
tutto il reale è razionale perché tutto ciò che è reale è stato operato dalla
ragione dell'uomo; In questo modo, quando dice che l'arte manifesta l'essenza
del divino, non si riferisce a Dio ma piuttosto fa riferimento ad una dinamica
razionale e consapevole. L'opera d'arte funge, pertanto, da collegamento o
punto di mediazione tra l'umano e il divino. Il suo scopo è quello di rendere
manifesto nella sfera della sensibilità umana il dinamismo della razionalità
dell'universo.[8]
1. L’arte
della cura e la cura dell’arte
Rispondere
alla domanda se l’arte guarisce richiede dal punto di vista metodologico un
approccio che ne indaghi la dimensione epistemica. Il primo aspetto da
considerare è sapere cosa significa “guarigione”. L’arte non cura una ferita
fisica, né una malattia come l’epatite o il cancro. Non cura un colpo alla
testa, ma aiuta a guarire, nella dimensione soteriologica che le è propria, un
colpo all’anima. Se ci atteniamo ad un possibile approccio definitorio è
possibile sostenere che curare è far guarire emotivamente una persona che
soffre, o far sparire quella sofferenza. L'arte può aiutare una persona che
soffre a riprendersi emotivamente, così come può favorire la scomparsa di tale
sofferenza.
Nella
storia dell’arte terapia, diverse volte tale ambito in passato è stato motivo
di forte dubbio e di discussione tra le figure rappresentanti le professioni
delle relazioni d’aiuto, quali potessero essere i campi d’impiego in ambito
sanitario oltre che sociale di questa disciplina; tutto ciò è dovuto a una
mancanza di formazione ed esplorazione di questo mondo.
D’altro
canto, con l’evolversi delle evidenze scientifiche nella cornice europea, le
arti hanno assunto un ruolo significativo come strumento terapeutico ed
espressivo, poiché il loro valore va oltre lo scontato stereotipo di essere
solo considerate delle attività ludiche.[9]
Le
arti possono svolgere un ruolo preminente nella cura, esse vengono utilizzate
come espressione e comprensione delle emozioni, anche nelle fasi della
riabilitazione, nel trattamento di alcune patologie, nella promozione e nella
prevenzione della salute.
L’arte
di fatto dimostra di essere un vero e proprio strumento terapeutico,
integrativo, per il benessere degli individui che dovrebbe essere incluso
nell’assistenza sanitaria, pertanto, sarebbe necessario creare degli interventi
infermieristici incentrati sulla persona e l’espressione creativa.
L'arteterapia
è definita come l'uso di risorse ed elementi artistici per facilitare
l'espressione e la riflessione della persona che ne fruisce, in compagnia di un
arte-terapeuta qualificato.[10]
In
questo tipo di terapia, viene sempre data priorità al processo creativo
dell'individuo rispetto al valore estetico del prodotto finale o dell'opera a
cui si arriva. Si tratta di un dispositivo che unisce l'arte alla psicoterapia,
integrando principalmente i contributi della psicoanalisi, della psicologia
umanistica e della terapia.
Dare
parole al dolore, come emerge dal Macbeth di William Shakespeare, rappresenta
uno degli scopi principali dell’arte del curare.[11]
In
alcune circostanze, tuttavia, la parola rappresenta ancora una sponda lontana,
incapace di offrire tempestivamente un sostegno e non permette di riflettere e
dare pienamente senso e pensabilità all’esperienza umana.[12]
Nei
contesti sanitari l’arte terapia si pone il raggiungimento di diverse mete, principalmente
rappresentate dall’espressione delle proprie emozioni, dalla riabilitazione con
conseguente ottenimento di benefici fisici, dalla parte psicologica e dalla
narrazione.[13]
La
riabilitazione psicologica in arte terapia, nella sua dimensione epistemica,
assume più significati, può essere collegata al grande ramo delle malattie
psichiatriche dei traumi psicologici e dei traumi fisici.[14]
Attraverso
le varie forme di arte terapia e un percorso personalizzato per l’assistito, è
possibile far affiorare ciò che si cela nella profondità della persona, nella
massima espressione di se stessa.
La
parte psicologica tiene conto della visione cognitiva ed emotiva
dell’individuo, come ad esempio nei malati che si trovano a dover lottare
contro la malattia; l’arte terapia in questi casi può essere fonte d’aiuto
nell’espressione delle proprie emozioni, nell’accettazione della malattia,
nell’identificazione dei propri bisogni.[15]
Secondo
Marxen l’arteterapia si è sviluppata grazie a due fonti: la psicoterapia
psicoanalitica e l’educazione artistica. Tuttavia, è importante evidenziare
che, sulla base dei contributi di Margaret Naumberg e Edith Kramer, attualmente
include nella sua applicazione una molteplicità di schemi teorici.[16]
L'arteterapia
sia negli Stati Uniti che in Europa si è sviluppata sotto la protezione di
diversi paradigmi presi dalle teorie psicologiche e psicoanalitiche. Così ai
convegni incontriamo professionisti formati nelle scuole adattive, evolutive,
sistemiche e in diverse posizioni psicoanalitiche. L'Arteterapia, secondo l’Instituto
Universitario Nacional de Arte de Buenos Aires è definita come la
sistematizzazione dell'uso di media, tecniche e supporti delle arti visive con
obiettivi terapeutici.[17]
A
causa della molteplicità degli approcci teorici all'arteterapia, l'American Art
Therapy Association (AATA) descrive la professione, nominandone i compiti e le
basi della tecnica, facendo riferimento alle varie teorie che inquadrano la
prestazione del professionista.
L'arteterapia
è un'attività professionale che utilizza i mezzi di espressione artistica, le
immagini, il processo di creazione artistica e le risposte del paziente/cliente
ai prodotti creati, come riflessi dello sviluppo, delle capacità, della
personalità, degli interessi, delle preoccupazioni e dei conflitti
dell'individuo. La pratica dell'arteterapia si basa sulla conoscenza dello
sviluppo umano e sulle teorie psicologiche, che vengono applicate all'intera
gamma di modelli di valutazione e trattamento, inclusi quelli educativi,
psicodinamici, cognitivi e transpersonali, nonché altre risorse terapeutiche
per riconciliare i conflitti emotivi, promuovere la percezione di sé,
sviluppare abilità sociali, autoregolamentare il comportamento, risolvere
problemi, ridurre l'ansia, promuovere l'orientamento verso la realtà e
aumentare l'autostima.
L’arte
terapia rappresenta una modalità di intervento, ad orientamento psicodinamico,
che promuove l’utilizzo integrato di un codice espressivo verbale e pre-verbale
valorizzando gli strumenti tipici delle arti visive e performative.[18]
Le
espressioni artistiche, mediante la produzione grafica e pittorica o attraverso
il movimento corporeo rappresentano degli strumenti in grado di sviluppare le
capacità simboliche e linguistiche idonee a comunicare le esperienze interiori.
In
questo senso l’opera d’arte è simbolo non discorsivo che riesce ad articolare
ciò che risulta ineffabile in termini verbali, essa esprime consapevolezza
diretta, emozione, identità, la matrice mentale.[19]
I
processi ed i prodotti estetici, motori o grafici sono un alfabeto arcaico in
grado di offrire una speranza di vita anche alle parti più nascoste ed inascoltate
di sé consentendo di metterle in condizione di esprimersi, prestando loro un
suono e poi una lingua.[20]
L’esperienza
creativa è fin dall’inizio, o a seguito di “nuovi inizi” resi necessari da
accadimenti e vicissitudini collegate al disagio psichico, un medium che
favorisce una forma di dialogo.[21]
Secondo
la psicanalista Melanie Klein quando il dolore è così intenso da non avere più
accesso alla coscienza, quando i pensieri sono così dispersi da non essere più
comprensibili ai propri simili, quando i contatti più vitali con il mondo sono
recisi, neppure allora lo spirito dell’uomo soccombe e il desiderio di creare
può persistere. [22]
2. Alcune
applicazioni pratiche dell’arte terapia.
Vincent
Van Gogh nell’aprile 1889 venne ricoverato nell’ospedale psichiatrico di
Saint-Rémy. Il dottor Gachet che lo ebbe in cura acconsentì che continuasse a
dipingere.
Paul
Gachet era un medico psichiatra, amante dell'arte: incontrò Vincent van Gogh
tramite il fratello di lui Theo e immediatamente i due si trovarono in sintonia
nell'analoga visione dell'arte. Il dottore si rese disponibile a posare per
Vincent, che da tanto tempo cercava un modello da ritrarre dal vero.
Specializzato
in psichiatria, il medico fece del proprio meglio per aiutare Vincent a
sconfiggere le proprie angosce offrendogli un conforto materiale in grado di
favorire distensione e serenità.
Il
ritratto del dottore rientra in questa fase creativa particolarmente intensa.
Modello privilegiato, Gauchet è caratterizzato da un atteggiamento malinconico,
che riflette "l'espressione sconsolata dei nostri tempi", come
scriverà Van Gogh.
Il
solo elemento di speranza in questo ritratto severo dalle tonalità fredde, il
fiore di digitale che, per le sue virtù curative, assicura un po'di conforto e
di serenità.
Malgrado
la sua abnegazione ed il suo attaccamento nei confronti dell'artista, il dottor
Gachet non potrà fare nulla per impedire il gesto irreparabile di Van Gogh che,
di lì a poco, si sarebbe tolto la vita.
Figura 2: Vincent Van Gogh – Le Docteur Paul Gachet – 1890.
Vincent
Van Gogh dipinse il mondo che per lui era accessibile: i fiori e gli alberi del
giardino con pennellate vivaci che rendono l’idea di movimento.
La
tavolozza che impiegò era generalmente composta da tinte più morbide, più
smorzate di quelle adoperate nei dipinti realizzati ad Arles.[23]
Figura 3: Vincent Van Gogh - Iris - 1889.
Figura 4: Vincent Van Gogh – Il giardino dell’ospedale a Saint Rémy – 1889.
I
vissuti traumatici legati all’esperienza del ricovero, rimossi dalla produzione
estetica immediata, riemergono, però a distanza in modo indiretto e non
catartico nell’opera La ronda dei carcerati.
Figura 5: Vincent Van Gogh, La ronda dei carcerati – 1890.
La scena si ambienta in una «fossa dei serpenti» dalla forma poligonale, dalle pareti che estendendosi minacciosamente verso l'alto precludono l'orizzonte allo sguardo, il quale vorrebbe andare oltre questo cortile claustrofobico e opprimente. Ogni velleità di speranza è funestamente rovinata, anche per via delle grandi pietre della pavimentazione che, riflettendo ulteriormente l'irreale luce azzurra che inonda la scena, la cala in un'atmosfera asfissiante e allucinata.
Il
senso di chiusura che scaturisce da questa visione viene esasperato dai
prigionieri che, fuoriusciti dalle celle per l'ora d'aria, sembrano ruotare
senza fine, con il loro incedere apatico, affaticato e ripetitivo.[24]
Van
Gogh, in questo modo, racconta la sua tragedia di artista esiliato dalla
società, incompreso, disadattato, nonostante il suo struggente desiderio di
amare il prossimo. Ma in tutta questa tristezza permane un anelito di speranza.
Due piccole farfalle, in alto, aleggiano vicine sulla parete: con le loro ali
fragili e bianche possono superare ostacoli insormontabili per gli esseri umani
e ricercare felicità infinite.
Il
prigioniero che sta in primo piano, l’unico senza berretto e con i capelli
fulvi, si rivolge allo spettatore. Quest’uomo lascia cadere stancamente le
braccia a penzoloni, senza tenerle dietro la schiena o in tasca come gli altri.
Secondo alcuni interpreti sarebbe riconoscibile un autoritratto di Van Gogh.
Certo, l’immagine dovette essere per il pittore una sorta di immagine
ossessiva. I carcerati sono trentasette, un numero che ricorre con una
frequenza nefasta nella vita di Vincent, che a trentasette anni si suicida.
La
storia di Carlo Zinelli, ricoverato nel manicomio di Verona, era destinata ad
essere invisibile in vita e dimenticata dopo la morte. Nel 1955 in uno dei
giorni della degenza, raccolse in giardino un sasso appuntito e, avvicinatosi
ad una parete iniziò a tracciare un graffito, fino a quando un infermiere non
lo immobilizzò per impedire che continuasse ad imbrattare quella
superficie. Il paziente ci riprovò
nuovamente, servendosi in questo secondo caso di un pezzo di legno, e riuscì a
rappresentare una scena strana e misteriosa.[25]
Figura 6: Carlo Zinelli – Forma con orologio e contorni neri, 1964.
Il medico del reparto interpretò quel gesto come un bisogno di esprimersi graficamente e decise di mettergli a disposizione delle matite e dei fogli di carta. Carlo Zinelli era affetto da schizofrenia e, a seguito della sua emarginazione dal mondo, dagli affetti e più in generale da una rete di relazioni sociali, le sue capacità di linguaggio era fortemente regredita. La sua patologia si era manifestata attorno all’età die 20 anni ed aveva determinato il suo ingresso nella struttura psichiatrica nel 1941, e la sua permanenza durò alcuni anni, per poi morire nel 1974. Zinelli grazie a quelle matite e a quei fogli di carta ha iniziato una narrazione capace di coinvolgere gli psichiatri che intravvedevano in quelle forme e colori i segni dello squilibrio mentale del paziente, ma al contempo anche quello di artisti ed esperti di arte che vi riconoscevano forme di espressione poetica e di figurazione pittorica.[26]
Carlo
Zinelli, chiamato comunemente Carlo (1916-1974), attualmente è considerato una
delle figure di riferimento dell’Art Brut al pari di Aloïse Corbaz, André
Robillarde Adolf Wölfli.
Figura 7: Carlo Zinelli – Senza titolo - 1960
Un paziente di cui si riportano solo le iniziali (A.G.) in occasione di un ricovero ospedaliero per un disturbo psicotico acuto, disegnò una mappa dell’Europa con il suo volto, scomposto e ricomposto nella maniera cubista, collocato al centro tra un profilo geografico dell’Italia, sua terra natia, ed un profilo antropomorfo ma inquietante della Germania rappresentata con elmetto militare e numerose croci, retaggio di tante guerre.
Il profilo estetico è capace di rappresentare, oltre alla memoria di conflitti reali, anche la dinamica di una contrapposizione tra gli elementi interiori della personalità, in alternativa alla estenuante reiterazione psicotica. [27] In un’ottica psicoanalitica la ripetizione di un evento psichico costituisca un
modo
per raggiungere e per mantenere il controllo su di esso, come nel caso della
riproposizione di
esperienze
traumatiche. L’opera di Carlo viene spesso associata, nel linguaggio “dell’arte
psicopatologica”, alle stereotipie, o piuttosto, in certe ipotesi
interpretative, ad una lettura in chiave esclusivamente musicale: un’ipotesi,
questa, che ha sollevato le critiche di autori come Sergio Marinelli, che ha
parlato di “forzature unilaterali di precedenti e più caute letture, che pure
parlavano di filastrocche, canzoni, suggestioni di musicalità”.[28] Uno sguardo già diverso
permette, invece, di leggerne la natura polisemica, individuando nel rapporto
con l’oggetto la sua specifica natura affettiva e percettiva. E tuttavia
l’iterazione, come sostiene Giorgio Bedoni a proposito della comunicazione
nella schizofrenia nella sua apparente, immutata continuità, può assumere caratteri
evolutivi, producendo così una differenza: certe forme ripetute, le più
enigmatiche, come l’opera di Carlo insegna, possono assumere una luce nuova nel
corso del tempo e divenire immagini preminenti, altamente significative per chi
le produce perché possono determinare uno scarto, una selezione nella serialità.[29]
Figura 8: A.G. Volto ed Europa
La riflessione del paziente/artista su un altro suo prodotto estetico realizzato durante la degenza apre una finestra sulla materia della mente, e, al contempo, delinea una traiettoria epistemica, necessaria e possibile della relazione terapeutica: “sulla destra c’è il pittore, sono io con il cappello e quello non è un bastone è il pennello. Al centro c’è una grotta con dentro un fantasma che va a zig zag tra le cose vive (gli alberelli) e le cose morte (il numero 1382); il fantasma l’ho colorato di giallo, ma non lo si può vedere e non lo si può acchiappare, perché dentro la grotta c’è buio; ad un certo punto il fantasma si spiaccica sulla parete della grotta e così lo possiamo riconoscere.”
Sulla
parete sinistra della grotta si poteva osservare una composizione di tipo
astratto che per le forme ed i colori utilizzati ricordava la poetica di Mirò.
Il paziente aveva frequentato solo le scuole elementari e non poteva conoscere
il “mito della caverna” di Platone, né l’arte contemporanea, ma nella sua
produzione erano comunque ravvisabili delle testimonianze di questi retaggi
filosofici ed artistici e la riflessione su tale produzione raffigurativa
poteva comunque attingere a tali risorse simboliche e archetipiche.
Nella
sua dimensione narrativa il paziente rappresenta la sua storia con queste
parole: “l’ombra della solitudine. Il cavaliere innominato era il protettore
della foresta, un giorno si allontanò per andare a cercare un mostro che era la
solitudine… di questo cavaliere non si conoscono le origini, e quindi non aveva
identità. Si sa soltanto che l’ombra della solitudine aveva distrutto la sua
casa e si era impadronita di tutto. Mentre lui era lontano per cercare questo
nemico, la solitudine si impadronì anche della foresta e diede fuoco a tutto.
L’eroe innominato arrivò nella casa della solitudine e non trovò nessuno, era
tutto disabitato. Allora decise di tornare indietro e sulla via incontrò gli
abitanti della foresta che fuggivano a causa del rogo. Corse verso il nemico e
l’aggredì alle spalle ma l’ombra lo gettò a terra sconfitto, allora
l’innominato tornò all’attacco e vinse stavolta lui. L’ombra dentro tornò al
corpo e l’innominato gli chiese che cosa sapesse della sua storia e perché
aveva rovinato tutto. La solitudine non rispose perché era troppo stanca per il
combattimento ma, appena vide tornare indietro gli abitanti della foresta, capì
che in fondo avrebbe voluto farsi degli amici e forse faceva del male perché
era troppo sola!”.[30]
Figura 9: A.G. Fantasma nella grotta
Ma tali formule archetipiche del sacro non sono presenti solo in epoca contemporanea, bensì si possono rintracciare in ogni epoca in cui l’uomo si è misurato con la dimensione artistica; all’inizio della modernità ad esempio un pittore come Giotto ha rappresentato in immagini esattamente le stesse formule letterarie che ritroviamo nel testo del suo più noto contemporaneo: Dante. I significanti, pur se espressi in due linguaggi all’apparenza disomogenei e inconciliabili, quando rilevati nelle loro valenze iconiche, mettono in evidenza una identica provenienza auratica, un linguaggio che alla luce dell’analisi iconografica viene immediatamente ricondotto nell’alveo della rappresentazione del sacro.[31]
La
produzione di immagini può essere utile per favorire una forma espressiva
alternativa a quella dialogica, che in alcuni soggetti può risultare difficile,
sospesa, frammentata se non del tutto interrotta e spezzata. La ricchezza, la
complessità e l’intensità dei codici espressivi non verbali è in grado di
favorire l’accesso, nella sua funzione trasformativa, della dimensione del
significante a quella dei possibili significati che rimandano comunque ad una
prospettiva relazionale.
Nell’arte
terapia si attivano processi e stili comunicativi connessi con i potenziali
creativi primari e si tessono forme e modalità variegate di dialogo tra il
mondo interno del paziente e del terapeuta.
Il
contatto con il paziente e la sua creatività artistica favorisce una maggiore e
più profonda comprensione, consente di interpretare tale complessità nelle sue
molteplici implicazioni e supportare il processo di terapia psicologica e di
sostegno del soggetto.
Capire
l’interdipendenza che sussiste tra processo creativo e terapia permette lo
svolgimento di un lavoro grazie agli strumenti messi a disposizione degli
operatori dalla dimensione grafica, motoria ed estetica dell’arte. Ciò
rappresenta uno dei principali strumenti di analisi e di intervento dell’arte
terapia.[32]
In
questa ottica la relazione terapeutica oltre ad essere analizzata nelle
dimensioni del transfert e del contro-transfert, viene
identificata nella forma, nel contenuto e nel processo dell’espressione
artistica e performativa.
Secondo
Gaetano Benedetti l’attività espressiva può assurgere alla piena espressione
della psicoterapia, in quanto il paziente ed il terapeuta hanno la possibilità
di esprimere grazie alle immagini e alle espressioni gestuali alcune delle fasi
del comune percorso del processo interiore.[33]
Grazie
al raffinarsi dell’esperienza clinica e all’ampliamento dei settori applicativi
è stata effettuata una sistematizzazione a livello teorico-metodologico
integrando la strumentazione specifica dell’arte terapia e della
danza-movimento terapia con le competenze e le responsabilità della presa in
carico dello psicoterapeuta.[34]
In
questa prospettiva l’atto del creare un’immagine o una danza non rappresenta un
allontanamento da un ruolo terapeutico standard né un attacco al processo
conoscitivo e al setting che lo sostiene, ma è una parte integrante del
processo assistenziale del paziente. Attraverso tale lavoro i vissuti profondi,
pur rimanendo inizialmente lontani dall’essere consapevoli, si esprimono
nell’atto creativo stesso, trovando in alternativo al sintomo un autonomo campo
di elaborazione. La produzione estetica in termini di segno grafico o motorio
permette l’articolazione di rinnovate direttrici di interazione facendo sì che
il paziente possa progressivamente imparare a riconoscersi e rispecchiare nella
creazione artistica difficoltà, difese inconsce, fantasie o bisogni.
La
compresenza di una pluralità di dimensioni comunicative permette al terapeuta
di procedere a più livelli in quanto la presenza dell’oggetto artistico viene
iscritta in un contesto di significazione simbolica.[35]
La
capacità “curativa” dell’arte può essere analizzata sotto il profilo epistemico
attraverso tre livelli: soggettivo, cognitivo e psicologico. A livello
soggettivo, l'arte ci permette di esprimerci e comunicare oltre le parole.
L'arte
permette di entrare in comunione con gli altri e con noi stessi, inoltre
permette agli individui di riconnettersi con il proprio essere creativo. Il
livello cognitivo, aspetto che approfondisce la psicologia dell'arte, si
riferisce al processo creativo come forma di conoscenza. Il livello psicologico
si riferisce alla possibilità che offre l'arte di abitare il delicato
territorio tra l'interno e l'esterno, ci consente stati transitori in cui
possiamo connetterci con il nostro vero sé. Sono rilevanti anche le intuizioni
di Freud quando visualizzò nell'arte una modalità di espressione
dell'inconscio, una forma sostitutiva destinata a soddisfare desideri repressi.
Altrettanto interessanti sono gli apporti di Melanie Klein che vedeva nelle
espressioni artistiche non solo un cambiamento della meta delle pulsioni ma
anche una riparazione della struttura mentale. È altresì opportuno rimarcare un
aspetto elaborato da Carl Gustav Jung che è andato oltre la coscienza
individuale per esprimere la tesi secondo cui l'arte è una manifestazione
dell'inconscio collettivo, la creazione implica il potere dell'archetipo che
fornisce al creatore una forza vivificante di grande intensità.
In
questo modo, la forza della maggior parte delle terapie che lavorano con le
risorse espressive sta nel fatto che, lavorando con le immagini interne, dando
la possibilità di espressione non verbale, generano un campo di trasformazione
e cambiamento, poiché lavorano direttamente con il coinvolgimento del corpo,
delle emozioni, della storia, dell'inconscio e dei processi cognitivi.[36] Un altro aspetto
importante è che, sia se affrontata metodologicamente individualmente che in
gruppo, la dimensione relazionale è implicita nello spazio di lavoro, poiché
viene introdotto il repertorio di legami delle persone.
Conclusioni
Le
espressioni artistiche fanno parte della storia dello sviluppo dell'essere
umano e in questo senso sono d'accordo con René Huyghe che sostiene che arte e
uomo sono inseparabili, non c'è arte senza uomo e forse non c'è uomo senza arte.
Tuttavia, è necessario evidenziare che non è cambiato solo il modo in cui gli
esseri umani hanno scelto di sviluppare queste espressioni, ma anche il
paradigma viene utilizzato e la chiave di lettura epistemica per definire
l’arte, soprattutto nel contesto della postmodernità fortemente impattata dalle
nuove tecnologie.[37]
Storicamente
si tende a limitare l’arte alla sua funzione estetica, tratto fondato fin dalle
origini della sua creazione, ma non possiamo dimenticare che deve assolvere a
molte altre funzioni, di tipo comunicativo, ideologico, cognitivo,
trasformativo.
L’utilizzo
dei mezzi espressivi da parte delle diverse discipline della psicologia è lungi
dall’essere una risorsa di miglioramento in termini di sviluppo delle tecniche,
l’intenzione non sarà quella di generare “artisti”, questo costituisce uno
degli aspetti più importanti che differiscono da insegnamento artistico. Nella
pratica psicologica la creatività è assunta come veicolo espressivo che
permette all'immaginazione di svilupparsi, aumentare l'autostima e potenziare i
sentimenti di autonomia. Lavorando con tecniche espressive si apre uno spazio
per la creazione, per trovare nuovi modi per esprimere ciò che non può ancora
essere espresso a parole. È da qui che sorge il quesito se l’arte sia in grado
di avere una dimensione soteriologica e terapeutica.[38]
L'esperienza
estetica ci collega alla vita e ci porta a una delle esperienze più complete
perché ci unisce al mondo da prismi diversi.[39] L'arte, in sintesi, nella
sua dimensione soteriologica è un'espressione culturale di individui, donne e
uomini di qualsiasi origine sociale o geografica, e costituisce una risposta
alla relazione emotiva e cognitiva con il mondo e con sé stessi, attraverso una
negoziazione e organizzazione dell'inconscio, un'organizzazione formale,
percettiva e cognitiva, che permette loro di comprendere e comprendere se
stessi, in un processo di interiorizzazione ed esteriorizzazione.[40] Ciò fornisce un
potenziale incredibile agli esseri umani e quindi l’arte è estremamente
importante nel loro sviluppo integrale. L'arte ha la capacità di organizzare in
una nuova armonia ciò che rimane destabilizzato nella psiche umana. L’arte non
ci priva della sofferenza, ma ci aiuta a immaginare altri mondi, accettando
quello in cui abitiamo e proiettandoci verso un altro possibile.
A
tal proposito sono illuminanti le tesi di Vasilij V. Kandinsky, riportate nella
sua opera “Lo spirituale nell'arte”, dove l’artista russo naturalizzato
francese sviluppa il suo desiderio di un'evoluzione spirituale nella pittura e
per estensione in tutte le arti. Dell'arte, in particolare dice: “Tutte queste
forme artistiche hanno veramente uno scopo e sono, (…) un nutrimento per lo
spirito (…) poiché lo spettatore trova un legame con la propria anima.
Logicamente, questo legame (o risonanza) non rimane superficiale: lo stato
d'animo dell'opera può approfondirsi e cambiare lo stato d'animo dello
spettatore. In tutti i casi, queste opere non ammettono la bassezza dell'anima
e la sostengono in un certo tono, come un diapason sostiene le corde di uno
strumento. Ma anche così, l’estensione e l’azione purificatrice di questo tono
sono unilaterali nel tempo e nello spazio e non esauriscono tutta la potenza
possibile dell’arte”.[41]
V. V. Kandinsky – Lo spirituale nell’arte. 1910.
Secondo
Kandinskij, infatti, l’arte deve rispondere ad una necessità interiore, ovvero
essere intimamente necessaria. In questo senso, in pittura, piuttosto che
servirsi di forme materiali per rappresentare fisicamente la natura,
bisognerebbe considerare la forma e il colore come energie interiori, energie
psichiche che trascendono il mondo materiale e parlano all’interiorità, ovvero
allo spirituale.
L’ambizioso
progetto di ideare una teoria dell’armonia in pittura analogamente a quella che
è la teoria dell’armonia in musica. La musica, a differenza della pittura
rappresentativa, non si serve infatti di forme esteriori che rappresentano la
realtà, ma esclusivamente di forme interiori, sue proprie, che esprimono il
sentimento dell’artista in maniera astratta. In questo senso si può capire
perché per Kandinskij la musica sia molto più vicina allo spirituale di quanto
non lo fosse la pittura nel 1910, anno in cui il saggio è stato scritto.
Kandinskij
invita a guardare nell’interiorità come sede della necessità interiore e dello
spirituale in ottica terapeutica e soteriologica. Chi apprezza l’arte o si
dedica ad essa potrà trovare nella sua arte un valido elemento integratore
della religione professata.
Secondo
Mircea Eliade “il sacro è un elemento della struttura della coscienza e non
un momento della storia della coscienza”.[42] Lo storico delle
religioni pone in rilievo la dimensione di alterità collegata all’esperienza
del sacro, sia perché espressiva del rapporto dell’uomo con la realtà del mondo
che lo circonda, sia perché del sacro l’uomo “soffre” le manifestazioni, le
ierofanie, che può concettualizzare grazie a forme di pensiero simbolico. L’homo
religiosus crede che esista una realtà assoluta, il sacro, che trascende
questo mondo, ma si rende presente in esso proprio mediante ierofanie e,
attraverso di queste, santifica il mondo e lo rende reale agli occhi dell’uomo.[43]
Grazie
a ciò, sostiene Eliade, “l’esperienza del sacro è indissolubilmente legata
allo sforzo fatto dall’uomo per costruire un mondo che abbia un senso”. [44]
L’arte
non cessa di parlare all’interiorità libera e priva di dogmi e pregiudizi
dell’artista, proprio perché, come Kandinskij ci ricorda, la vera sede
dell’umano è lo spirituale e non il materiale. Inoltre, i disagi psicologici
accentuati anche dalla recente pandemia del Covid-19 possono trovare un’utile
catarsi nella dimensione artistica, capace di portare o riportare senso e
significato in situazioni esistenziali in alcuni casi molto difficili e
caratterizzate da forte disagio.
V. V. Kandinsky - La spiritualità nell’arte – 1910.
L’arte terapia e gli approcci creativi possono essere applicati a un’ampia varietà di ambiti ottenendo ottimi risultati nel campo della salute.
L’espressione
creativa migliora in modo efficace la dimensione fisica e psichica della persona,
unendo mente e corpo, apportando diversi vantaggi per l’arte terapeuta e nell’assistenza
sociosanitaria.
L’arte
terapia ha dimostrato esiti positivi nell’atto creativo ed espressivo e
sull’andamento emotivo, cognitivo e fisico degli individui.
L’individuo
ha la possibilità di “raccontarsi” attraverso l’arte e di condividere la
propria esperienza di malattia tramite un linguaggio comunicativo alternativo
dato dal colore, dalle linee, dai movimenti, dalle parole, e dalle narrazioni, ed
in questo contesto gli operatori risultano facilitatori poiché possono
integrare e prediligere interventi artistici sul paziente.
Gli
arte-terapeuti possono avvalersi dell’apporto di materiale artistico, quali immagini,
nastri musicali, dipinti e possono invitare il malato a personalizzare la
stanza di degenza con le proprie opere d’arte.[45] L’arte terapia è
risultata inoltre efficace nella riduzione delle degenze ospedaliere, nelle patologie
acute e croniche, nella riduzione del dolore e come terapia alternativa a
quella tradizionale.
Il
Presidente del National Endowment for the Arts, Dr. Jane Chu, sostiene
che: “il connubio tra arte e assistenza sanitaria è un esempio naturale di
come la creatività si colleghi [..] alla scienza della medicina, per migliorare
la salute e il benessere [..]”[46]
Bibliografia
Armiraglio
F., Van Gogh,
collana I Classici dell'Arte, vol. 2, Rizzoli, Segrate 2003.
Ancora L., Pre simbolico e simbolico, in L. Ancora, E. De Rosa, C. Fischetti (a
cura di), La vergine del latte, Cosmopoli, Bologna, 1995.
Alessi
A., Sui sentieri
del sacro, LAS, Roma 1998.
Arieti S., La sintesi in magia, Il Pensiero
Scientifico, Roma, 1974.
Baudrillard J., El complot del arte. Ilusión y desilusión estética. Amorrortu,
Buenos Aires, 2006.
Bedoni R., La forma e lo sguardo: Polisemia
dell’immagine in arte terapia, Carlo Zinelli e i mondi visionari, in Ar-tè.
Quaderni italiani delle arte terapie, 2, 2007, pp.48-55.
Benedetti G., Segno, simbolo, linguaggio,
Bollati Boringhieri, Torino, 1971.
Benedetto A., Prima della parola l’ostacolo
psicanalitico del non detto attraverso le forme dell’arte, Franco Angeli,
Milano, 2006.
Bettelheim
B., Art as a personal vision. in: G. D. Stoddard, I Edman, B. Bettelheim, Art,
The Museum of Modern Art, New York, 1964 pp. 41-64.
Boccalon R., Arte e Arti terapie, in I quaderni
di Psico Art, 2, 2012, pp.1-19.
Boccalon R., “Imago e psiche” Processi creativi e
terapie espressive,
in Psico Art, 2, 2012, pp.1-29.
Castoriadis C., Ventana al Caos, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008.
Caterina R., Che cosa sono le arti-terapie. Carocci, Roma, 2005.
Edelman G. M., Sulla materia della mente,
Adelphi Milano, 1993.
Eliade
M., Giornale,
a cura di L. Aurigemma, Boringhieri, Torino 1976.
Facchini
F., Magnani P. (edd.), Miti e
riti della preistoria. Un secolo di studi sull'origine del senso del sacro:
fonti scelte, Jaca Book, Milano 2000.
Fancourt D., Finn S., Quali sono le evidenze sul
ruolo delle arti nel miglioramento della salute e del benessere? Una
scoping review, Dors Regione Piemonte Centro di Documentazione per la
Promozione della salute, Torino, 2020.
Ehrenzweig
H., The Hidden Order of Art, University of
California Press, Los Angeles, 1971.
Hernández Merino A., Las hebras para hilvanar la vida: el dibujo del dolor, in Arteterapia,
1, 2006, pp. 79-96.
Instituto Universitario Nacional
de Arte La utilización de medios visuales con objetivos
terapéuticos. www.iuna.edu.ar
Kim K. S., Lor M., Art Making
as a Health Intervention: Concept Analysis and Implications for Nursing
Interventions, in ANS. Advances in nursing science, 45(2), 2022, pp.155–169.
Klein M., Scritti 1921-1958, Boringhieri,
Torino, 1977.
Laban
R., The Mastery of Movement, Macdonald &
Evans, London, 1960.
Lane M. R., Creativity and spirituality in nursing:
Implementing art in healing, in Holistic nursing practice, 19(3),
2005, pp. 122–125.
Lane
M. R., Arts in Health care: A new paradigm for holistic
nursing practice, in Journal of Holistic Nursing: Official journal of
the American Holistic Nurses’ Association, 24(1), 2006, pp.70–75.
Langer K., Filosofia in una nuova chiave: uno
studio sul simbolismo della religione, dei riti e dell’arte, Armando, Roma,
1980.
Marinacci M., Giotto, il ciclo dell’anima. Il
polittico Stefaneschi,
Marietti, Genova, 2009.
Marinacci M., Raffaello e la biblioteca di Giulio
II. Un’esegesi della Stanza della Segnatura, Marietti, Genova, 2010.
Marinelli S., Carlo, dentro e fuori della storia,
in Carlo Zinelli, “Catalogo generale”, (a cura di V. Andreoli e S. Marinelli), Marsilio,
Venezia, 2000.
Marxen, E., Diálogos entre arte y terapia. Gedisa, Barcelona, 2011.
Mayos Solona G., Hegel: Vida, pensamiento y obra. Planeta,
Barcelona, 2006.
Ricci P. E., Regolazione delle emozioni e arti
terapie, Carrocci, Roma, 1998.
Ruddy R., Milnes D., Arteterapia para la esquizofrenia o las enfermedades similares a la
esquizofrenia. La biblioteca Cochrane Plus,Oxford 2008.
Saccomani S., Arte, ciberespacio y nuevos medios en la postmodernidad, in Medium
e medialità, 2-2022, pp.52-66.
Saccomani S. La metáfora del espejo en la mitología griega y en la tradición
judeocristiana,in Medium e medialità, 1/2023, pp.8-28.
Schloss J., Murray M.
(edd.), The Believing Primate. Scientific, Philosophical, and
Theological Reflections on the Origin of Religion, Oxford University Press,
Oxford 2009.
Schopenhauer A., El mundo como voluntad y representación: Parte 1, Trotta, Madrid,
2005.
Shakespeare
W., Macbeth, in Id. Tutte le Opere, Sansoni,
Firenze, 1964.
Tanzella-Nitti
G., Religione e
Rivelazione, Città Nuova, Roma 2018
Kadinsky
V. V., Lo espiritual en el
arte. Premia, Mexico 1989.
Zanzi A., Carlo Zinelli recto verso, Ed.
Amici, Losanna, 2003.
[1] Un interessante status
quaestionis delle risonanze interdisciplinari suscitate da questa
tematica è quello descritto da J.
Schloss, M. Murray (edd.), The Believing Primate. Scientific, Philosophical,
and Theological Reflections on the Origin of Religion, Oxford University Press,
Oxford 2009. Per un approfondimento
si segnala anche F. Facchini, P. Magnani (edd.), Miti
e riti della preistoria. Un secolo di studi sull'origine del senso del sacro:
fonti scelte, Jaca Book, Milano 2000.
[2] A. Alessi, Sui
sentieri del sacro, LAS, Roma 1998, p.90.
[3] A. Schopenhauer, El
mundo como voluntad y representación: Parte 1, Trotta, Madrid, 2005.
[4] S.
Saccomani La metáfora del espejo en la mitología griega
y en la tradición judeocristiana,in Medium e medialità, 1/2023,
pp.8-28.
[5] J. Baudrillard, El
complot del arte. Ilusión y desilusión estética. Amorrortu, Buenos Aires,
2006, p.91.
[6] C. Castoriadis, Ventana
al Caos, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008.
[7] M.
Marinacci, Raffaello e la biblioteca di Giulio II. Un’esegesi della
Stanza della Segnatura, Marietti, Genova, 2010.
[8] G. Mayos Solona,
Hegel: Vida, pensamiento y obra. Planeta, Barcelona, 2006.
[9] R.
Caterina,
Che cosa sono le arti-terapie. Carocci, Roma, 2005, pp.10-26.
[10] R. Ruddy, D. Milnes, Arteterapia para la esquizofrenia o las enfermedades similares a
la esquizofrenia. La Bibliotheca Cochrane Plus, Oxford 2008, p.2.
[11] W. Shakespeare, Macbeth, in Id. Tutte le Opere, Sansoni, Firenze, 1964.
[12] L.
Ancora, Pre simbolico e simbolico, in L. Ancora, E. De Rosa, C. Fischetti (a cura di), La
vergine del latte, Cosmopoli, Bologna, 1995.
[13] M. R. Lane, Creativity
and spirituality in nursing: Implementing art in healing, in Holistic
nursing practice, 19(3), 2005, pp. 122–125.
[14] M. R. Lane, Arts
in Health care: A new paradigm for holistic nursing practice, in Journal
of Holistic Nursing: Official journal of the American Holistic Nurses’
Association, 24(1), 2006, pp.70–75.
[15] R. Caterina, Che cosa sono le arti-terapie,
cit. pp.41-55.
[16] E. Marxen, Diálogos
entre arte y terapia. Gedisa, Barcelona, 2011.
[17] Instituto Universitario Nacional de
Arte La utilización de medios visuales con objetivos
terapéuticos. www.iuna.edu.ar
[18] G.
M. Edelman, Sulla materia della mente, Adelphi Milano, 1993.
[19] S.
K. Langer, Filosofia in una nuova chiave: uno studio sul simbolismo
della religione, dei riti e dell’arte, Armando, Roma, 1980.
[20] A.
Benedetto, Prima della parola l’ostacolo psicanalitico del non detto
attraverso le forme dell’arte, Franco Angeli, Milano, 2006.
[21] S.
Arieti, La sintesi in magia, Il Pensiero Scientifico, Roma, 1974.
[22] M.
Klein, Scritti 1921-1958, Boringhieri, Torino, 1977.
[23] R.
Boccalon, Arte e Arti terapie, in I quaderni di Psico Art,
2, 2012, pp.1-19.
[24] F. Armiraglio, Van
Gogh, collana I Classici dell'Arte, vol. 2, Rizzoli,
Segrate 2003, p. 150
[25] R. Boccalon, Arte e Arti terapie, in I quaderni di Psico Art,
cit. p.5.
[26] Per un approfondimento sulla
poetica di Carlo Zinelli si rimanda a: A.
Zanzi, Carlo Zinelli recto verso, Ed. Amici, Losanna, 2003.
[27] R. Boccalon, Arte e Arti terapie, in I quaderni di Psico Art,
cit. p.7.
[28] S.
Marinelli, Carlo, dentro e fuori della storia, in Carlo
Zinelli, “Catalogo generale”, (a cura di V.
Andreoli e S. Marinelli), Marsilio, Venezia, 2000.
[29] R.
Bedoni, La forma e lo sguardo: Polisemia dell’immagine in arte
terapia, Carlo Zinelli e i mondi visionari, in Ar-tè. Quaderni italiani
delle arte terapie, 2, 2007, pp.48-55.
[30] R.
Boccalon, Arte e Arti terapie, in I quaderni di Psico Art,
cit. pp.8-9.
[31] M.
Marinacci, Giotto, il ciclo dell’anima. Il polittico Stefaneschi,
Marietti, Genova, 2009.
[32] H. Ehrenzweig, The Hidden Order of Art, University of California Press,
Los Angeles, 1971.
[33] Per un approfondimento su questa
tematica si rimanda a: G. Benedetti,
Segno, simbolo, linguaggio, Bollati Boringhieri, Torino, 1971.
[34] R. Laban, The
Mastery of Movement, Macdonald & Evans, London, 1960.
[35] R.
Boccalon, “Imago e psiche” Processi creativi e terapie espressive,
in Psico Art, 2, 2012, pp.1-29.
[36] P.
E. Ricci, Regolazione delle emozioni e arti terapie, Carrocci,
Roma, 1998.
[37] S. Saccomani, Arte,
ciberespacio y nuevos medios en la postmodernidad, in Medium e
medialità, 2-2022, pp.52-66.
[38] R.
Boccalon, Dall'agire al pensare: esperienze creative e percorsi
psicoterapeutici, in Ar-Tè, Quaderni Italiani delle Artiterapie, n. 2,
2007
[39] B. Bettelheim, Art as a personal vision. in: G. D. Stoddard, I Edman, B. Bettelheim, Art, The
Museum of Modern Art, New York, 1964 pp. 41-64.
[40] A. Hernández Merino, Las hebras para hilvanar la vida: el dibujo del dolor, in Arteterapia,
1, 2006, pp. 79-96.
[41] V. V. Kandinsky, Lo espiritual en el arte. Premia,
Mexico 1989, p.10
[42] M. Eliade, Giornale,
a cura di L. Aurigemma, Boringhieri, Torino 1976, p.420.
[43] G. Tanzella-Nitti, Religione
e Rivelazione, Città Nuova, Roma 2018, pp. 40-50.
[44] M. Eliade, Giornale,
cit. pp.420-421.
[45] D.
Fancourt, S. Finn, Quali sono le evidenze sul ruolo delle arti nel miglioramento
della salute e del benessere? Una scoping review, Dors Regione Piemonte
Centro di Documentazione per la Promozione della salute, Torino, 2020, pp.1-80.
[46] K. S. Kim, M. Lor, Art Making as a Health Intervention: Concept
Analysis and Implications for Nursing Interventions, in ANS. Advances in nursing
science, 45(2), 2022, pp.155–169.












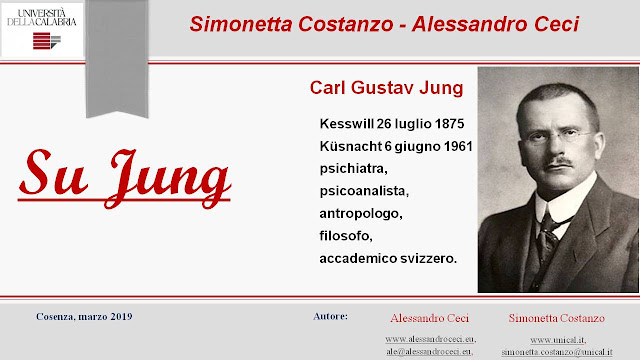
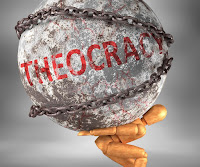

Commenti
Posta un commento