2 - Epistemica della Simbiosi
CSI
Competenza Situazionale
di Incorporazione
Alessandro
Ceci
marzoduemiladiciassette
EPISTEMOLOGIA
SIMBIOTICA:
la probabilità soggettiva che ha un evento di
accadere è data dalla sua competenza situazionale a incorporare possibilità
pesate e a elaborarle in propensioni pensate.
Ho
notato una certa recrudescenza a pubblicare, ultimamente, libri al confine tra
epistemologia e politica. L’ultimo, in ordine cronologico - che risulti a me -
è questa intervista di Pino Donghi a Giulio Giorello sulla scienza e sulla
rivoluzione[1]. Un
altro è la descrizione del mondo, specificamente il mondo della politica, al
tempo dei quanti, proposta da Mario Agostinelli e Debora Rizzuto[2].
Quasi contemporaneamente è comparsa la cronaca autobiografica della esperienza
parlamentare[3] di
Elena Cattaneo, eminente biologa e farmacologa, scienziata di chiara fama,
nominata dal Presidente Giorgio Napolitano senatrice a vita. Potrei continuare citando moltissime altre
pubblicazioni, dalla filosofia politica genetica dell’umano[4]
all’avvento prossimo venturo di uomini cyborg[5],
che, in modo esplicito o implicito, cancellano sempre più, mentre lo
descrivono, il labile confine tra scienza e politica.
Che
cosa significa?
Forse
è vero, come scrive Audi, che nell’era moderna l’epistemologia trasborda, cioè
che “acquisisce una portata che va oltre i confini della disciplina
specialistica”[6]?
Perché? Per sconfiggere il dominio del potere incontrollato, che nella società
della comunicazione è un potere cognitivo fondato sulla scissione simbiotica
tra realtà e verità?
Certo,
ma non solo. Non solo per l’affermazione di una nuova forma di potere nella
società della comunicazione; che pure è la causa più importante se non
addirittura determinante.
C’è, a mio avviso, anche un tema più sotterraneo,
più rivoluzionario, più in sintonia con le evoluzioni funzionali della
conoscenza. Un tema di carattere epistemologico.
Avendo
spesso trattato il problema del potere altrove[7],
mi dedico qui all’altro aspetto, quello appunto epistemologico.
…verso la epistemologia
simbiotica
Diciamo che per molti di noi, per
quelli di noi che sono stati influenzati se non addirittura cognitivamente
colonizzati, dalla produzione letteraria di Karl Popper e della sua “Società
Aperta”[8], questa
congiunzione epistemologica tra scienza e politica, era nota. Io stesso, ben 11
anni fa, nel 2006, concludevo così un mio noto libro: “Quando, tra cinquemila anni, chissà da quale
anfratto intergalattico, nello spazio, le future generazioni per conoscersi
meglio ci osserveranno, coscienti che nella storia dell’umanità non esistono
esperienze che, per quanto nuove o rinnovatrici, non siano in qualche modo
riconducibili ad esperienze precedenti: che cosa vedranno? Come sintetizzeranno
la multiforme vita di ciascuno di noi? A che cosa ci ridurranno? Come ci
caratterizzeranno? Forse racconteranno la breve storia della nascita e della
prima, lenta evoluzione dell’intelligenza. Tracceranno il passaggio, a diversi
ritmi di accelerazione, della logica: dalla sua complessità ontologica alla sua
complessità tecnologica fino alla attuale complessità epistemologica.
Descriveranno la nostra emancipazione attraverso le quattro tappe della
modernizzazione: dalla conquista della posizione retta alla coltivazione dei
campi, dalla produzione industriale ai network della comunicazione. Ci
rappresenteranno dentro le varie forme in cui è evoluta la nostra associazione
di individui: in gruppi, organizzazioni, comunità, società. Ci raffigureranno
come un coacervo indistinguibile e spesso, per fortuna, incomprensibile di
razionalità e ragionevolezza, follia e spensieratezza, teorizzazione e
sperimentazione, tentativo ed errore, sensazione, emozione, ira, violenza,
programmazione, improvvisazione, usurpazione e giustizia, privazione e
libertà. Ma, sopra tutto, emergeranno
inequivocabili e chiari i due segni più esaltanti della nostra presenza nel
mondo: la conoscenza scientifica e l’azione politica.”[9]
E
allora?
Di
che stupirsi?
Dell’intensità:
tanta produzione, tanti libri sul tema e
con tanta frequenza, come oggi, nessuno se li aspettava.
Come
mai?
Non
credo che siano tutti improvvisamente rinsaviti, fulminati all’istante sulla
strada della epistemologia e della sua rilevanza metodologica nella soluzione
politica dei problemi sociali. Anche perché, ad ascoltare i protagonisti
televisivi di analisi politica, giornalisti, opinion makers e politici, questa
consapevolezza non compare proprio. Si preferiscono lunghi e noiosi monologhi,
spesso senza alcuna articolazione logica, il semplice, cioè, banale almanacco
dei problemi, dei loro deficit, abbozzate soluzioni, senza articolazione e
senza alcuna connessione. Però con tanta enorme presunzione.
Invece,
proprio l’approccio epistemologicamente congiunto tra scienza e politica,
dovrebbe fornirci una visione d’insieme, prospettica, dei trend sociali, dei
suoi modelli di sviluppo e dei valori da enfatizzare per scambiare porzioni di
vita di qualità che fanno la qualità della vita.
John
Losee[10]
distingue 4 diversi punti di vista sulla filosofia della scienza:
1. quello delle implicazioni universali, “secondo
cui la filosofia della scienza è la formulazione di concezioni del mondo che
sono coerenti con importanti teorie scientifiche e in certo qual senso sono
basate su di esse”[11];
2. quello delle implicazioni soggettive, “secondo
cui la filosofia della scienza è un’esposizione dei presupposti e delle
predisposizioni degli scienziati”[12];
3. quello delle implicazioni teoriche, “secondo cui
la filosofia della scienza è una disciplina in cui i concetti e le teorie
delle scienze vengono sottoposti a un’opera di analisi e di chiarificazione”[13];
4. quello delle implicazioni metodologiche, che “considera
la filosofia della scienza una criteriologia di secondo livello”[14]
che risponde a quesiti sulle caratteristiche, sulle procedure, sulle condizioni
e sullo status dei problemi scientifici.
Poi
c’è un quinto approccio: il nostro.
Nasce
dalla lebenswelt, dalla scienza della vita di Husserl[15],
per passare ai gradi dell’organico di Plessner[16],
ancora dentro la epistemologia genetica di Piaget[17],
attraverso la teoria della complessità e la fisica di Ilya Prigogine[18],
fino alla nostra epistemologia simbiotica.
Simbiotica
a che?
Alla
natura?
All’ambiente?
No.
All’habitat sociale.
Ho
passato tutta la vita a studiare le scienze sociali e particolarmente quelle
politiche.
La
mia inclinazione filosofica è stata in parte arginata: prima per calcolo,
poiché la vulgata familiare era convinta della oziosa inutilità della
disciplina; poi per amore, in quanto hegelianamente mi ero convinto che la
scienza politica fosse la sintesi della dialettica conoscenza/azione.
Una
volta laureato, sono stato dissuaso allo studio cattedratico della filosofia
dal presidente del mio primo centro di Ricerca sulle tecnologie educative[19],
il quale riteneva che lo studio affascinante, sebbene altrettanto “matto e
forsennato” della epistemologia fosse molto più diretto e funzionale alla
mia professione di sempre ed alla mia professionalità: la gestione di gruppi
scientifici, in ambito di ricerca, di sperimentazione, di formazione e di
consulenza.
Così
ho fatto, per fortuna! E allora tutta la mia vita intellettuale, tranne qualche
improvviso hobby, è stata racchiusa – spero non chiusa – nello studio
filosofico della scienza e della politica. Anche se a molti non sembra, in
realtà mi sono sempre soltanto occupato di epistemologia e politologia. Anzi,
per meglio dire, con la epistemologia ho sempre difeso la politologia e,
tramite essa, tutte le scienze sociali.
Questo
confronto serrato è durato molti anni. Infatti, da quando mi sono laureato ad
oggi, ho incontrato una pletora di scienziati presunti e presuntuosi che, con
aria di sufficienza, mi hanno fatto notare l’insignificanza delle scienze
sociali e la futilità di una laurea in Scienze Politiche. Ho difeso in mille
modi, invece, questa competenza e non perché fosse la mia. Tuttavia allora non
avevo la esaustività di oggi, specie dopo le più recenti scoperte.
Le
ragioni delle Scienze Sociali si sono stabilizzate in me soltanto di recente,
nel 2013, quattro anni fa, quando ho letto il libro del biologo-sociale Edward
Wilson[20],
che meriterebbe davvero il premio Nobel, in cui si dimostra in modo inequivocabile che la terra
è stata conquistata da animali eu-sociali. E che proprio la eu-socialità ha
generato primati superiori, fino all’umano.
La
cosa, come detto, mi era già nota da quando ho studiato la Labenswelt,
la scienza della vita di Emund Husserl, il quale sostiene che la epistemologia
classica è riduttiva per il fatto che, concentrando la scienza su se stessa,
perde gran parte della vita, quella che sembra disperdersi nelle relazioni
sociali e nell’ermeneutica, la scienza dei significati. Il primo punto è stato
quello del superamento della obiettiva oggettività della scienza ufficiale nel
mondo-della-vita. C’è, infatti, un mondo-della-vita che “è il mondo dello
spazio-temporale delle cose così come noi le sperimentiamo nella nostra vita
pre- ed extra-scientifica e così come noi le sappiamo esperibili al di là della
esperienza attuale”[21].Invece,
con la scienza ufficiale, “ponendo come fine questa obiettività (una «una
verità in sé») assumiamo una specie di ipotesi che travalica il
mondo-della-vita”[22].
Tuttavia questa accezione è definitivamente superata giacché “noi abbiamo
prevenuto questa possibilità di «travalicamento» del mondo-della-vita mediante
la prima epoché (l’epoché delle scienze obiettive) e ora siamo in imbarazzo
riguardo a ciò che può essere preso in considerazione scientificamente come un
che di constatabile una volta per tutte e da parte di tutti”[23].
La scienza obiettiva tradizionale non supera il suo imbarazzo fino a quando non
si prende in considerazione che “il mondo-della-vita, malgrado la sua
relatività, ha una propria struttura generale”[24].
Ma “questa struttura generale, a cui è legato tutto ciò che è relativo, non
è a sua volta relativa”[25].
Husserl poneva dunque una esigenza di conoscenza, al limite anche di una
conoscenza scientifica, di quel mondo che trascuriamo perché la presunzione di
oggettività dei nostri metodi non
considera, esclude, ma dove tuttavia viviamo ogni giorno. Un mondo che ha
regole fondamentali, cioè una sua “struttura generale”[26]
e che quindi può essere investigato se avesse una epistemologia libera dalla
oggettivazione tradizionale e dunque in condizione di percepirlo. Un mondo che, in realtà, le scienze obiettive
avrebbero già dovuto considerare, in quanto il “mondo-della-vita ha già in
via pre-scentifica le «stesse» strutture che le scienze obiettive presuppongono
parallelamente alla loro sostruzione (diventata orma un’ovvietà attraverso una
tradizione secolare) di un mondo che è «in-sé», che è determinato attraverso le
«verità in-sé», e che dispiegano sistematicamente nelle scienze a priori, nelle
scienze del logos, delle norme metodiche universali a cui va connessa qualsiasi
conoscenza del mondo «obiettivamente essente in sé»”[27].
Quando “rinuncia a fondarsi scientificamente sull’a-priori universale del
mondo-della-vita”[28]
la nostra logica è “presuntivamente autonoma”[29].
Si tratta di una logica, cioè, che “rimane sospesa nell’aria, priva di
fondamenti”[30],
ma che invece, tramite una “riflessione radicale”[31]
può realizzare “il grande compito di una teoria dell’essenza del
mondo-della-vita”[32].
Pertanto, “soltanto una volta attuata questa scienza radicale del
fondamento, la logica stessa può diventare scienza”[33].
In questo modo Husserl, prima di morire (1938), tra il 1936 e il 1937, lancia il suo programma che per noi oggi
sarebbe un programma quantistico: “occorrerebbe dunque una distinzione
sistematica delle strutture universali, dell’a-priori universale del
mondo-della-vita e dell’a-priori universale «obiettivo»; successivamente
occorrerebbe definire la problematica universale del modo in cui l’a-priori «obiettivo»
si fonda sull’a-priori «soggettivo-relativo» del mondo-della-vita, oppure, per
esempio, del mondo in cui l’evidenza matematica trova la propria fonte di senso
e di legittimità nell’evidenza del mondo-della-vita”[34].
La
dimensione sociale della conoscenza mi era nota dalla epistemologia genetica di
Jean Piaget, secondo cui “l’intelligenza organizza il mondo organizzando se
stessa”, fondamentale concetto della auto poiesi cognitiva precedente agli
studi di Maturana e Varela. In quanto biologo e zoologo, non in quanto
psicologo, Piaget cerca una epistemologia sperimentale che fosse in grado, come
per Husserl, di superare i limiti degli approcci positivisti e neopositivisti
della conoscenza scientifica e contro ogni costruzione lineare e unilaterale
della scoperta scientifa, in cui il noto scaturisce dall’ignoto, trasmigrando
da una disciplina all’altra. Piaget immaginava un programma di conoscenza che
fosse scientifica in quanto fosse interdisciplinare
e transdisciplinare in grado di coordinare metodi e contenuti di ogni
ricerca, sfuggendo dalla riduzione specialistica delle discipline. Piaget era
perfettamente cosciente del fatto che la scienza “oggettiva” fosse una scienza
essenzialmente normativa, cioè costruita interamente su norme e criteri
epistemologici predeterminati e atemporali; “dall’ipotesi che la verità si
fonda su norme permanenti, situate nella realtà, nelle strutture a-priori o
nelle sue intuizioni immediate e vissute”. La sua epistemologia genetica
allora tenta di elaborare un programma che consideri la genesi temporale
delle norme, perché attribuisce la crescita della conoscenza “alla
pressione delle cose, alle felici convenzioni del soggetto o alle interazioni
del soggetto e dell’oggetto” per invertire il processo e fare in modo che “l’analisi
dello sviluppo potrà procedere dal fatto alla norma” per definire “soluzioni
genetiche”. In questo modo “il problema non sarà più il tal caso quello
di rinvenire la norma fissa nell’ambito della evoluzione, bensì di generare la
norma stessa tramite i dati mobili dello sviluppo”.[35]
In questo modo Piaget pone, forse per la prima volta, la funzione auto poietica
della scienza, costruita su una epistemologia che, oltre ad essere oggettiva[36],
storica[37],
sperimentale[38],
fosse principalmente genetica, nel senso della continua auto-produzione della
scienza a se stessa. L’epistemologia di Piaget diventa una meta epistemologia,
una epistemologia della epistemologia[39].
che sfrutta ogni tipo di indagine che sappia formulare modelli
interpretativi e fornire dati al fine di implementare lo sviluppo storico,
sociale, naturale e individuale dei processi cognitivi. Si potrebbe dire così:
l’essere umano conosce la realtà attraverso la sua verità e la sua verità
attraverso la realtà. Questo circuito genera la conoscenza di cui ha bisogno
per fronteggiare le sfide della complessità del mondo.[40] Siamo alla prima espressione di una
epistemologia riflessiva, di ordine processuale, che sarà riconosciuto e
reinterpretato, nella dizione di conoscenza della conoscenza[41], dalle
ipotesi auto poietiche di Maturana e Varela[42]. Lo
riconosce Varela: “L'originalità dell'epistemologia genetica consiste
nell'estendere l'ambito di indagine dell'epistemologia a tutti gli stadi
evolutivi, non limitandosi a quelli geneticamente più compiuti, come è quello
della conoscenza scientifica. Suo oggetto di studio non è cioè soltanto la
conoscenza scientifica, ma anche le varie manifestazioni storiche della
conoscenza scientifica, la conoscenza prescientifica che è solidale alle
strutture mentali dell'adulto e del bambino, nonché l'insieme di condizioni
biologiche, fisiche e sociali che rendono possibile lo sviluppo di tali
strutture. Jean Piaget ha studiato il modo in cui soggetto e oggetto si
costruiscono reciprocamente attraverso molteplici livelli di sviluppo”.[43] La
connotazione comune tra la epistemologia genetica e l’autopoiesi, consiste
nella dimensione cognitiva: “Quanto Piaget ha introdotto in modo indimenticabile – sostiene Varela - è che la cognizione - anche in quelle che sembrano
le sue espressioni più astratte - è
fondata sulla concreta attività
dell'intero organismo, cioè sull'accoppiamento senso-motorio.” Siamo di nuovo alla considerazione dell’habitat sociale, alla vita in
un mondo che “non è qualcosa che ci è dato, è qualcosa a cui prendiamo parte attraverso il modo in
cui ci muoviamo, attraverso il modo
in cui tocchiamo e via dicendo”. Questa partecipazione quotidiana e assoluta
alla vita nel mondo “è quanto io chiamo cognizione quale a-zione effettiva,
dato che azione effettiva connota questa attività di produzione attraverso una manipolazione concreta”[44].
Anche
la fisica, che consideriamo sempre resistente, si è aperta al riconoscimento
della esigenza di una nuova epistemologia con le strutture dissipative e la
freccia irreversibile del tempo di Ilya Prigogine, essenziale interprete delle
teorie sulla complessità. In modo molto esplicito, Prigogine pone il problema
di “una nuova razionalità”[45]
contro quello che William James ha chiamato “il dilemma del determinismo”[46].
“La fisica del non equilibrio, che è venuta prendendo forma negli ultimi
decenni, – scrive Prigogine – è in effetti una nuova scienza. Essa ha
condotto a nuovi concetti, come l’auto-organizzazione e le strutture
dissipative, che sono oggi largamente utilizzati in molti ambiti, dalla
cosmologia all’ecologia e alle scienze sociali, passando per la chimica e la
biologia”[47]. I
nostri habitat sociali sono “sistemi dinamici instabili”[48]
è occorre una nuova scienza per comprenderli, sostitutiva di quella vecchia,
oggettiva, classica, che “privilegiava l’ordine, la stabilità, mentre noi
oggi riconosciamo il ruolo primordiale delle fluttuazioni e dell’instabilità a
ogni livello di osservazione”[49].
Negli habitat sociali che garantiscono la nostra evoluzione noi abbiamo
costantemente di fronte “le scelte multiple e gli orizzonti di prevedibilità
limitata”[50]. Non
abbiamo più certezza e “nella fisica quantistica le leggi fondamentali
esprimono ora delle possibilità”[51].
Addirittura anche le leggi non bastano più. Viviamo dentro “eventi che non
sono deducibili da leggi ma ne traducono in atto le possibilità”[52].
La questione di una nuova epistemologia comprensiva delle dinamiche della vita,
“non è limitato alle scienze, ma è al centro del pensiero occidentale”[53].
Il problema della conoscenza non deterministica, “esprime una tensione
profonda in seno alla nostra tradizione, che vorrebbe presentarsi al tempo
stesso come fautrice di un sapere obiettivo e come paladina dell’ideale
umanistico della responsabilità e della libertà”[54].
Torna la equivalenza tra scienza e politica: “democrazia e scienze moderne
sono eredi della stessa storia, la quale condurrebbe pero a una contraddizione
se le scienze facessero trionfare una concezione deterministica della natura,
mentre la democrazia incarna l’ideale di una società libera. Considerandoci
estranei alla natura introdurremmo un dualismo che è estraneo all’avventura
della scienza, come pure a quella passione per l’intelligibilità che è propria
del mondo occidentale. Questa passione, secondo Richard Tarnas, è quella di
«ritrovare la propria unità con le radici del proprio essere». Noi pensiamo
oggi di essere a un punto cruciale di quest’avventura, al punto di partenza di
una nuova razionalità che non identifica più scienza e certezza, probabilità e
ignoranza”[55].
Tuttavia
lo studio di Wilson è stato illuminante. Solo in quel testo, tra gli altri a me
noti, è ben delineato il rapporto simbiotico essenziale tra l’individuo e il
suo habitat sociale, tra l’habitat sociale e l’ambiente naturale. Nessuno vive
nel mondo a contatto diretto con l’ambiente. Ciascuno vive dentro il suo
habitat sociale, esclusivamente nel suo habitat, e si adatta biologicamente e
quindi fisicamente ad esso. Senza habitat sociale nessun essere vivente sarebbe
evoluto e, tanto più è forte la rete
dell’habitat sociale, tanto più gli animali evolvono. Noi non saremmo evoluti
né fisicamente, né cognitivamente. Una situazione, sebbene non precisamente
definita e approssimativamente rappresentata, fu rappresentata chiaramente da
Plessner che ha individuato il posizionamento dei viventi distinguendo tra 3
gradi dell’organico: l’ambiente naturale in cui vivono le pietre e le piante;
l’habitat eu-sociale in cui vivono gli animali centrici, cioè concentrati
attorno ai propri bisogni; e l’habitat sociale in cui vivono gli umani
eccentrici, che sanno superare lo schema vitale dei bisogni in funzione di
relazioni collettive, esigenze di gruppo e valori morali[56].
L’ipotesi
teorica che l’habitat sociale sia la condizione fondamentale della nostra
fitness evolutiva ci è collettivamente giunta soltanto qualche mese, all’inizio
del 2017, con un esperimento finalizzato a dimostrare il paradosso dei gemelli
di Einstein.
Come
è noto, il teorico della relatività sosteneva che, se sulla terra vi fossero
due gemelli e uno partisse per un viaggio interstellare di andata e ritorno su
una astronave che viaggiasse a velocità prossime a quelle della luce, al suo
ritorno il fratello astronauta troverebbe il gemello molto più invecchiato di
lui se non addirittura morto. In realtà non si tratta di un vero e proprio
paradosso, ma di un esempio per spiegare la relatività del tempo rispetto
all’habitat in cui si misura. Un conto è il tempo che si trascorre
nell’astronave e altro conto è il tempo che si trascorre sulla terra. La
variabile è data dalle condizioni di habitat dell’astronave rispetto a quelle
sulla terra. Infatti è da molto tempo che si verifica, in termini di particelle
subatomiche, che il loro decadimento, misurato in laboratorio, è diverso in
relazione alla loro velocità, molto più lento quando le particelle viaggiano a
velocità prossime a quelle della luce.
Ora
si da il caso che alla NASA due gemelli monozigoti vi fossero davvero: i
gemelli Kelly.
Scotte e Mark Kelly, gemelli astronauti americani,
si sono divisi i compiti, Mark è rimasto sulla terra e Scott si è trasferito
per 340 giorni su un’astronave sullo spazio. I gemelli monozigoti, cioè nati da
una sola cellula, erano praticamente identici. Al ritorno di Scott, non lo
erano più. Non solo perché Scott è risultato essere, come prevedeva Einstein,
più giovane di Mark. I suoi telomeri, cioè le parti che si trovano alle
estremità dei cromosomi associati alla longevità, sono diventati più lunghi. Inoltre i telomeri, le parti che si trovano alle estremità dei
cromosomi, associate anche alla longevità, sono diventati più lunghi. Ma essenzialmente e inaspettatamente perché Scott,
in 340 giorni nello spazio, ha cambiato il suo DNA.
L’esperimento
è estremamente interessante rispetto agli studi sulla depressione perché, dopo
la lunga serie di analisi approfondite sui gemelli, sono comparsi cambiamenti
nell’attività dei geni e, in modo specifico, nei processi chimici (metilazione)
del DNA di Scott. I cambiamenti sono, infatti, simili ai cambiamenti che
avvengono nelle persone sottoposte a condizioni di stress o depressioni, come
ad esempio la modifica del ciclo del sonno e della dieta.
Tuttavia
la cosa estremamente interessante, che influenzerà tutte le ricerche
scientifiche presenti e future, è il dato ormai oggettivo che la modificazione
dell’habitat sociale modifica il microbioma, cioè proprio quell’insieme del
patrimonio genetico deputato alle interazioni tra organismo e habitat sociale.
In ogni caso, con la modificazione dell’habitat, tutti, tutti i parametri
fisici di Scott sono cambiati, con la variabilità rapida di un mutante.
…verso un modello
multidimensionale complesso (COMP)
Nella
epistemologia classica o tradizionale, compresi i 4 approcci proposti da Loose,
il valore di una scoperta scientifica è tanto più oggettiva (e dunque valida)
quanto più è non variabile e non influenzabile. Deve essere applicabile ovunque
e sempre, in qualsiasi condizione data.
Sulla
variabilità del tempo, a causa della diversificazione dello spazio, sappiamo
quasi tutto. Il tempo è relativo perché lo spazio è concavo. Agostinelli e
Rizzuto, che hanno scritto un bel libro sulle leggi della fisica nella dinamica
sociale, ci hanno mostrato come, nella relatività ristretta, le “linee di
universo” che tracciano un evento, “le relazioni e la conoscenza in una
società complessa e evoluta, possano essere viste sia sotto il profilo
particellare (velocità) che ondulatorio (frequenza) e questa complementarietà,
essenziale per la quantistica, consentirà anche al lettore consentirà anche al
lettore di orientarsi di volta in volta secondo la metafora di interpretazione
più congrua.”[57]
Ci ricordiamo cioè che, dopo la
Labenswelt di Husserl e dopo la funzione irreversibile del tempo nei fenomeni
dell’esistenza di Prigogine e, per me, dopo la mia epistemologia simbiotica, la
non variabilità e la non influenzabilità spazio/temporale del dato è un limite
alla oggettività scientifica, perché non considera la rilevanza (ormai
conclamata) dell’habitat sociale e dalle sue dinamiche di cambiamento.
È a questo punto che vorrei
principalmente discutere della ricerca di Massimo Cocchi e del suo gruppo
scientifico. Perché non ho capito se il problema della incisività dell’habitat
sociale sia stato o no davvero preso in
considerazione.
Il gruppo ha osservato che una
determinata e specifica composizione di acidi grassi presenti nella membrana
delle piastrine come “marker biologici di depressione” si correla in
maniera significativa con la clinica dello stato depressivo ed è quindi un
supporto fondamentale alla diagnosi di depressione e permetterebbe di
discriminare i soggetti depressi dai bipolari. La classificazione è avvenuta
tramite “la costruzione di una Rete Neurale Artificiale (RNA) di tipo Self
Organizing Map (SOM), rete di Kohonen”[58].
“La distribuzione dei 144 soggetti
effettuata dalla SOM ha permesso di individuare 4 aree: due specifiche
(esclusivamente normali ed esclusivamente patologici) e due miste con diverse
concentrazioni di soggetti patologici e di soggetti del campione apparentemente
normale.”[59] Il
risultato conclusive è quello di “imprimere una svolta storica alla diagnosi
psichiatrica, fornendo allo psichiatra strumenti efficaci e obiettivi di
valutazione clinica per consentirgli una diagnostica con la possibilità di
ridurre, in pratica, a zero, il margine di errore diagnostico.”[60]
Dal mio punto di
vista la ricerca è significativa, nonostante alcune titubanze di ordine
metodologico, per 3 motivi precisi:
· perché, anche se inconsapevolmente, constata la
presenza di un intervallo di sostenibilità fenomenologico sul tema della
depressione;
· perché è una delle rare occasioni in cui si svolge
una, diciamo così, wetware epistemolgy, cioè una ricerca condotta con
l’ausilio di una rete neurale;
· perché offre la “possibilità di ulteriori
indagini anche riguardo ad altre patologie psichiatriche quali le psicosi e
l’ideazione suicidaria, oltre alla complessa indagine rispetto a possibili
variazioni biologiche indotte dalle terapie attualmente in uso.”[61]
Proprio questo
ultimo punto, delle ulteriori possibilità di ricerca, tranquillizza i fautori del libero arbitrio. Chi ritiene
che sapere ontologicamente della depressione e delle possibilità di suicidio
commette due errori fondamentali di ordine logico ed epistemologico.
Il primo errore,
di ordine logico, può tranquillizzare la rigida teologia cattolica: la
propensione al suicidio non significa assolutamente che esista una probabilità
che accada, nonostante il marcatore della depressione. La differenza tra
propensione e probabilità è stata ben delineata da Karl Popper[62].
Per Popper
viviamo “in un mondo di propensioni”[63]
che “rende il nostro mondo sia più interessante che familiare di com’era
visto dalle scienze dell’era precedente”. E, nel 1956, elabora una Iterpretazione
della probabilità in termini di propensione (The Propensity Interpretation of
Probability)”[64].
I punti sono
questi:
1. per stabilire quali sono le probabilità che un
evento accada è prima indispensabile stabilire quali siano le sue possibilità, poiché “la probabilità di un evento corrisponde
al numero delle sue possibilità favorevoli diviso per il numero di tutte le
possibilità”[65];
2. per stabilire il valore
ponderale delle possibilità, un
criterio quantitativo non basta, occorre un criterio qualitativo, occorre cioè
ricorrere alla Teoria Generale dei pesi, cioè che “una teoria generale della
probabilità deve comprendere anche queste possibilità pesate”[66]
e che, altresì, “casi di possibilità uguali potrebbero e dovrebbero essere
trattati come casi speciali di possibilità pesate”[67]
e che cioè “possibilità uguali possano essere considerate come possibilità
pesate, i cui pesi sono uguali”[68].
Ma se, per un motivo o per l’altro, come quasi sempre si verifica nella logica
quantistica, nelle scienze sociali e in ogni ambito della teoria della
relatività di Einstein, i pesi non sono uguali? La teoria dei pesi è
fondamentale ed è impressionante come Popper arrivi subito a stabilire che sia
indispensabile “a tutte le scienze, alla fisica e alla biologia per
affrontare problemi come la probabilità di sopravvivenza per alcuni anni”[69].
Popper è perfettamente cosciente del problema: “esiste un metodo - o uno
strumento come la bascula – che possa aiutare a stabilire il peso effettivo
delle possibilità pesate? C’è un metodo che ci permetta di attribuire valori
numerici a possibilità che non sono uguali?”[70];
3. tuttavia la sua soluzione parziale è una sola: il metodo statistico. Stabiliti, infatti, una serie di eventi identici
che si ripetono con una certa frequenza e senza alcuna interferenza, “se il
numero di queste ripetizioni è abbastanza alto, noi possiamo applicare la
statistica come metodo per pesare le possibilità e per misurare il loro peso.
In parole più esplicite, la maggiore o minore frequenza delle occorrenze può
essere usata per verificare se un peso attribuito in via puramente ipotetica è
un’ipotesi adeguata”[71];
4. ciò significa allora che c’è una tendenza o propensione a che l’evento accada e che “la tendenza o
propensione verso la realizzazione di un evento è, in generale, inerente a
ogni possibilità”[72];
5. si tratta di una propensione
misurabile “ricorrendo alla
frequenza relativa della realizzazione effettiva in un gran numero”[73],
cioè “stabilendo quante volte l’evento in questione accade realmente”[74];
6. solo se questa propensione è costante, solo se lo è
addirittura in condizioni di altre alterazioni come ad esempio le modificazioni
dell’habitat sociale, noi possiamo constatare una stabilità dell’evento (o del dato)[75].
Abbiamo in altri termini bisogno di frequenze statistiche stabili, “la
tendenza delle medie statistiche a rimanere stabili a condizioni costanti è una
delle caratteristiche più notevoli del nostro universo. Io ritengo che essa
possa essere spiegata solo con la teoria della propensione; ossia con la teoria
secondo la quale esistono possibilità pesate, che sono più di semplici
possibilità, bensì tendenze o propensioni a diventare reali: tendenze o
propensioni a realizzarsi, che sono, in vario grado, inerenti a tutte le
possibilità e che rappresentano come delle forze che mantengono stabili le
statistiche”[76];
7. quando le frequenze
statistiche sono stabili, quando cioè esistono propensioni, significa
che la complessità fenomenologica di un evento è più bassa perché esistono
strutture conservative di energia che hanno abbassato il livello entropico
interno all’intervallo di sostenibilità di quel determinato evento. Significa
cioè che la tendenza alla realizzazione dell’evento è abbastanza stabile e che
l’entropia in libertà ha una scarsa capacità di destabilizzazione. Questa
conclusione, di cui rimando la dimostrazione, è suffragata dalla intuizione
assuntiva di Popper che “le propensioni non siano semplici possibilità,
bensì realtà fisiche, reali come le forze o i campi di forza. E viceversa: le
forze sono propensioni, propensioni a mettere in moto i corpi. Le forze sono
propensioni ad accelerare, e i campi di forze sono propensioni sparse su
qualche regione dello spazio, nella quale esse sono in continuo cambiamento
(come le distanze da un punto di partenza dato). I campi di forze sono campi di
propensioni, reali ed esistenti”[77].
Confermo quanto sostenuto al punto 3:
che la soluzione di Popper è parziale.
Le frequenze statistiche non bastano a
stabilire le propensioni: come si dice, sono necessarie ma non sufficienti.
Proprio perché le propensioni sono forze
occulte che spostano il peso delle possibilità, cioè i loro valori ponderali
entro l’intervallo di sostenibilità, potrebbero essere indotte da un fattore
non riscontrabile dalle frequenze statistiche, altrettanto pesante sebbene non
ricorrente; come ad esempio il caso delle madri assassine che,nel campo di
forze dell’habitat sociale, hanno una frequenza statistica (ricorrenza) molto
bassa (la stragrande maggioranza delle madri fa nascere i figli e non li
ammazza), ma un valore ponderale altissimo perché è una minaccia genetica che
sconvolge i tabù relazionali e l’immaginario collettivo. Ed è, ad esempio, il
caso tipico della depressione, che, finora almeno[78],
è stato un male oscuro e, per questo motivo, non riscontrabile dalle frequenze
statistiche in fase di insorgenza.
In ogni caso il
problema resta: il metodo statistico è necessario ma non sufficiente per
stabilire l’andamento, cioè la propensione alla esplosione o alla implosione
nell’intervallo di sostenibilità di un determinato evento.
Occorrono anche
metodi e tecniche di comparazione, in grado di verificare meglio la profondità
e quindi il peso non evidente di un determinato evento. Metodi e tecniche di
comparazione o, come si chiamano oggi, EN: Esperimenti Naturali[79].
Si tratta di un approccio che “consiste ne confrontare – preferibilmente in
modo quantitativo e con l’aiuto di analisi statistiche – sistemi diversi che
siano simili fra loro sotto molti aspetti ma che differiscano in relazione ai
fattori dei quali si vuole studiare l’influenza”[80].
Naturalmente,
entrare in una dettagliata esposizione dell’analisi comparativa sarebbe lungo e
quindi deve diventare oggetto di altra trattazione.
Possiamo qui
indicare quattro condizioni fondamentali a cui bisogna fare costantemente
riferimento quando si percorre questo
metodo ormai noto e sperimentato nelle scienze sociali:
1.
ogni evento è
unico e irreversibile.
Qualche anno
(2009) fa ebbe un discreto successo un film apparentemente assurdo, dal titolo
“Il curioso caso di Benjamin Button”.
Il protagonista nasce vecchio e muore bambino. Tutta la sua vita è un
processo invertito, un tempo invertito, con esperienze invertiti. Il simbolismo
è descritto da un altro simbolismo all’inizio del film: in occasione della
inaugurazione di una stazione ferroviaria un prestigioso orologiaio cieco, a
cui era scomparso un figlio in guerra, aveva costruito un imponente orologio le
cui lancette correvano in senso antiorario. L’orologio segnava il tempo a
ritroso nella vana speranza che, mandando il tempo indietro, si sarebbero
potuti riportare i soldati morti in vita e ritornare a trovare le ragioni della
pace per evitare la guerra.
Perché però la
speranza è vana?
Perché nel mondo
della vita il tempo non torna più. Nale tempo che passa l’energia si disperde
nello spazio e si trasforma. E questo processo è irreversibile, e procede
sempre nello stesso ordine: il passato, il presente e il futuro. Il tempo non
procede al contrario. In nessuna dimensione dell’esistente siamo mai tornati
indietro, mai siamo andati dal futuro al passato. Per Ilya Prigogine il tempo è
una freccia che procede secondo un certo ordine e sempre con lo stesso verso; e
questo comporta una serie incredibili di implicazioni universali e
scientifiche. Direi, epistemologiche. Se potessimo tornare indietro, anche alla
velocità della luce, anche oltre la velocità della luce, non torneremo mai al
Big Bang iniziale. Quanto è avvenuto è avvenuto. Forse sarebbe potuto andare
diversamente. In ogni istante sarebbe potuto andare diversamente. È andata
così. Il nastro non si può riavvolgere, comunque.
2. ogni campo di forze (habitat sociale, dominio
relazionale) è perturbato dai pesi soggettivi e/o individuali, veri (cioè
percepiti) o reali (cioè strutturali) (Einstein)
3. ogni evento è multidimensionale in termini logici
(E. Ceci)
4. ogni evento (individuo e/o soggetto) è un sembionte
di un ospite fenomenologico (habitat e/o ambiente) (Margulis Lynn)
…verso una conoscenza
simbiotica
C’è un altro punto che ci conduce, per
comprendere un evento, al suo habitat sociale. Le propensioni – dice Popper – “non
dovrebbero venir considerate come proprietà inerenti a un oggetto, come
un dato o una moneta da un penny, bensì come inerenti a una situazione
(della quale naturalmente l’oggetto fa parte). Io ho sostenuto che l’aspetto
situazionale della teoria della propensione era importante, e decisamente
importante per una interpretazione realistica della teoria dei quanti”[81].
Contro il tempo
della funzione, che abbiamo vissuto, “sorge così un tempo della prestazione
che non appare nel quadrante dell’orologio appeso alla parete, che non può
essere misurato solo in durata di secondi, minuti e ore”[82].
La psicologia e
la sociologia ci aiutano a coprire questa distanza, questa “discrepanza con
l’unità di misura tempo/orario”[83],
tra la propensione indicata dal marcatori e le probabilità del comportamento
individuale e /o dell’azione soggettiva.
In altri termini, nel network delle relazioni
individuale nell’habitat sociale si genera un tempo altro, che ci conduce,
senza essere riconosciuto, in un altrove, in uno spazio distinto in cui non è
detto che la propensione si converta in probabilità. In un altrove, in uno
spazio diversamente concavo, piegato dal peso dei problemi psicologici e
sociali, non è detto che il marcatore resista. Anzi, sulla base delle scoperte
ottenute sui gemelly Kelly, è molto possibile che quel marcatore scompaia.
Utilizzando il
paradosso dei gemelli di Einstein possiamo dire che: se un individuo, marcato
con tracce di depressione tendente al suicidio, dovesse vivere in un tempo e in
uno spazio statico, si troverebbe ad un alto tasso di probabilità. In un
sistema lineare della individuo-ambiente, il risultato della ricerca
costituirebbe un dato oggettivo permanente. Invece in un sistema complesso, a
diverse dimensioni e a cause variabili, l’oggettività del dato è un effetto del
peso dei problemi individuali che determinano la inclinazione o curvatura delle
linee delle “linee di Universo” nello spazio\tempo sociale. Se cambia il peso
dei problemi reali e/o percepiti cambia la curvatura e l’oggettività
previsionale del dato decade:
· sia perché il marcatore non si attiva, cioè non
dovrebbe determinare la formulazione di un valore stabile; cioè, potrebbe
indicare un comportamento oggettivo, ma non stabile;
· sia perché, in una condizione di diversi pesi
relazionali e sociali, il marcatore dovrebbe cambiare, modificarsi, scomparire
su alcuni soggetti e forse comparire in altri.
Pertanto, se non
è stata sufficientemente trattata la questione relativa agli impatti ondulatori
dell’habitat sociale nel profilo particellare della ricerca fisica e/o
biologica, allora la questione affascinante consiste nel sapere se – secondo le
nuove teorie epistemologiche della simbiosi eu-sociale – il marcatore è
assoluto o, come intuitivamente sospetto, relativo.
BIBLIOGRAFIA
1.
Augè
Marc, NONLUOGHI. INTRODUZIONE A UNA ANTROPOLOGIA DELLA SURMODERNITA’, Eléutera,
Roma 2009
2. Ayer
A. J., THE PROBLEM OF KNOWLEDGE, Macmillian,
3.
Bocchi
Gianluca e Ceruti Marco, ORIGINI DI STORIE, Feltrinelli, Milano 1993
4.
Cacciari
Massimo, LABIRINTO FILOSOFICO, Adelphi, Milano 2014
5.
Calabi
Clotilde, Coliva Annalisa, Sereni Andrea, Volpe Giorgio (a cura di), TEORIE
DELLA CONOSCENZA. IL DIBATTITO CONTEMPORANEO, Raffaello Cortina Editore, Milano
2015
6.
Capra
Fritjof, LA RETE DELLA VITA, BUR Rizzoli, Milano 2001
7.
Ceci
Alessandro, ANTROPOLOGIA DELLA SICUREZZA, Eurilink, Roma 2010
8.
Ceci
Alessandro, COSMOGONIE DEL POTERE, Ibiskos, Empoli 2011
9.
Ceci
Alessandro, INTELLIGENCE E DEMOCRAZIA, Rubettino, Soveria Mannelli,2006
10.
Ceci
Alessandro, SCENARI DI VERITA’, I Quaderni del Campus, Pomezia 2009
11.
Ceci
Elvio, LE QUATTRO DIMENSIONI DI LOGICA, in Schegge di Filosofia Moderna XIV,
deComporre Edizioni, Gaeta 2014
12.
Ceruti
Mauro e Petra Lorena (a cura di), CHE COSA E’ LA CONOSCENZA, Laterza, Bari 1990
13.
De
Waal Frans, IL BONOBO E L’ATEO. IN CERCA DI UMANITA’ FRA I PRIMATI, Raffaello
Cortina Editore, Milano 2013
14.
Diamond
Jared e Robison James (a cura di), ESPERIMENTI NATURALI DI STORIA, Le Scienze,
Torino 2017
15.
Florenskij
Pavel, L’INFINITO NELLA CONOSCENZA, Edizioni Mimesis, Milano 2014
16.
Galimberti
Umberto, CRISTIANESIMO, Feltrinelli, Milano 2012
17.
Gee
Henry, LA SPECIE IMPREVISTA. FRAINTENDIMENTI SULL’EVOLUZIONE UMANA, Il Mulino,
Bologna 2016
18.
Gershon
D. Michael, IL SECONDO CERVELLO, Utet, Torino 2013
19.
Hofstadter D. e Sanders E., SUPERFICI ED ESSENZE.
L’analogia come cuore pulsante del pensiero, Codice, Torino, 2015
20.
Husserl
Edmund, LA CRISI DELLE SCIENZE EUROPEE E LA FENOMENOLOGIA TRASCENDENTALE, Il
Saggiatore, Milano 2015
21.
Khun
Thomas, LA STRUTTURA DELLE RIVOLUZIONI SCIENTIFICHE, Einaudi, Torino 1979
22.
Lewis
Clarence Irving, LE BASI DELLA CONOSCENZA EMPIRICA, in Calabi C. C., Sereni A.,
Volpe G. (a cura di), cit. 2015
23.
Lhumann
Niklas, SISTEMI SOCIALI. FONDAMENTI DI UNA TEORIA GENERALE, Il Mulino, Bologna
1990
24.
Margarete
Yourcenar, LE MEMORIE DI ADRIANO, Mondadori, Milano,
25.
Margulis, Lynn and Sagan, MARVELLOUS MICROBES, in Resurgence, vol. 206, 2001,
pp. 10–12. Margulis Lynn e Sagan Dorion, LA DANZA MISTERIOSA, Mondadori,
Milano 1992.
26. Margulis Lynn, SERIAL ENDOSYMBIOTIC THEORY (SET) AND COMPOSITE INDIVIDUALITY, in Microbiology
Today, 2004, p. 172.
27.
Melandri
Enzo, ANALOGIA, Quodlibet, Macerata 2004
28.
Piaget
Jean, L’EPISTEMOLOGIA GENETICA, Laterza, Bari 2000
29.
Pier
Paolo Pasolini, LA BALLATA DELLE MADRI, in BESTEMMIA, Garzanti, Milano
30.
Plessner
Helmuth, I GRADI DELL’ORGANICO E L’UOMO. INTRODUZIONE ALLA ANTROPOLOGIA
FILOSOFICA, Bollati Boringhieri, Torino 2006
31.
Popper
R. Karl, I DUE PROBLEMI FONDAMENTALI DELLA TEORIA DELLA CONOSCENZA, Il
Saggiatore, Milano 1979
32.
Popper
R. Karl, EPISTEMOLOGIA, RAZIONALITA’ E
LIBERTA’, Armando, Roma 1972
33.
Popper
R. Karl, IL MONDO DI PARMENIDE, Piemme, Milano 1998
34.
Popper
R. Karl, LA LOGICA DELLA SCOPERTA SCIENTIFICA. IL CARATTERE AUTOCORRETTIVO
DELLA SCIENZA, Einaudi, Torino 1970
35.
Popper
R. Karl, LA SOCIETA’ APERTA E I SUOI NEMICI, vol. 2, Armando, Roma 1973/1974
36.
Popper
R. Karl, CONOSCENZA OGGETTIVA, Armando, Roma 1983
37.
Popper
R. Karl, POSCRITTO ALLA LOGICA DELLA SCOPERTA SCIENTIFICA, Il Saggiatore,
Milano 1984
38.
Popper
R. Karl, VERSO UNA TEORIA EVOLUZIONISTICADELLA CONOSCENZA, Armando, Roma 1994
39.
Pringle
Heather, LE ORIGINI DELLA CREATIVITA’, in “le Scienze”, maggio 2013, pag.35
40.
Quine William van Orman, EPISTEMOLOGIA
NATURALIZZATA, in RELATIVITA’ ONTOLOGICA ED ALTRI SAGGI, Armando, Roma 1986.
41.
Redazione, I NEURONI SCELGONO TRA GENI MATERNI E PATERNI, in “Le Scienze”, 27
febbraio 2017, n.3, marzo 2017
42.
Rumelhart D. McClelland , DPD. MICROSTRUTTURA DEI PROCESSI
COGNITIVI, Il Mulino, Bologna 1991
43.
Russell
Bertrand, IL POTERE, Feltrinelli, Milano 1981
44.
Schiff
J. L., ANALISI TRANSAZIONALE E CURA DELLE PSICOSI, Astrolabio, Roma, 1980
45.
Taleb
Nassim Nicholas, IL CIGNO NERO, Il Saggiatore, Milano 2014
46.
Van
Forester Heinz, NON SAPERE DI NON SAPERE, in
Ceruti Mauro e Petra Lorena (a cura di), CHE COSA E’ LA CONOSCENZA,
Laterza, Bari 1990
47.
Wilson
O. Eduard, LA CONQUISTA SOCIALE DELLA TERRA, Raffaello Cortina, Milano 2013
48.
Zolo
Danilo, IL PRINCIPATO DEMOCRATICO: UNA TEORIA REALISTICA DELLA DEMOCRAZIA,
Feltrinelli, Milano 1992
[1] Giorello Giulio, L’ETICA DEL
RIBELLE, Laterza, Bari 2017
[2] Agostinelli Mario, Rizzuto Debora,
IL MONDO AL TEMPO DEI QUANTI, Mimesis, Milano 2016
[3] Cattaneo Elena, OGNI GIORNO,
Mondadori, Milano 2016
[4] Tomasello Michael, STORIA NATURALE
DELLA MORALE UMANA, Raffaello Cortina Editore, Milano 2016
[5] Pizzuti Marco, EVOLUZIONE NON
AUTORIZZATA, Il Punto D’Incontro, Vicenza 2016
[6] Audi Robert, EPISTEMOLOGIA,
Quodlibet Studio, Macerata 2016
[7] Ceci Alessandro, COSMOGONIE DEL
POTERE, Ibiskos, Empoli 2011
[8] Popper R. Karl, LA SOCIETA’ APERTA
E I SUOI NEMICI, vol. I Eii, Armando; Roma 1986
[9] Ceci Alessandro, INTELLIGENCE E
DEMOCRAZIA, Rubettino, Soveria Mannelli, 2006
[10]
Losee John, FILOSOFIA DELLA SCIENZA, Il Saggiatore, Milano 2016
[11]
Loose J., cit. 2016
[12]
Loose J., cit. 2016
[13] Loose J., cit. 2016
[14]
Loose J., cit. 2016
[15] Husserl Edmund, LA CRISI DELLE
SCIENZE EUROPEE E LA FENOMENOLOGIA TRASCENDENTALE, Il Saggiatore, Milano 2015
[16] Plessner Helmut, I GRADI
DELL’ORGANICO E L’UOMO,Bollati Boringhieri, Torino 2006
[17] Piaget Jean, EPISTEMOLOGIA
GENETICA, Laterza, Bari 2000
[18] Prigogine Ilya, LA FINE DELLA
CERTEZZA, Bolati Boringhieri, Torino 2014
[19] CNITE – Centro Nazionale Italiano
sulle Tecnologie Educative
[20] Wilson Edward, LA CONQUISTA
SOCIALE DELLA TERRA, Raffaello Cortina, Milano 2013
[21] Husserl E., cit., Milano 2015
[22] Husserl E., cit., Milano 2015
[23] Husserl E., cit., Milano 2015
[24] Husserl E., cit., Milano 2015
[25] Husserl E., cit., Milano 2015
[26] Husserl E., cit., Milano 2015
[27] Husserl E., cit., Milano 2015
[28] Husserl E., cit., Milano 2015
[29] Husserl E., cit., Milano 2015
[30] Husserl E., cit., Milano 2015
[31] Husserl E., cit., Milano 2015
[32] Husserl E., cit., Milano 2015
[33] Husserl E., cit., Milano 2015
[34] Husserl E., cit., Milano 2015
[35] J. Piaget, Introduction
à l'epistemologie généttque, voi. I, P.U.F., Paris 1972^, p. 37.
[36] Per motivare le ragioni
dell'epistemologia genetica, svolgendo un'analisi critica delle altre forme
storiche di epistemologia e in particolare del neopositivismo, si veda J.
Piaget, L'épistémologie et ses varìétés, in Id., Logique et
connaissance scientifique cit.
[37] Giorello Giulio, FILOSOFIA DELLA
SCIENZA, Jaca Book, Milano, 1992.
[38] Piattelli
Palmarini M.(a cura di), Théorìe du language, Théorie de l'apprentissage. Le àébat entre Jean Piaget et Noam
Chomsky, Seuil, Paris
1979; J.M. Dolle, Au-delà de Freud et de Piaget, Privat, Toulouse, 1987.
[39] Cfr. H. von
Foerster, A constructivìst epistemology, in «Cahiers de la Fondation Archives Jean Piaget», 2-3, 1982.
[40] J. Piaget,
Introduction à l'epistemologie génétique, cit., p. 45. Ciò che Edgar Morin intende con
'epistemologia complessa' converge con la prospettiva qui delineata: «Ci sono
delle istanze che consentono di controllare la conoscenza; ciascuna è necessaria;
ciascuna è insufficiente». (E. Morin, Epistemologie de la complexité, in
C. Atias, J.L. Le Moigne [éds.], Edgar Monti. Science et conscience de la
complexité, Librairie de l'Université, Aix-en-Provence 1974, pp. 65-66). Queste istanze rimandano alla mente, al
cervello, alle condizioni bio-antropologiche, alle condizioni socioculturali,
all'ideologia, alla noologia, alla paradigmatologia, alla logica, e quindi alla
conoscenza scientifica... «E il problema dell'epistemologia è di fare
comunicare queste istanze separate; è, in certo senso, di fare il circuito.
[...] Non ci sono privilegi, troni, sovranità epistemologiche; i risultati
delle scienze del cervello, della mente, delle scienze sociali, della storia
delle idee ecc., devono retroagire sullo studio dei principi che determinano
tali risultati. Il problema non è che ciascuno perda la propria competenza. E
che la sviluppi abbastanza per articolarla su altre competenze che, legate in
catena, formerebbero un anello dinamico, l'anello della conoscenza della
conoscenza» (ivi, pp. 77-78).
[41] Cfr. L. Gallino, L'incerta alleanza, Einaudi,
Torino 1992; E. Morin, Il metodo, Feltrinelli,
Milano, 1983; E. Morin, La conoscenza
della conoscenza, Feltrinelli,
Milano 1989; E. Morin, Introduzione
al pensiero complesso, Sperling
& Kupfer, Milano 1993; G. Bocchi,
M. Ceruti (a cura di), La sfida della complessità, Feltrinelli,
Milano, 1985.
[42] Maturana e valera, auto poiesi e
cognizione
[43] J. Piaget, Logique
et connaìssance scientifique cit., p. 1244.
[44] F.
Varela, Piaget: una conduzione orchestrale per la scienza cognitiva
moderna, in M. Ceruti (a cura di), Evoluzione e conoscenza, Lubrina,
Bergamo 1992, p. 76. Per un approfondimento della questione si veda F. Varela,
E. Thompson, E. Rosch, La via di mezzo della conoscenza, Feltrinelli,
Milano 1992; F. Varela, Un know-how per l'etica, Laterza, Roma-Bari
1992.
[45] Prigogine Ilya, cit. 2014
[46]
James William, LA VOLONTA’ DI CREDERE, Principato, Milano 1969
[47] Prigogine Ilya, cit. 2014
[48] Prigogine Ilya, cit. 2014
[49] Prigogine Ilya, cit. 2014
[50] Prigogine Ilya, cit. 2014
[51] Prigogine Ilya, cit. 2014
[52] Prigogine Ilya, cit. 2014
[53] Prigogine Ilya, cit. 2014
[54] Prigogine Ilya, cit. 2014
[55] Prigogine Ilya, cit. 2014
[56] Tomasello Michael, STORIA NATURALE
DELLA MORALE UMANA, Raffaello Cortina Editore, Milano 2016
[57] Agostinelli Mario e Rizzuto
Debora, IL MONDO AL TEMPO DEI QUANTI, Mimesis, Milano 2016
[58] Dipartimento di Scienze
Biomolecolari, RELAZIONE SCIENTIFICA FINALE, Urbino marzo 2012
[59] Dipartimento di Scienze
Biomolecolari, cit., 2012
[60] Dipartimento di Scienze
Biomolecolari, cit., 2012
[61] Dipartimento di Scienze
Biomolecolari, cit., 2012
[62] Popper R. Karl, VERSO UNA TEORIA
EVOLUZIONISTICA DELLA CONOSCENZA, Armando Editore, Roma 1994
[63] Popper, cit. 1944
[64] Popper, cit. 1944
[65] Popper, cit. 1944. Le probabilità
che al lancio di un dato esca un numero pari è 1 diviso il numero di tutte le
possibilità tra l’usita di un numero pari e un numero dispari, che appunto sono
2. ½ = 0,5. « ho il 50% di probabilità che esca un numero pari al lancio di un
dato o della pallina della roulette.
[66]
Popper, cit. 1944
[67]
Popper, cit. 1944
[68]
Popper, cit. 1944
[69]
Popper, cit. 1944
[70]
Popper, cit. 1944
[71]
Popper, cit. 1944
[72]
Popper, cit. 1944
[73]
Popper, cit. 1944
[74] Popper, cit. 1944
[75] Nel caso della ricerca del gruppo
di Massimo Cocchi possiamo sostenere
che, se la individuazione – tramite il marker biologico – della depressione
scatenante in suicidio si trasforma in individui depressi in un incremento dei casi di suicidio e ciò
accade – data la costante certificazione delle piastrine compromesse – in
condizione di diverso habitat sociale, esiste una certa stabilità del
dato.
[76] Popper, cit. 1944
[77] Popper, cit. 1944 Questo
stabilisce un elemento assai affascinante della ricerca del gruppo Cocchi e specificamente sui
risultati dati dalla applicazione della rete neurale. La rete SOM utilizzata ha
automaticamente polarizzato i depressi da una parte e i bipolari,
dall’altra. Tra i due poli estremi ha
individuato molteplici integrazioni intermedie, commistioni dell’uno e
dell’altro in cui, di volta in volta,l’uno è più incisivo dell’altro. Il che
significa si è definito un intervallo di sostenibilità in cui ovviamente
gli estremi sono radicalizzati in condizioni di quasi insostenibilità, mentre
all’interno dell’intervallo abbiamo molteplici casi in cui depressione e
bipolarità sono integrate e, paradossalmente, relativamente sostenibili, in
funzione della reciproca incisività. Per me, che sono il teorico dell’intervallo
di sostenibilità, il fatto che una rete neurale lo abbia automaticamente
evidenziato è un elemento di estremo fascino.
[78] Finora perché, se è vera la
ricerca del gruppo Cocchi, tra qualche tempo la depressione potrà essere
individuata con una semplice analisi del sangue.
[79] Diamond Jared e Robinson James (a
cura di), ESPERIMENTI NATURALI DI STORIA, Edizioni Le Scienze, Roma 2017
[80]
Diamond J. E Robinson J. (a cura di), cit. 2017
[81] Popper, cit. 1944
[82] Agostinelli M. e Rizzuto D., cit.
2017
[83] Agostinelli M. e Rizzuto D., cit.
2017

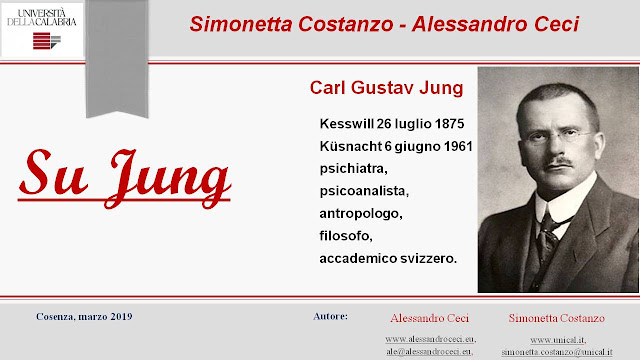
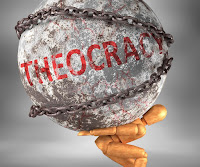

Commenti
Posta un commento