1 - Epistemica dell'inizio
incertezza
nella presa di posizione conoscitiva
Non pubblicherò il mio nuovo libro
in una versione cartacea. Lo pubblico qui, un capitolo ogni sabato. Si intitola
"Epistemiche" e si compone di articoli che rappresentano i capitoli.
Chi vuole partecipare può scrivere una sua epistemica, cioè un suo articolo,
che diventerà un capitolo del libro. Ciascuno, se lo desidera, può archiviare i
capitoli settimana dopo settimana e avrà, alla fine composto l'intero libro.
Solo alla fine valuteremo se sarà il caso di farne una versione cartacea.
Grazie
La probabilità che ha la verità di affermarsi è
data dalla sua capacità di incorporare realtà.
Premessa
Non
abbiamo altra possibilità che “considerare
l’esigenza di conoscere la conoscenza un tema classico della storia del
pensiero”[1].
Per alcuni addirittura questo sarebbe il problema scientifico genetico: quello
che, da Talete a noi, ha dato origine al mix di filosofia e scienza da cui
tutte le discipline si sono poi differenziate.
Si tratterebbe di una sorta di Big Bang centrale, anzi di un doppio big
bang come ipotizzano le più recenti teorie astronomiche.
Sta
di fatto che da allora ad oggi, la conoscenza è stata considerata o come rappresentazione
o come percezione o come costruzione della realtà. Noi qui
sosterremo che la conoscenza, con l’avvento della società della comunicazione,
è diventata incorporazione della realtà; e che questa capacità è un potere
politico, non nuovo ma di una potenza inusitata e unica che, sia in termini di
percezioni che in termini di rappresentazione, espande o riduce, potenzia o
depotenzia la dimensione cognitiva dell’umano.
Ormai
sappiamo bene come funziona questo potere irreversibile di carattere
epistemologico. La sua azione politica consiste nel produrre macro
events, eventi che vengo classificati come simbolicamente
rappresentativi, per governare e condizionare i nostri individuali e personali micro
events, gli eventi e i comportamenti
(imprescindibili ma determinanti) della nostra vita quotidiana[2].
In
altri testi[3]
ci siamo dedicati alla articolata descrizione del potere epistemologico nella
società della comunicazione. Qui trattiamo soltanto la questione epistemologica
che, tuttavia, è la questione derimente perché è l’unica che può stabilire uno
o più metodi per tentare di distinguere il vero dal falso (Statuto
epistemologico) e, quindi, l’unico strumento di effettivo controllo democratico
del potere contemporaneo.
In ogni caso, oltre il fatto inusitato del potere di costruzione di scenari di verità, resta la connotazione tipicamente umana di indagare per conoscere, che trasforma l’eccentricità in accrescimento e l’accrescimento in eccentricità. Non c’è dubbio che dobbiamo avere come insuperabile punto di riferimento la socratica conoscenza della nostra ignoranza; e meglio ancora se, come ci ha insegnato Heinz Von Forester[4], la consideriamo come elemento imprescindibile, strutturale e connotativo del soggetto, piuttosto che come semplice atteggiamento mentale. Tuttavia, non possiamo trascurare il fatto che, tra tutte le specie dei viventi noti, siamo quelli che conosciamo di più, non fosse altro perché, conosciamo la conoscenza.
E
ci interroghiamo su di essa.
Molte
volte ci siamo trovati a pensare se e quanto utili fossero questi studi così
teorici e immateriali alle esigenze della nostra vita quotidiana. Quanto, ci
chiediamo, è necessario e controproducente, questa dipendenza al pensiero dei
processi invisibili della conoscenza e della conoscenza della conoscenza,
questo “ragionar di nubi”, questo
vagabondare tra intuizioni che si trasforma in un viaggiare tra teorie, questo
vagare tra l’essenza fenomenologica dell’umano; quanto fosse utile tutto questo
pensare il pensiero alla nostra esistenza concreta, singolare ed unica di
individuo che oggi è in ogni luogo a sopravvivere. Molte volte ho avuto dubbio
di fronte alla arcigna precarietà finanziaria, ai problemi della vita pratica e
alla comodità della ricchezza, alla esaltazione del successo e alla presunzione
del potere; se piuttosto non avessero ragione gli altri, i tanti consiglieri
del pratico, i sacerdoti dell’utilità, nemmeno dell’utilitarismo, i
professionisti della contabilità, i tecnici del vantaggioso, le madri vili che,
come le ha descritte Pasolini, ci hanno detto “Pensate a voi! / Non provate pietà o rispetto / per nessuno, covate nel
petto / la vostra integrità di avvoltoi!”[5].
Molte
volte abbiamo dubitato. Talvolta abbiamo anche tentato di disintossicarci da
questa dannata dipendenza al pensiero scientifico e filosofico, dalla emozione
letteraria e dal rigore logico che, per noi, epistemologia ed ermeneutica
rappresentano. Altrettante volte abbiamo fallito, ogni volta che abbiamo
tentato di raggiungerli o di seguirli o di imitarli, abbiamo fallito con grande
discapito professionale e più grande deficit personale. Sempre, alla fine,
siamo tornati all’infantilismo dello scrittore e alla inadeguatezza
imbarazzante dello scienziato che non riesce proprio a comprendere lo sforzo
del mondo alla futilità e il definitivo, ossessionante successo della cronaca
sulla storia. Poi, in silenzio, da soli, spesso ci siamo chiesti se ci fosse un
senso al godimento ostentato di una vita consumata che noi invece non riusciamo
ancora a capire, a questa età. Certo che tra la precarietà e l’incertezza della
vita quotidiana, viviamo scomodi. Ma staremmo meglio nella “diuturna fatica dell’ambizione personale”[6]?
Staremmo meglio se vivessimo nella ossessione della supremazia e nella
esaltazione dell’egocentrismo ipertrofico dei protagonisti?
Certamente
no. Saremmo notevolmente più stanchi. Per noi abbiamo scelto allora di godere
una vita fruita, di cercare un significato nelle cose, di fare della conoscenza
l’essenza della nostra esistenza. Tuttavia, questa decisione, questa etica
individuale, non elimina la sensazione di inutilità che avvolge inevitabilmente
la parola e il rigoroso suo articolarsi in un teorema.
Finché
a settembre, una mattina, nel mese del ripensamento, mentre camminavamo, da
soli, parlando nel parco del Campus dove lavoriamo, tra una telefonata e una
riunione, mentre camminavamo
favoleggiando di una possibile fortunata vincita, una vincita qualsiasi,
generosa, di una qualsiasi lotteria, un qualsiasi evento casuale che fosse in grado di cambiare definitivamente il
nostro status economico, ancora fanciulli e dunque scienziati tra immaginazioni
e sogni, soli e lentamente, mentre camminavamo, abbiamo capito che nulla è più
utile di pensare il nulla.
Tra
qualche miliardo di anni il sole che illumina il nostro passo qui, ora, si
spegnerà definitivamente. Nella nostra galassia avrà vita in un’altra vita e la
nostra presenza nell’universo potrà essere semplicemente cancellata ignota e,
inevitabilmente, ignorata. Di tanti
contro futuri possibili, se lasciamo le cose andare verso la nostra
indifferenza utilitaristica, quello sarà certamente il punto di fine, appunto
il nulla irreversibile che è la morte.
L’unica
possibilità che abbiamo è cercare di indirizzare l’evoluzione verso una ipotesi
di futuro che non contempli il nostro annullamento. Questi miliardi di anni sono un capitale che
non dobbiamo e non possiamo dilapidare. Dobbiamo investirli sulla nostra
sopravvivenza, piuttosto. Possiamo
realizzare il sogno fantascientifico di migrare in altri sistemi stellari, in
altre galassie, in altri mondi fors’anche più piacevoli e salubri di quanto non
sia questo nostro compromesso da scorie nucleari e inquinamento ambientale.
Oppure possiamo risolvere il problema della fissione nucleare e dotarci di soli
portatili, urbani, metropolitani e domestici; o anche di un sole nuovo,
sostitutivo di quello esistente e più duraturo; o infine trovare la formula di
rivitalizzazione della stella che ci riscalda. Abbiamo qualche migliaio di anni
per trovare una soluzione. Non sono molti. Non possiamo perdere tempo con la
blanda amenità del nostro accomodamento.
L’unica
possibilità che abbiamo è dedicare il nostro impegno a fare in modo che un
giorno qualcuno troverà la soluzione; con il patrimonio delle conoscenze che ci
siamo tramandati; in un futuro che probabilmente non ci ricorderà, ma che
comunque sarà come oggi noi contribuiamo a costruire e che, per questo, ci
trasporterà nel background del suo ultimo pensiero. Perché quell’ultimo
pensiero non sarà, non potrà essere un’intuizione venuta da niente. Potrà
essere istintiva. Potrà anche nascere senza un percorso razionale, in modo
occasionale e improvvido. In ogni caso non sarà improvvisa. Sarà comunque il
prodotto di una elaborazione secolare, addirittura millenaria, anche
discontinua, ma costante, un lavoro irrefrenabile del pensiero dialogico, una
comunicazione critica intensa a cui dobbiamo contribuire, sbagliando, con
errori che risolvono altri errori, che si carica in ogni scambio relazionale e
in ogni confronto tra ipotesi e modelli teorici e che si depotenzia solo quando
si rinuncia. Proprio la potenza della
intelligenza collettiva, questa elaborazione cognitiva reticolare, il valore
aggiunto del network integrato della ignoranza che si implementa
indipendentemente dagli errori, anzi, grazie agli errori, noi dobbiamo
contribuire ad accrescere per garantire all’umanità una soluzione interna ad un
intervallo di contro futuri possibili che comunque contemplino la nostra
presenza nell’universo. E dunque la nostra memoria. E dunque la nostra
immortalità.
Ora
sappiamo che l’unica possibilità pratica per salvarci, l’unica opzione di
sopravvivenza è la conoscenza. Agli umani è riservata la responsabilità di
tutela della terra e di ogni sua forma di vita, poiché sono solo gli umani a
conoscere la conoscenza: gli unici eccentrici. Troveremo una soluzione
tecnologica (un’arca intergalattica che ci trasporti chissà dove) o scientifica
(la scoperta che evita l’esplosione o l’implosione delle stelle); ma quella
soluzione, se la troveremo da soli, non potrà che essere fondata sulla logica e
sul metodo. Sono queste le nostre
connotazioni fondamentale e dunque queste soltanto potremo utilizzare. La soluzione finale per la nostra
sopravvivenza sarà inevitabilmente una verità scoperta o costruita con una
metodologia. Quindi, soltanto la scelta etica di oggi per la genetica della
vita fruita contro la morte della vita consumata può garantirci l’intervallo
dei controfuturi della nostra universale presenza. In fin dei conti,
allora, soltanto la soluzione epistemologica di oggi potrà garantire la
sopravvivenza dell’umanità. In ogni
istante della nostra vita, abbiamo di fronte a noi la soluzione finale della
nostra vita. In ogni ora della nostra giornata, in ogni affannoso minuto della nostra
ora decidiamo per un intervallo di controfuturi con o senza gli umani.
In ogni attimo del nostro respiro tuteliamo l’infinito respiro dei nostri
attimi.
E
se permettete, quello della nostra immortalità è una questione seria.
[1] Ceruti M. e Petra L.
(a cura di), Che cosa è la conoscenza, Laterza, Bari 1990
[2] Ceci A., Scenari di verità, I Quaderni
del Campus, Pomezia 2009
[3] Ceci A., Intelligence e democrazia,
Rubettino, Soveria Mannelli,2006; Ceci A., La Relazione Responsiva,
Europarole, Roma 2020, Ceci A., Ceci E., Ricognizione della democrazia, Nep
Edizioni, Roma 2022
[4] Van Forester H., Non
sapere di non sapere, in Ceruti M. e Petra L., cit. 1990
[5] Pasolini P. P., La
ballata delle madri, in Bestemmia, Garzanti, Milano 1995
[6] Yourcenar M., Le
memorie di Adriano, Mondadori, Milano 1988




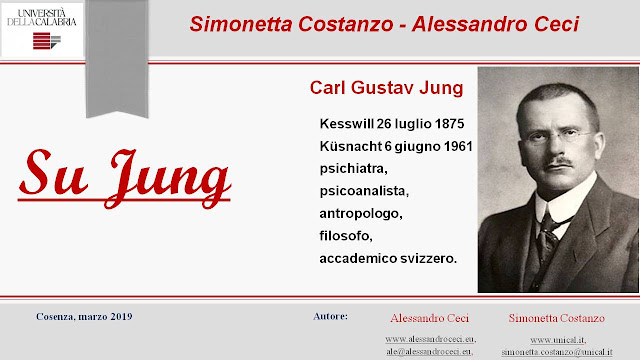
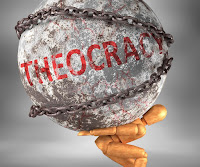

Commenti
Posta un commento