4 - Epistemica della Intelligenza Artificiale
maggio
duemilaveniquattro
Non credo
che Jean Piaget, quando sostenne che “l’intelligenza organizza il mondo
organizzando sé stessa”[1],
pensasse all’intelligenza artificiale.
L’affermazione
sintetizza molto bene il complessivo elaborato della sua epistemologia e,
difatti, comparve in un testo, per noi, del 1979, pochi anni prima della sua
morte; avvenuta ad 84 anni il 16 settembre del 1980. In quel periodo, come
tutti Piaget, cercava una sintesi conclusiva del suo lavoro. Inutilmente,
perché una sintesi conclusiva non c’è mai, per nessuno. In ogni caso, egli
intendeva sostenere che siamo noi i fenomeni, costantemente in simbiosi, più o
meno pervasiva, con il nostro habitat.
Secondo
l'epistemologo Ernst con Glasersfeld, Piaget, assieme a molti altri autori, da
Eraclito a Dewey, è un significativo esponente del “costruttivo radicale”;
di quel paradigma teorico che, in estrema sintesi, sostiene la fondante azione
umana nella fondamentale cognizione della realtà. In altri termini il problema
è: siamo noi a costruire la realtà o è la realtà a formare noi? Il “costruttivo
radicale” attribuisce a noi la responsabilità (o addirittura la esclusiva
possibilità) di conoscere e generare - generare perché lo si conosce - l’esistente
noto. Siamo noi che costruiamo ciò che sappiamo.
Un po’ meno
certo di essere un costruttore del conosciuto e, peggio ancora, del conoscibile,
ho preferito utilizzare il concetto di “simbiosi” proposto alla
letteratura scientifica da Lynn Margulis. Viviamo, cioè, in reciproca
connessione, noi, il nostro habitat e l’ambiente. Noi siamo un coacervo di
esperienza e conoscenza, psiche, logica e fisicità, la dialettica irrefrenabile
tra desiderio e godimento, come diceva Lacan. Il nostro habitat è, invece, la
multifunzionale integrazione tra azione, relazione, organizzazione e tecnologia
che nella storia ha assunto di volta in volta la forma idealtipica di comunità,
società, sistemi e network. L’ambiente è tutto il resto, la fisica di ogni
fenomenologia nella sua dimensione caotica, complessa o semplice.
Però, non
aveva torto Jean Piaget a collegare irreversibilmente la costruzione della
nostra intelligenza alla organizzazione della nostra esistenza. Solo che lui
non considerava assolutamente l’intelligenza come un artificio, non artefatto, non
artificiosa e non artificiale, ma naturale, nella sua insostituibile dimensione
biologica e sociale.
Da qualche
anno sappiamo che è proprio così.
Circa dieci
anni fa, gli scienziati del King’s College di Londra, in una ricerca denominata
“Molecular Psychiatry”, hanno sostenuto di aver identificato uno dei
cosiddetti “Geni dell’intelligenza”. In realtà, non è proprio così e gli
stessi ricercatori hanno subito indotto alla cautela. Loro hanno scoperto
soltanto una porzione del codice genetico che ancora giustifica le dimensioni,
in termini di spessore e di estensione, del cervello; ma la quantità della materia
grigia non corrisponde automaticamente al livello della nostra intelligenza. La
nostra intelligenza in realtà è la risultante della triangolazione di
molteplici fattori genetici, di habitat e ambientali.
La stessa
scoperta, forse epistemologicamente più giustificata, è stata realizzata dagli
scienziati americani della Yale School of Medicine che, dopo aver
compiuto diverse analisi genetiche, hanno individuato una lieve variazione di
appena due lettere di un singolo gene LAMC3 negli oltre tre milioni dell’alfabeto
genetico umano. LAMC3 consentirebbe lo sviluppo dell’intelligenza potenziale
del cervello umano, in qualità di primarie connotazioni come, ad esempio, il
ragionamento razionale e astratto, la memoria, l’attenzione e lo stato vigile,
il pensiero, il linguaggio e la coscienza. LAMC3 avrebbe dovuto, con evidenza
clinica, con simili variazioni riscontrate in altri pazienti nella medesima
condizione clinica, risolvere il mistero della genesi e della evoluzione (o
della involuzione nella malattia) dell’intelligenza umana. Non lo ha fatto.
Da allora ad
oggi, ciclicamente spunta qualche scienziato che, con intollerabile
atteggiamento lombrosiano, ha scoperto il gene dell’intelligenza, della
timidezza, dell’arte, dell’autismo, dell’omosessualità, della criminalità,
della predisposizione a quella o quell’altra malattia. Non basta, infatti, uno
sperimentale screening genetico per conoscere l’essenza della nostra esistenza.
Non basta la clinica e, principalmente, non si può lobotomizzare la vita per
comprendere la vita. Il fenomeno è come appare[2].
Se lo scompongo non è più lo stesso fenomeno; decostruendo le parti si rischia
di perdere le connessioni formative che determinano la complessità
fenomenologia dell’esistenza.
La genetica
non riesce spiegare da sola la nostra intelligenza[3].
Figurarsi se
può farlo la tecnologia.
La nostra
intelligenza in realtà è la risultante della triangolazione di molteplici
fattori genetici, di habitat e ambientali.
Chiara Valerio racconta[4] che Lev Davidovič Landau, premio Nobel per la fisica nel 1962 e Medaglia Max Planck nel 1959, affermava che non importa cosa sia che muove le cose. Egli “definisce forza ciò che fa cambiare” lo stato delle cose. E Lei conclude: “La forza è la causa ma noi viviamo immersi negli effetti”. Quanto è distante questa interpretazione dalla affermazione di Piaget del 1979 in cui si considera la intelligenza che cambia le cose e riorganizza il mondo per riprodurre sé stessa in modo sempre più ampio e pervasivo.
Quanta
distanza c’è tra questa percezione di una fenomenologia strutturata sul
rapporto causa/effetto e invece la percezione di Piaget che ci ha trasmesso
l’immagine di una intelligenza che ci avvolge. E ci coinvolge. Non una quantità
che sta dentro di noi, conteggiabile in un qualsiasi test, ma una qualità che
sta intorno a noi. Siamo tutti dentro l’intelligenza del mondo. E invece noi,
contrariamente abbiamo sempre pensato e ancora pensiamo che l’intelligenza sia
contenuta in una scatola, sia essa cranica o metallica. Abbiamo sempre pensato
che l’intelligenza fosse, talvolta anche oltre il connotato fisico, organico,
un modo di interpretare le cose, una azione cognitiva verso le cose.
Secondo Luciano Floridi, l’Intelligenza Artificiale “è una nuova forma di agire” [5]. Personalmente preferisco sostenere che sia un nuovo modo di re-agire. La differenza sembra piccola, fors’anche banale, ma non lo è affatto. Si tratta di una classica biforcazione: più procediamo verso una migliore comprensione e più percepiamo le distanze.
Secondo
Luciano Floridi, l’Intelligenza Artificiale “è una nuova forma di agire” [6].
Personalmente preferisco sostenere che sia un nuovo modo di re-agire. La
differenza sembra piccola, fors’anche banale, ma non lo è affatto. Si tratta di
una classica biforcazione: più procediamo verso una migliore comprensione e più
percepiamo le distanze.
Secondo Luciano Floridi, inoltre: “Una maggiore potenza di calcolo e una maggiore quantità di dati hanno reso possibile il passaggio dalla logica alla statistica. Le reti neurali che erano interessanti da un punto di vista teorico [...] sono diventati strumenti ordinari nell'ambito dell'apprendimento automatico. La vecchia IA era per lo più simbolica e poteva essere interpretata come una branca della logica matematica, ma la nuova IA è principalmente connessionista e potrebbe essere interpretata come una branca della statistica. Il principale cavallo di battaglia dell'IA non è più la deduzione logica ma l’inferenza è la correlazione statistica.”[7].
Ora, siamo
sicuri che: apprendimento automatico, connessione, inferenza e perfino
correlazione siano “una branca della statistica”?
Forse no.
Certamente non siamo più soltanto nella logica matematica, e non più nemmeno soltanto nella logica computazionale. Oggi siamo anche, se non principalmente, nella logica quantistica e questo è, come diceva Marcel Mauss, “un fatto sociale totale”[8] della nostra epoca e non la tecnologia. Se questo è corretto, come ovviamente credo, tutto, anche l'IA, deve essere considerata, non una semplice azione[9], ma una relazione[10].
Agire è una spinta, un moto proprio, autonomo anche solitario.
Re-agire presuppone
una relazione, una risposta, un feed-back, un rapporto almeno tra due.
È la stessa
differenza che c’è tra informazione e comunicazione. L’informazione è
un’azione, un flusso anche indipendente da chi ascolta, una press ione che tenta
di omologare e talvolta anche asservire l’audience a sé, di trasformare il
cittadino in utente, come fa la televisione. La comunicazione, invece, è
un feed-back, presuppone una relazione, la risposta dell’altro, definisce un
network di scambi semantici sebbene spesso su una comune sintattica, su una
reciproca piattaforma di confronto, come accade per i social.
È una
differenza che fa tutta la differenza.
La
conoscenza, per come l’abbiamo considerata finora, nelle scuole e nei media, è
pura informazione, la nostra possibilità di agire, il nostro andare verso le
cose in modo unidirezionale. Infatti,
Edmund Husserl consigliava una epistemologia che si riferisse alle cose stesse,
così come sono, come le percepiamo.
L’Intelligenza
Artificiale oggi offre agli umani di tornare alla loro competenza comunicativa,
ci offre la possibilità di re-agire nella crescente complessità dell’esistente.
Una complessità, nonostante i molteplici nostri irrefrenabili tentativi,
inafferrabile nella sua interezza, ma che ci avvolge, ci circonda
E, dunque, ci consente di reagire, cioè di entrare inevitabilmente in una relazione multidimensionale e sempre biunivoca con il nuovo mondo, perché l’Artificio Tecnologico simula l’Intelligenza solo quando, come noi, entra in relazione con l’uomo, con il suo habitat e con l’ambiente. Altrimenti resta un sofisticato contenitore di dati. Per questo motivo non possiamo identificare l’IA con una macchina, con un robot, o con uno o più algoritmi. L’IA si definisce e si evidenzia, piuttosto, in modo diffuso, in una serie di connessioni tra poli, e di vuoti entro cui può sprofondare la nostra solitaria individualità se non addirittura la nostra intera civiltà. L’IA è un network a morfologia variabile, come dico io, che viene di volta in volta ri-clusterizzato e ri-assemblato, in funzione delle nostre esigenze problematiche. L’IA non si restringe a un processore. Si diffonde nell’ovunque, è la nostra stessa intelligenza ri-organizzata, non una intelligenza-altra, esterna ed estranea a noi; come scrive Francesco Parisi[10], le nuove tecnologie dell’IA siamo noi che ci avvaliamo di una serie di strumenti utili alla governance della nostra complessità. Perché il vero artificio del mondo che conosciamo è la nostra intelligenza, non quella delle macchine. Ciò che non sappiamo fare, tutte le nostre paure, non derivano dalla invadenza o dalla invasione di macchine incontrollabili, ma dalla nostra incapacità di vivere con una intelligenza che ci avvolge. E inevitabilmente ci coinvolge. La nostra conoscenza non deve riferirsi alle cose stesse per una migliore oggettivazione, deve sapersi connettere imparare a vivere nelle cose stesse per una più opportuna giustificazione. Il fatto sociale totale della società della comunicazione in cui siamo ormai definitivamente immersi non è la IA, ma l’acquisizione della logica quantistica la quarta dimensione cognitiva dell’umano.
Essere nelle cose stesse significa essere in simbiosi con i fenomeni della nostra esistenza passata, presente e futura. La logica quantistica è il connotato di questa nuova epoca e si mostra e si dimostra anche nella Intelligenza Artificiale. Ciò che davvero temiamo è la capacità di acquisire e fronteggiare questa nuova dimensione dell’umano e trasferiamo nelle macchine, il simbolo e il simulacro della nostra impotenza. Noi non agiamo ma re-agiamo perché siamo, siamo sempre stati, in simbiosi con i fenomeni che ci travolgono, la complessità che ci preoccupa è vivere nelle cose stesse. Non c’è niente distante da noi. Noi siamo dentro il divenire del mondo, dentro la sua complessità e temiamo, profondamente temiamo, che ci travolga. Denunciamo, con la preoccupazione degli strumenti, la paura della nostra profonda inadeguatezza. La logica quantistica ci induce a capire che, per esistere (e a maggior ragione per resistere), dobbiamo saper essere nelle cose stesse. In simbiosi con il mondo[13].
Per prima
Lynn Margulis ha indicato nella simbiosi del mondo (e non la simmetria con il
mondo) l’elemento centrale della evoluzione di tutte le specie viventi note.
L’ha denominata endosimbiosi. Ha contestato il paradigma darwiniano
basato sul processo di adattamento come rapporto singolare individuo/natura.
Per Lynn Margulis l’evoluzione è il prodotto di generali interconnessioni,
l’endosimbiosi è una condizione sociale rafforzata dalla interazione cooperativa
interna al gruppo dei pari, una “dipendenza mutuale”. “La vita –
afferma – non colonizzò il mondo attraverso il combattimento, ma per mezzo
della interconnessione”[14].
È questo già un primo approccio di logica quantistica, che interpreta i
fenomeni che percepiamo, non sulla base delle regole deterministiche della
simmetria, ma sulla base dei principi stocastici della simbiosi. “Noi viviamo insieme (dal greco symbiôun),
tutti, in ogni dimensione del vivente e anche del non vivente. Nessuno può
sopravvivere senza l’altro, senza l’habitat, senza l’ambience, senza
l’ambiente. Siamo obbligati da una relazione tra simbionti, siamo immersi in
una simbiosi universale.”[15]
Se il mondo cambia il mondo cambiamo anche noi, in un equilibrio
relativo raggiunto per caso e necessità, acquisiamo i connotati cognitivi e
logici di “uno dei possibili equilibri raggiunti all’interno dell’intervallo
simbiotico della vita”[6].
Il mondo
cambia e dal mio punto di vista è cambiato già 4 volte[17].
Intanto
dobbiamo distinguere tra mutamento e mutazione.
Per
mutamento si intende un cambiamento del fenotipo sociale. Come e più dei
singoli organismi le società hanno una serie di caratteri e di caratteristiche,
come ad esempio l’aggregazione familiare, gli usi, i costumi e, in generale, i
comportamenti personali e collettivi, che sono percepibili e osservabili. La
sociobiologia contemporanea distingue questi caratteri in fenotipi negativi,
quelli che cadono in desuetudine e tendono a scomparire nel corso degli anni, e
i fenotipi adattativi, quelli che si riscontrano nell’habitat, si propagano
rapidamente come moda, restano come background culturale e si
solidificano in tradizioni. In ogni caso, il mutamento di una qualsiasi
organizzazione è sempre un cambiamento fenotipico.
Per
mutazione, invece, si intende un cambiamento del genotipo sociale.
Infatti, il cambiamento del genotipo non modifica i caratteri di una
determinata organizzazione, ma la sua connotazione. Si tratta di un cambiamento
dei geni sociali, di una trasformazione strutturale del DNA di una determinata
società. Ad esempio, il modello di vita degli umani passa da migrante a
sedentario, da agricolo a industriale, da fisico a bionico. Una mutazione
cambia dunque definitivamente il corredo genetico di un contesto politico o di
una determinata società.
I
gruppi similari sono quelli che hanno lo stesso genotipo, pur avendo diverso
fenotipo. In sociobiologia, ad esempio, la democrazia francese ha lo stesso
genotipo dalla democrazia americana, pur avendo un diverso fenotipo.
L’epigenetica insegna che con il tempo (cioè con la consuetudine, che consiste
nel depositare in modo ricorrente energia-informazione da una funzione –
fenotipo – ad una struttura – genotipo) è possibile che il fenotipo modifichi
il genotipo di un qualsiasi soggetto vivente (sia esso organismo,
organizzazione, sistema o network), come essenziale processo di adattamento
all’ambiente (epigenetica). Se il soggetto vivente non si adatta rischia
l’estinzione. Possiamo sostenere, dunque, che a cicli ricorrenti (e, in termini
sociali, in intervalli di tempo decrescenti) un soggetto vivente qualsiasi è
sottoposto a mutazioni genotipiche per contenere il surplus di
energia-informazione (entropia) che i mutamenti fenotipici (funzioni)
trasmettono al corredo genetico (struttura), nella dinamica relazionale con
l’habitat e l’ambiente, per adeguarsi al processo di adattamento e garantire la
propria sopravvivenza. Un soggetto vivente qualsiasi; sia esso un organismo,
una organizzazione, un sistema o un network.
Di
mutazioni ne ho individuate solo quattro[18], e tutte scatenate sempre
dallo stesso cromosoma, quello che porta più chiaramente di altri l’intera
informazione genetica, l’unico in grado di governare, di equilibrare o
squilibrare, il processo di adattamento: il potere. Con un linguaggio più
evocativo le ho chiamate le quattro cosmogonie del potere, quelle mutazioni
cioè che ridefiniscono interamente i rapporti con l’universo, il cosmo delle
regole e delle regolazioni, la complessità delle relazioni fenomenologiche in
cui siamo immersi:
1.
dalla conquista della posizione retta alle
piramidi egiziane, l’avvento dell’ontopower, il potere ontologico della
sopravvivenza, l’epoca della logica endofasica;
2.
da Narmer, primo faraone della prima
dinastia egiziana, alle grandi rivoluzioni americana, francese, inglese (e,
forse, quella più distante e reattiva russa), l’avvento dell’egopower,
il potere egocentrico dell’autorappresentanza, l’epoca della logica formale;
3.
dalla rivoluzione industriale alla caduta
del muro di Berlino, in soli duecento anni profondissimi di storia, in cui
siamo passati (per traumi sconvolgenti) dal cavallo al missile, l’avvento del biopower,
il potere del controllo della vita, la cura, la tutela, la gestione dalla culla
alla bara, l’epoca della logica computazionale;
4. dal
crollo del muro e delle torri a noi, l’avvento dell’epipower, il potere
epistemologico dell’autorappresentazione, la verità che produce realtà e anche
la realtà che induce verità, la società della comunicazione e l’intelligenza
collettiva, l’ologramma della conoscenza e le minacce di omologazione, l’epoca
della logica quantistica.
Quattro solo
quattro mutazioni, in una dinamica del potere che è sempre la stessa: garantire
la propria vita, dalla sopravvivenza (ontopower) alla cura (biopower), e
governare l’ambiente, dalla rappresentanza (egopower) alla rappresentazione
(epipower).
Il
punto è che ogni mutazione trasmette a noi (o noi acquisiamo simbioticamente da
essa) una dimensione logica. Dalla prima mutazione, quella della conquista
della posizione alla formulazione di concettualizzazioni prescientifiche e del
mito, abbiamo simbioticamente acquisito la logica endofasica, costruita
interamente sulla analogia empirica, un pensiero pre-razionale che concepiva il
mondo come un qualcosa di indifferenziato, totalmente privo del principio di
non contraddizione aristotelico. Dalla seconda mutazione, quella della
rivoluzione agricola e della formazione di strutture architettoniche e sociali
di ordine gerarchico/piramidale, abbiamo simbioticamente assorbito una nuova
dimensione logica, la logica formale, con l’acquisizione del principio
aristotelico di non contraddizione, il primo pensiero razionale. Con l’avvento
della Rivoluzione Industriale abbiamo assistito alla nascita dei computer,
grazie ai principi della logica computazionale, inventata da Alan Touring. È la
logica che giustifica i nostri computer e il loro linguaggio, cosiddetto Lambda
calcolo, i cui una proposizione è determinatamente vera o
determinatamente falsa, se corrisponde o meno alla realtà.
La
narrazione predominante è, tuttavia, impressionante. Di fronte
alla quarta mutazione della storia intera dell'umanità, l'avvento della società
della comunicazione, il cui “fatto sociale totale” è l'acquisizione della nuova
dimensione della LOGICA QUANTISTICA (di cui scrivo inutilmente da anni), gli
analisti del mondo si occupano e preoccupano di INTELLIGENZA ARTIFICIALE. Questi analisti andrebbero analizzati, perché occuparsi e
preoccuparsi della nuova TECNOLOGIA piuttosto che della nuova LOGICA è
l'esempio più emblematico ed evidente di stupidità naturale.
Spiego meglio.
Mauro Ceruti e Francesco Bellusci[19],
mutuando in qualche modo la interpretazione dialettica di Aldo Gargani[20],
rappresentano l’evoluzione della conoscenza umana (e forse della sua
intelligenza) come lo scontro tra ragionevolezza e razionalità; cioè “periodizzazione
della modernità” distinta in due momenti: “una «prima modernità»,
caratterizzata dall’umanesimo rinascimentale, e una «seconda modernità» segnata
dall’egemonia del razionalismo seicentesco”[21].
Insomma: da una parte, il ragionevole umanesimo; dall’altra, il razionale
illuminismo. La sintesi proposta da Cerruti e Bellusci è il ritorno ad una sola
Ragione, che unisca gli opposti in una nuova dimensione cognitiva, dentro una
epistemologia che ci aiuti a pensare diversamente il futuro, dentro una lebenswelt,
come reclamava Husserl[4], che ci
permetta di “danzare con il pianeta vivente”[22]; una
conoscenza scientifica, cioè, che non destabilizzi l’umano, ma che anzi iscriva
sé stesso “in una relazione di codefinizione, di cotrasformazione e di
coemergenza con la natura”[23].
Cerruti e Bellusci, alla fine, fanno ciò che ci sconsigliano di
fare, attestano ciò che contestano; cioè una sintesi hegeliana banale in cui
religiosamente scompare ogni limite, tutte le divergenze sanate, in una magica
era della nuova conoscenza umana. Alla fine, dunque, Cerruti e Bellusci,
teorici della complessità, semplificano banalmente.
Lasciamo stare: sia perché, come al solito, la dialettica
hegeliana finisce nella illusa certezza di ogni religione; sia perché la
sintesi trascendente è un mondo chiuso e soffocante. Ed io soffro di
claustrofobia.
Le cose sono andate così. Come ci ha insegnato Jung, nonostante
gli inequivocabili limiti, la storia dell’umanità è cumulativa non alternativa.
O almeno è talvolta cumulativa, talvolta alternativa. Perfino il singolo e il
singolare individuo, fin dalla sua nascita e tramite meccanismi ancora ignoti,
è connesso ad un inconscio collettivo costituito da archetipi. E questa connessione è il più grande
contributo epistemologico che Jung ha dato alle chiusure paradigmatiche della
psicologia, resa definitivamente interdisciplinare perché legata alla
complessità dell’habitat della nostra esistenza. La nostra essenza, tramite le
connessioni dell’inconscio collettivo, è la nostra esistenza; ciascuno di noi,
pur nella sua unicità, è il precipitato storico di ciò che siamo stati come
specie vivente, nella lebenswelt, nel pragmatico mondo della vita.
Dunque, la natura della umanità è principalmente cumulativa, meno,
molto meno alternativa; acquisisce continuamente nuove dimensioni come prodotto
della propria esistenza, l’esempio più evidente è rappresentato
dall’esperimento pubblicato su “Le Scienze”.
Che tutti i bambini partecipati all’esperimento conoscessero la
soluzione è il “dente di leone” della nostra storia. Noi non dobbiamo
mai ricominciare da capo. Se scompare uno di noi, gli altri sanno comunque.
Quel conscio collettivo diventa un archetipo e, con un meccanismo ancora
ignoto, si deposita in un inconscio collettivo che, con un imprinting ancora
ignoto, si trasmette alle future generazioni. Siamo gli unici che sanno fare. O
meglio, siamo gli unici ad essere così specializzati a farlo. Ora si capisce
cosa intendo dire quando insisto nel sostenere chela nostra essenza è la nostra
esistenza. In ogni caso, le mutazioni che ci hanno fatto assurgere nuove
dimensioni logiche, nella storia dell’umanità, sono state solo 4. Per ora. La
differenza tra mutamento e mutazioni, nella dinamica dei cambiamenti è nota.
Ogni mutamento ci permette di acquisire una nuova condizione
situazionale. Ogni mutazione ci permette di acquisire una nuova cognizione
strutturale. Cumulative, mi raccomando, non alternative. Di mutazioni nella
storia evolutiva dell’umanità, ne abbiamo avute solo 4.
Queste 4 mutazioni ci hanno fatto accumulare solo 4, per ora,
dimensioni logiche. La logica endofasica, grazie alla funzione dell’analogia,
ha fornito una ragione. La logica formale, grazie alla funzione del principio
di non contraddizione, ha fornito di una razionalità. La logica computazionale,
grazie alla funzione della falsificazione critica, ci ha fornito di procedure
di controllo. La logica quantistica, grazie alla funzione del principio
probabilistico, ci fornisce oggi di ragionevolezza. In questo senso intendo che
la vera innovazione della nostra modernità, non è l’intelligenza artificiale,
che è soltanto una tecnologia, ma è la logica quantistica, che è una nuova
dimensione del pensiero.
La
grande mutazione che stiamo vivendo, con l’avvento della società della
comunicazione, consiste in una nuova cosmogonia, una nuova visione delle regole
che governano, perché lo generano e perché lo gestiscono, l’universo della
nostra vita quotidiana. Cambia per la quarta volta; e cambia ancora
radicalmente. Con l’intelligenza artificiale, direi grazie alla intelligenza
artificiale, il nostro cervello, la nostra endemica stupidità, entra
definitivamente nella logica quantistica. È la quarta mutazione della storia
dell’umanità, l’avvento della società della comunicazione che ci offre la
insuperabile occasione di avere una nuova intelligenza complessiva. Che sia
artificiale o no, l’intelligenza si contrappone o soggiace alla invisibile
dirompenza del potere ologrammatico. Per far questo ha bisogno di una nuova
logica, di una logica quantistica, e di una essenziale epistemologia di nuova
dimensione, in grado di gestire la scissione simbiotica tra verità e realtà.
La
logica quantistica, per quel che ne sappiamo, ancora non esplorata specie in
merito alle scienze sociali (dove invece, a mio avviso, troverebbe maggior
applicazione), si basa su alcune nuove e sconcertanti cognizioni.
· In
primo luogo, non si parla più di stati o di situazioni; ma di condizioni e
dimensioni. Questo è il primo concetto di cui abbiamo bisogno: il concetto di sovrapposizione.
Significa che un determinato soggetto può trovarsi contemporaneamente in due o
più dimensioni diverse o addirittura opposte. Se facessimo una call conference
con tutto il mondo sul problema della logica quantistica comodamente seduti sul
divano di casa nostra, saremmo nella duplice dimensione globale e locale; ma
globale e locale sono anche due dimensioni opposte.
· Il
secondo concetto che dobbiamo assolutamente tener presente nella logica
quantistica sono le relazioni entanglement. In un network è possibile
che due o più poli, pur essendo lontani, cioè reciprocamente distanti si
colleghino o si connettano tra loro in modo che l’uno dipenda dall’altro,
indipendentemente dalla loro distanza. Questa relazione entanglement viene definita
e descritta come “azione spettrale a una distanza”.
· Il terzo concetto di cui non possiamo assolutamente prescindere sono i Qubit. Si tratta di un valore che ci permette di superare la logica computazionale in cui le alternative dialettiche di 0 (Falso) e 1 (Vero) costituiscono simboli reciprocamente escludenti. Il Qubit invece può rappresentare entrambi i valori contemporaneamente con un metodo interpretativo di ordine probabilistico. Il Qubit introduce definitivamente il concetto di intervallo in ogni punto del quale si conservano percentuali di elementi caratteristici dei poli opposti. Se, ad esempio, in un polo c’è la democrazia e nel polo opposto c’è l’autocrazia in ciascuno degli infiniti punti interni all’intervallo definito (cioè in ogni nostro momento) il regime politico è sia democratico che autocratico. Naturalmente si tratta di valori percentuali in relazione alla tipologia del regime e in relazioni ai tempi diversi del processo decisionale. I nuovi network politici, la loro natura, devono essere valutati e definiti in Qubit quantistici.
Come si vede, sebbene la logica quantistica appaia controintuitiva, tuttavia ci offre una rappresentazione più realistica della fenomenologia esistente.
Qualche
tempo fa mi è accaduto di partecipare ad una conferenza in una sala piena di
gente, tutta interessata, che mi ha bombardato con domande estremamente
intelligenti e talvolta sofisticate, che ha messo in dubbio e discusso alcune
delle mie asserzione e addirittura intere congetture. Alla fine, tutti siamo
rimasti contenti, ci siamo reciprocamente complimentati e applauditi, ma io non
ero li. Apparivo a loro come se fossi presente, con i pantaloni e la camicia
che effettivamente indossavo, con lo stesso tono di voce che ho sempre e la
passione che mi caratterizza. Si vedeva perfino il sudore, ma io non ero li. Io
ero a casa mia, in piedi, come se fossi di fronte a quella platea attenta,
percepivo da casa mia il loro interesse e le loro emozioni. Loro mi vedevano
per quello che effettivamente sono. Io, però, non ero li. C’era piuttosto il
mio ologramma. Ero a casa mia, davanti a un proiettore particolare e navigavo
ad una piattaforma specializzata in grado di favorire le rappresentazioni
olografiche. I dati venivano immagazzinati ed elaborati in tempo reale per
poter trasmettere la mia immagine olografica e farmi partecipare ad un meeting,
a una conferenza, stando davanti ad un proiettore, a casa mia.
Il rapporto
con l’intelligenza artificiale non è come il solito rapporto con la solita
protesi tecnologica innovativa. Cambia totalmente l’intelligenza degli umani di
cui quella artificiale è una parte, parziale e nemmeno la più importante. Il
passaggio fondamentale dalla logica computazionale alla logica quantistica, che
si esprime principalmente con il simbolico strumento della Intelligenza
Artificiale, che in realtà non è uno strumento ma un nuovo diffuso habitat,
comporta il passaggio, anche sul piano professionale e del lavoro, dal
Know-how al Know-out, come ho già scritto più volte: “La conoscenza non è più in noi, è nel dominio relazionale in cui
siamo immersi, nel campo cognitivo che ci supera e ci assorbe. Anche le nostre
capabilities tecniche o specialistiche, addirittura il cervello, è ormai fuori
dal corpo, dalla sua stessa fisicità, in un network che è al tempo stesso
relazionale e cognitivo; che è cognitivo proprio perché è relazionale”.[24]
L’intelligenza artificiale richiede addestramento. La logica
quantistica richiede formazione.
Per questo abbiamo ancora una volta, per la quarta volta,
l’esigenza di retribalizzare l’umano: perché dobbiamo imparare una nuova
dimensione dell’intelligenza e abbiamo bisogno di una nuova pedagogia. Se non
fosse cumulativa, la scienza, la conoscenza, l’intelligenza, non avremmo mai
una complessità cognitiva. La complessità, in generale, esiste in quanto la
coscienza è cumulativa (p.48).
La logica computazionale,
grazie alla funzione della falsificazione critica, ci ha fornito di procedure
di controllo. La logica quantistica, grazie al principio probabilistico, ci
fornisce oggi di criteri di ragionevolezza. L’intelligenza artificiale richiede
addestramento. La logica quantistica richiede formazione. L’Intelligenza
Artificiale di cui parliamo non è in una macchina, o in un sistema, o in un
qualsivoglia contenitore. Non è avulsa da noi o estranea a noi. È nella “fusione
di orizzonti”, come li definiva Gadamer[1], con cui viviamo in simbiosi nella società. “Ci estendiamo
sempre di più dentro concetti metodologici di pluri-problematicità e di
multidisciplinarietà.”[25]
Acquisiamo nuove metodologie di conoscenza, oltre ogni incommensurabilità
paradigmatica[26],
oltre ogni ideologia. “Sempre più oggi possiamo integrare i nostri domini
relazionali, gli insiemi dei nostri reciproci saperi, connetterci dentro
intervalli cognitivi di ordine e dimensione quantistica, che rappresentano
habitat di conoscenza più ampi: orizzonti di cognizione e competenza fusi.”[27] Possiamo
ancora restare in simbiosi con la vita, grazie alla nostra intelligenza, che
sia artificiosa o artificiale. La conoscenza che rimpolpa la nostra
intelligenza sta dentro la vita, nelle cose stesse, atti e fatti, fenomeni che
ci formano e dentro cui ci riconosciamo, nella complessità logica e tecnologica
della nostra esistenza. “Viviamo la quarta dimensione della logica
quantistica. La scienza precedente alla nostra, quella che derivava dalla
logica computazionale, reclamava una epistemologia del know-how, fatta di
saperi individuali specializzati. Naturalmente non intendo dire che le
competenze specialistiche non servono più. Le logiche non si escludono. Le
dimensioni logiche si assemblano. In un mondo integrato, in cui la conoscenza è
data dalla morfologia delle connessioni, in cui la pedagogia, la scienza
dell’educazione, la didattica e perfino la docimologia è rappresentata da una
mappa connettografica di ordine cognitivo, l’epistemologia diventa simbiotica
della intera complessità della vita.” [28]
L’Intelligenza Artificiale ci aiuta a restare dentro la
fenomenologia della società della comunicazione, ci aiuta a “ri-orientare il
posizionamento individuale dell’umano in funzione della sua condizione
esistenziale”. Se c’è un rischio, quel rischio siamo noi. Il vero
rischio è il rischio di sempre: il demone della sopraffazione e del sopruso,
utilizzando gli strumenti, di volta in volta, disponibili.
Non per
l’Intelligenza Artificiale, ma nella società della comunicazione, il potere
ologrammatico ci atterrisce, per il suo anonimato, per la sua altissima
competenza nel mimetizzarsi dentro gli interstizi della società. In questa
quarta mutazione della turbolenta storia dell’umanità, il demone non è la
tecnologia, ma le enormi e incontrollate potenzialità del potere ologrammatico
che trasforma i cittadini in anonimi utenti, per la sua capacità di controllo,
di decervellamento collettivo e per il costante tentativo di costituire, senza
istituire, un nuovo regime autocratico.
Non siamo
noi i portatori di un luddismo di nuova maniera.
L’intelligenza
artificiale non ci spaventa, perché la paura e il dolore esistenziale
dell’umano è sempre lo stesso.
Le scienze
sociali inglobano l’intelligenza artificiale in una nuova dimensione della
società, pur consapevoli che, con la logica quantistica, il potere
ologrammatico, la sua invisibile dirompenza, è molto pericoloso.
Oggi più che
mai credo abbia ragione Bertrand Russell nel sostenere che il potere sta alle
scienze sociali come l’energia alla fisica. Con l’energia in fisica possiamo
produrre il buio del terrore atomico o la luce della civiltà e del benessere. Il
rischio, che vedo concreto difronte a me ogni giorno che passa proprio qui in
Italia, è la scissione tra verità e realtà che minaccia la nostra democrazia.
L’artificio può restare dentro le nostre verità e i fatti possono restare
dentro la realtà.
Noi non
siamo coloro, come canta Vasco Rossi, che confondono quello che siamo con
quello che usiamo. Noi no. Anche quando usiamo una Intelligenza artificiale,
non la confondiamo mai con ciò che siamo.
La variabile
è la nostra etica.
Se il potere
ologrammatico della società della comunicazione genera autocrazia o democrazia
dipende esclusivamente dalla nostra competenza etica. Il rischio del potere ologrammatico nella
logica quantistica è la produzione della verità, cioè che i fatti sono
interpretati da verità precostitituite e fideistiche e l’artificio si deposita
nella nostra conoscenza e nella nostra consapevolezza al posto della realtà.
Questo è il pericolo determinante, il passo decisivo verso l’autocrazia.
L’etica ci impone una scelta politica tra la democrazia dell’artificio o la
autocrazia dell’artefatto.
NOTE
[1] PIAGET J., Lo sviluppo della nozione di tempo nel bambino, La Nuova Italia, Firenze 1979
[2] SARTRE J.P., L’essere e il nulla, Il Saggiatore, Milano 2023
[3] in BARBUJANI G. e VOZZA L. Il gene riluttante, Zanichelli, Milano 2016, si mostrano molti luoghi comuni
[4] VALERIO C., La tecnologia è religione, Einaudi, Torino 2023, 10
[5] FLORIDI L., Etica dell’intelligenza artificiale, Raffaello Cortina Editore, Milano 2022. 91
[6] FLORIDI L. Etica dell'Intelligenza Artificiale, Raffaello Cortina Editore, Milano 2022, 25
[7] Marcel Mauss riteneva che “un fatto sociale totale” fosse un evento globale che aveva una potenza in grado di condizionare l’insieme della società e dei suoi meccanismi di funzionamento. MAUSS M., Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche., Einaudi, Torino 1965
[8] FLORIDI L., cit. 2023
[9] Secondo Hannah Arendt, "la politica nasce nell'infra e si afferma come relazione". ARENDT H:, Che cosa è la politica, Einaudi,Torino 1965, 47.
[10] PARISI F., La tecnologia che siamo, Codice edizioni, Torino 2019
[11] Vedi CECI A., Epistemica della simbiosi, in RISE -n.1, volume VII, anno 2021 • issn 2421-583X
[15] Per tutte valga CECI A., La relazione Responsiva: l’intelligence nella società della comunicazione, Europarole, Roma 2020.
[1] [16] CERUTI M. e BELLUSCI F., Umanizzare la modernità, Raffaello Cortina Editore, Milano 2023, 39-66
[17] GARGANI A (a cura di), La crisi della ragione, Einaudi, Torino 1975, 11
[18] CERUTI M. e BELLUSCI F., cit. 2023, 39-66
[21] CECI A., cit. 2020
[22] KUHN T., La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino 1962
[24] CECI A., cit. 2020
[25] CECI A., cit. 2020. Per il concetto di connettografia vedi: KHANNA P., Connectography, Fazi Editore, Milano 2016
[26] HUSSERL E., La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Il Saggiatore, Milano
[27] CERUTI M. e BELLUSCI F., cit. 2023, 39-66
[28] CERUTI M. e BELLUSCI F., cit. 2023, 39-66












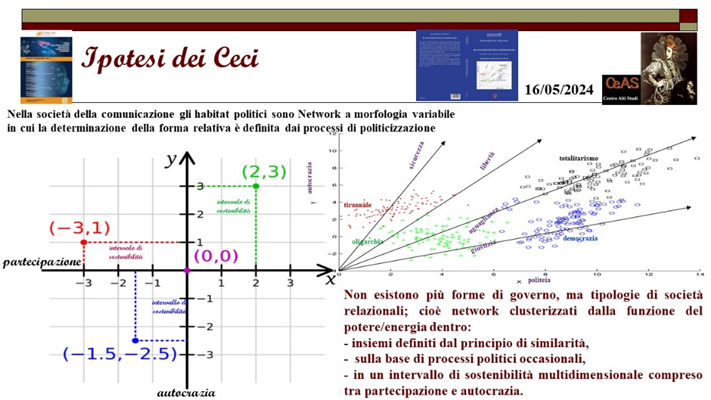
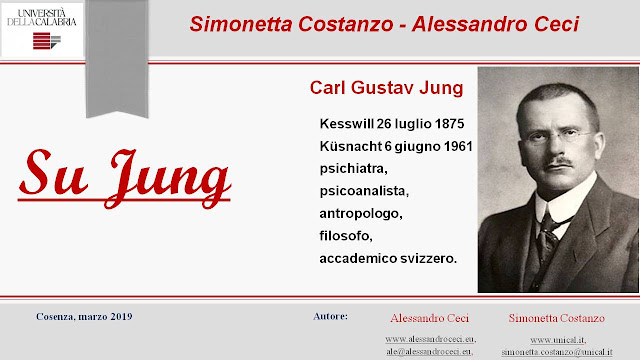
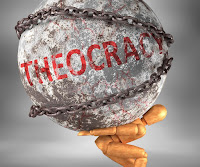

Commenti
Posta un commento