LO SPECCHIO DI MEDUSA - Introduzione
Nella “Storia universale dell’infamia”, Jorge, Fancisco, Isidoro, Luis, Borges, “autore e autodidatta”, il cui padre “fu professore di psicologia”, nato a Buenos Aires il 24 agosto del 1899, restituisce un magnifico racconto di R. F. Burton, tratto da The Lake Regions of Equatorial Africa.
La narrazione è magnifica per la miriade di significati che produce ogni volta che l’unico simbolismo della sola storia viene narrato.
Sintetizzo il racconto così: “il tiranno Yaqub il Dolente morì mentre vedeva se stesso che moriva, ucciso da Lui con una alchimia fatta di benzoino e semi di coriandolo in uno specchio di inchiostro”.
Lo specchio mostra all’assassino se stesso assassinato.
Lo specchio ci riflette: “il cristallo ci spia. Se tra le quattro / pareti della stanza v’è uno specchio, / non sono, solo. C’è un altro: il riflesso / che innalza all’alba un segreto teatro.”[1]
E ci rappresenta con incredulità: “Può essere uno specchio col mio volto diverso, / Può essere il crescente carcere di un labirinto, / Può essere un giardino. Ma è sempre un incubo. / Il suo orrore non è di questo mondo….”[2].
Infine ci mostra, dimostra cioè davvero quel che siamo: “Temo adesso che lo specchio nasconda / Il vero volto dell’anima mia, / Oltraggiata da ombre e da colpe, / Ciò che Dio vede e forse pure gli uomini.”[3]
Che obietti oppure no; che lo rifiuti d’impulso per vergogna, adducendo le argomentazioni di fortuna e provvisorie giustificazioni; che lo ammetta con realismo o come artificio per rimuovere la colpa curva; che lo escluda con una fiera e volgare de-umanizzazione o ne faccia argomento raffinato di un dialogo lucido, utile a mistificare con enigmatiche perplessità le poche deplorevoli certezze; comunque sia nei nostri banali archetipi; siamo noi il tiranno Yaqub il Dolente. Siamo noi gli assassini di noi stessi, nella illusione di essere giustizieri, inconsapevoli di essere giustiziati dalla nostra stessa condanna. Siamo comunque noi, gli umani, i suicidi.
I greci lo sapevano benissimo.
Siamo stati folgorati e corrotti dalla bellezza di Medusa l’astuta, l’unica mortale che primeggiava tra le divine sorelle Gorgoni - Steno la forte e Eriale l’ampia - Poseidone la volle. L’attrazione sfrenata non fu tanto l’oltraggio, quanto l’insulto di un Dio che adorò l’umano. A causa di questo impetuoso trasporto, Medusa l’astuta si illuse di poter competere e sconfiggere un Dio. Anzi una Dea dal famoso fervore. Sottratta la bellissima giovane mortale alla caverna del giardino delle Esperidi, dove abitava con le sorelle, Poseidone la condusse presso un piccolo tempio dedicato ad Athena, dove consumò, con adesione o con forza, il suo turbolento desiderio.
In questo modo l’oltraggio si trasformò in insulto, l’affronto in una sfida intollerabile e non giustificabile. Athena vendicò il tradimento condannando, non già il colpevole reo, ma la involontaria vittima. Perché? Perché sottrasse il godimento del suo volto, dei suoi capelli e della sua bellezza agli umani per cederla fragorosamente ad un Dio? O per una stupida gerarchia di splendore, per una ostentata primogenitura che meritava l’esecuzione di una condanna? O per orgoglio, famelico e velenoso, orgoglio ferito e ambizione? Sta di fatto che l’affronto non poteva restare impunito e, non potendo colpire il Dio, Athena giudico più semplice e opportuno colpire i lineamenti gentili della razza più debole.
Fece di Medusa un mostro, una creatura obbrobriosa e, contro l’amore concesso, la condannò ad essere automatica e inevitabile portatrice di morte. Medusa ottenne l’orribile maschera della peggiore umanità, con una bocca famelica armata da zanne di cinghiale, un groviglio di serpenti velenosi a sostituire i magnifici, morbidi e lunghissimi capelli, dalle mani e dai piedi di bronzo spuntarono impudenti e taglienti artigli di leone, il corpo sinuoso meritò le forme di cavallo a cui aggiunse, inclemente, due piccole ali d’oro sulla schiena.
La forma saccheggiata agli animali non fu tuttavia sufficiente alla condanna. La più grande maledizione che Athena ordinò per la dolce Medusa fu quella di procurare inevitabilmente la morte, la disperata crudeltà degli umani, la loro illusione di potenza che corrisponde alla più devastante debolezza: pietrificare, procurare una morte orribile solo con lo sguardo. Essere murati in una tomba solo per il fatto di guardarsi, di riconoscersi, di indovinarsi e di affrontarsi con gli occhi. Gli umani sono condannati a guardare la morte e la loro morte, insistente, guarda gli umani. Ogni sguardo coinvolto e coinvolgente, ogni curiosa attrazione è al tempo stesso la propria definitiva pietrificazione. Gli umani sono diventati per sempre Medusa e Medusa gli umani. Tutto è chiaro: siamo in condizione di dare la morte che è pure la nostra. Con lo stesso strumento con cui colpiamo ci colpiamo: lo sguardo micidiale.
Tutti da allora siamo vinti, fossimo mortali o immortali. Medusa è l’espressione terribile dell’umanità intera, relegata al castigo infinito della sua solitudine per l’orrore che è, senza avere colpa, vittima di un giudizio ingiusto e ingiustificato. Unico privilegio, coerente con il nostro aspetto orribile, è quello di accordare la morte con nostro stesso sangue velenoso sgorgante dalla vena destra o il maleficio, in grado di resuscitare perfino i morti, di decidere dei vinti o dei vincitori, se sgorgante dalla vena sinistra.
Così che la bellezza incommensurabile di Medusa fu punita per un capriccio di gelosia e per la iniquità di Dei che sovraintendevano all’ordine delle cose senza averne il dominio, né l’equilibrato potere della giustizia. Spesso invece cedevano alla tempesta dei loro sentimenti e calpestavano gli uomini conducendoli spavaldamente alla rovina. Notte e giorno Medusa maturò un risentimento che aggiunse distruzione a distruzione, che violò le leggi naturali, che pietrificò senza clemenza gli sguardi fragili e coinvolti di chi osava.
Finché Perseo, l’eroe, spinto sempre dalla insaziabile Athena, non decise di uccidere la potente Medusa, scovandola dal suo rifugio, in un’impresa monumentale che avrebbe garantito in eterno il ricordo di lui. L’impresa, però, non fu condotta per una contabilità insipida. Fu l’iniziazione all’eroismo. E come ogni iniziazione all’eroismo, si comincia con l’emancipazione dall’autorità paterna.
L’impegno era gravoso, non per incapacità di Perseo, ma per assenza del padre. Ancora oggi noi ignoriamo: se a fecondare la disponibile Danae, fu suo Zio, fratello del padre, Preto, in un impeto di passione mista alla convenienza di avere Lui l’unico maschio in grado di ereditare il trono del fratello; o se fu Zeus stesso che ingannò gli umani trasformandosi in una pioggia d’oro, penetrò il tetto e i favori della giovane donna. In ogni caso, Perso privo di padre, dovette rivolgersi al nonno Acrisio, di cui restano poche tracce, tranne l’interrogazione dell’oracolo che lo mise in guardia dalla forza del nipote e dalle sue bellicose ambizioni che gli avrebbero assicurato il suo sangue regale.
Acrisio, dotato di una accurata idiozia e ignaro che ogni suo gesto lo avrebbe inevitabilmente condotto all’ordito destino, rinchiuse la nipote in una prigione arcigna, con guardie acerrime, cani famelici e fruste sanguigne. Nel segreto di quella segreta nacque Perseo, allevato di nascosto e nascosto per essere allevato. Quando l’inganno fu svelato per una impudenza infantile, la nutrice fu passata per la spada. La madre e il figlio furono rinchiusi in una cassa galleggiante, abbandonata alla deriva di una qualsiasi navigazione.
Il semplice mare condusse quella occasionale imbarcazione tra le braccia e totalmente dentro la curiosità di Ditti il pescatore, fratello di Polidette, tiranno dell’isola di Serifo. Illuso dalle possibili ricchezze che avrebbe potuto celare, il pescatore recuperò la cassa e i corpi sfiniti dei naufraghi. Li rifocillò e li condusse al cospetto del re che, colpito dalla bellezza sciupata di Danae, ospitò i profughi. Perseo crebbe bellissimo e forte, abile con la spada e temerario nelle imprese. Il tempo esaltò le forme e la chioma di Danae che, tuttavia, non si concesse ai propositi del tiranno, dedita com’era alla tutela del figlio.
Ignara di trasformare il ragazzo in un concorrente, la dedizione di Danae costrinse Polidette ad ordire un piano apparentemente furbo: chiunque tra amici e confinanti, Perseo compreso, avesse voluto sposare sua figlia Ippodamia avrebbe dovuto dotarsi di un dono. Chiese al cordone di pretendenti un cavallo che Perseo certamente non possedeva. Allora Perseo, evidentemente non attratto dai sorrisi della giovane Ippodamia e dalla volgare sfida del tiranno, alzò la posta e offrì, sfrontato, al re qualsiasi cosa, purché avesse assicurato una vita tranquilla e non insidiata alla madre.
Il re, divertito, lo derise con una richiesta impossibile, una trappola mortale per il presuntuoso Perseo: la testa di Medusa l’astuta, una delle tre Gorgoni, la più odiosa, la più pericolosa, trasformata dalla gelosia di Athena in famelico mostro. Il realtà Polidette chiese a Perseo, implicitamente, come pegno per la falsa liberazione della madre, di essere egli stesso pietrificato dal mostro.
Perseo avrebbe dovuto dotarsi dell’occorrente: sandali alati per essere puntuale; la kibisis, ovvero la sacca magica per contenere la micidiale testa di Medusa; il kunè, l’elmo con cui Ade ci rende invisibili. Capì che avrebbe dovuto recarsi dalle Graie - Pafredo la vespa, Enio la guerresca e Deino la terribile -, vetuste sorelle delle Gorgoni, nate vecchie e decrepite, dai capelli bianchi e canuti, tutte e tre con un solo occhio e con un solo dente che utilizzavano a turno, nel momento del reciproco bisogno.
Il furto di quell’occhio e di quel dente, approfittando di un incauto risposo sui troni nel monte Atlante, permise a Perseo di trattare per ottenere l’elmo, la bisaccia e i sandali di cui necessitava. L’elmo lo rese invisibile per varcare tranquillamente il luogo in cui vivevano le Gòrgoni, loro sorelle.
In procinto di compiere una missione suicida, Perseo incontrò la sua Dea protettrice. Athena comparve al prossimo eroe e gli donò uno scudo lucente e levigato: uno specchio. E lo ammonì di non guardare direttamente Medusa, ma soltanto per il tramite dello specchio donato. Ottenne anche, dal favore di Ermes, un falcetto di diamante, indispensabile per recidere la testa di Medusa.
Cosi fu.
L’elmo lo rese invisibile e attraversò indisturbato il percorso di esseri pietrificati che lo condusse fino alla caverna di Medusa. Lo scudo gli permetteva la visione riflessa del posto, per evitare lo sguardo folgorante del mostro. Finché, senza vederla, non sentì sibilare i serpentini capelli. Medusa dormiva. Occhi chiusi dunque. Decapitarla con il falcetto fu agevole e la testa definitivamente rinchiusa nella sacca. Il mito racconta la pietà. Perseo evitò che la nuda terra sporcasse la testa mozzata e il collo, che partorì Pegaso, il cavallo alato, e il gigante Crisaore.
Con la sacca preziosa Perseo volò, trasportato dai sandali alati, verso la vendetta: di Atlante prima, che rifiutò di aiutarlo e fu trasformato in montagna dallo sguardo di Medusa estratta all’occorrenza; contro i giustizieri di Andromeda, figlia del re di Etiopia Cefeo e di Cassiopea, condannata altrettanto dalla sua bellezza, che divenne sua moglie dopo aver ucciso il mostro marino che voleva divorarla e pietrificato con lo stesso sguardo della testa di Medusa, tutti i nemici e i pretendenti; e infine Polidette, che aveva nel frattempo rinchiuso sua madre Danae in un tempio, pietrificato con tutti i suoi cortigiani dall’ira di Perseo e dagli occhi di Medusa.
La storia ha l’epilogo che merita.
Perseo restituisce il potere in terra ai giusti e la testa terribile di Medusa alla pretendente perfida e altrettanto terribile, Athena che la pose definitivamente al centro del suo scudo, l’Egida necessaria a pietrificare tutti i suoi nemici. I romani, consci dei pericoli insuperabili della intelligenza, rinominarono Athena in Minerva, la Dea della ragione, del senno e, al tempo stesso, della guerra. I 3 elementi che appartengono esclusivamente all’umanità e non certo agli animali.
Siamo ancora qui.
La nostra storia è ancora come è sempre stata: l’intelligenza e la perfidia, la ragione e la forza, il senno e il furore. Sono i due volti, opposti e complementari, del potere: la possibilità di costruire civiltà e quella di distruggere l’umanità. Un potere che acquista potenza con il tempo, con la tecnica e la tecnologia. Il potere che abbiamo ha una potenza inusitata e superiore ad ogni altra mai esistita nella storia dell’umanità. Una potenza talmente devastante da poter solo essere ostentata ma non esercitata. Una potenza talmente distruttiva da essere autodistruttiva. Temo ancor di più, tuttavia, il potere che avremo nel futuro, prossimo venturo, con la sua indescrivibile e indefinibile potenza. Il potere esorbitante e crescente di umani che hanno soggiogato il mondo e si accingono a farlo con l’universo, però, ha sempre la stessa profonda debolezza: quando si guarda direttamente in faccia, quando si riflette in uno specchio, è pietrificato dall’orrore del suo stesso essere, dalla morte che produce con il devastante veleno della sua vena destra e dalla vita di cui si appropria distruggendo i nemici con il sangue della vena sinistra.
O forse non è così?
Forse vediamo il mondo a tinte fosche, non diverso da come è sempre stato.
Forse è soltanto come noi lo abbiamo percepito, perché alla fine l’umano esiste e resiste, dentro sempre minori tassi di violenza applicata, dentro una vita estesa negli anni, distesa negli infinti spazi della profondità sociale, contesa in un potere preteso che è energia ed egemonia, dentro una democrazia delle relazioni che espande i diritti a chi non ne ha mai avuti.
Forse, invece, siamo agli esordi di un mondo nuovo. La penna e la spada non si contendono più una supremazia. Forse siamo nell’era della egemonia e, nella società della comunicazione, la penna è la spada.
Alla fine chi ha il potere sulla storia e sui significati del mondo? L’eroico ed eternamente belligerante Perseo o il suo oscuro narratore? Chi ha deciso i nostri destini, il guerriero che ha giustiziato mostri tremendi per vivere sereno la quotidianità del suo amore, o colui che ha deciso per tutti noi chi dovesse essere il protagonista e chi lo sfondo, chi dovesse essere immortalato nella mitologia di ogni tempo e chi dovesse passare nello spazio affollato dell’ombra? Chi ha il potere delle nostre menti, l’eroe che agisce per essere narrato o chi, narrando, decide chi merita di essere eroico?
ooo/ooo
[1] Borges Jorge Louis, Gli Specchi, in L’Artefice, in Opere, vol.I, Milano 1984
[2] Borges Jorge Louis. Efialte, in La Rosa Profonda, in Opere, vol. II, Milano 1985
[3] Borges Jorge Loius, Lo Specchio, in Storia della Notte, in Opere, vol. II, Milano 1985



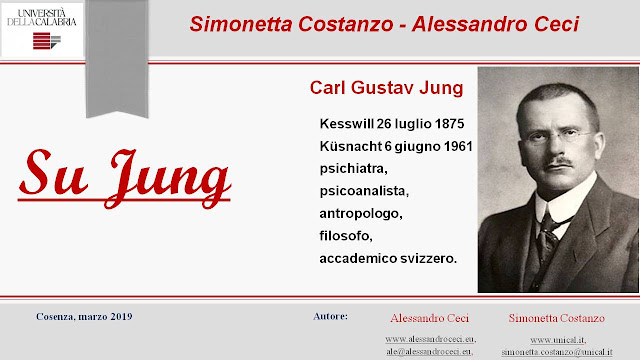


Commenti
Posta un commento