Wetware Town: i network urbani simbiotici della società della comunicazione
DISCORSI AD UN PUBBLICO ASSENTE
Venezia 05.011.2021
Biennale di Architettura
Alessandro CECI
Ringrazio Aqui Olleia e Giulio Pascali, con cui ormai si è radicata una relazione affettiva e professionale importante, che, per me, è un journey to the past, un viaggio nel passato, essendomi per moltissimi anni occupato di educazione, sia in termini tecnologici[1], sia in termini pedagogici[2]. Riprendo contatto con ciò di cui mi sono occupato, se è possibile, nel lavoro intellettuale, dismettere talvolta l’interesse.
Sono tornato a Venezia dopo anni. Ho praticamente vissuto qui per un certo periodo, quando all’Università, facoltà di urbanistica, a San Stae, organizzammo il primo seminario internazionale sulla simulazione. “Venezia – diceva Borges – è un crepuscolo delicato ed eterno, senza prima né dopo”[3]. Io però ho apprezzato un’altra Venezia. In quel periodo studiavo le Memorie di Giacomo Casanova, a cui il gioco di simulazione che stavano costruendo, era dedicato. Nelle Memorie di Casanova, il crepuscolo non c’è; c’è il giorno e c’è essenzialmente la notte. Venezia di Casanova è la città degli intrighi e degli inganni, che non sono mai tradimenti, ma scelte, parziali e provvisori schieramenti. Venezia è la città dei segreti, la città dei servizi segreti di cui Casanova sembra facesse parte.
Nel suo testo più famoso, L’Insostenibile Leggerezza dell’Essere, Milan Kundera fa dire a Franz, il protagonista: “In Europa la bellezza è sempre stata premeditata. C’è sempre stata una intenzione estetica ed un progetto a lungo termine; ci sono voluti decenni per costruire, secondo quel progetto, una cattedrale gotica o una città rinascimentale. La bellezza di New York ha una base completamente diversa. È una bellezza inintenzionale. È una sorte senza intenzione da parte dell’uomo, un po’ come una grotta di stalattiti. Forme in sé brutte si trovano per caso, senza un piano, in ambienti così incredibili.” A Venezia la bellezza intenzionale europea è visibile, palpabile, vivibile e addirittura condivisibile. Venezia è l’emblema universale della bellezza intenzionale, della bellezza premeditata dell’opera d’arte.
Ho apprezzato moltissimo un libro che ho letto ultimamente, d’altronde pubblicato quest’anno, di Maurizio Ferraris dal titolo “documanità”. Maurizio Ferraris è, dal mio punto di vista, un personaggio particolarmente singolare, sul piano intellettuale e filosofico. Personalmente condivido gran parte e l’impostazione generale delle cose che scrive. Tuttavia egli ci ha proposto un libro con un titolo perfetto e un contenuto discutibile[4]. Ora ci propone un libro con un titolo discutibile e un contenuto perfetto[5]. Un libro bellissimo e importante che comunque, se lo avessi scritto io, avrei scritto in modo parzialmente diverso, come è normale che sia. Sul piano metodologico, probabilmente non avrei avuto la capacità di Ferraris, anche se ne ho sempre avuto l’idea, di permetterci la lettura del testo come se fosse una tabella a doppia entrata, sull’asse delle ascisse (avanti e dietro), sull’asse delle ordinate (avanti e indietro) e dentro i singoli riquadri, dentro i poli, dentro i numeri della logica che hanno molteplici valori. Sul piano contenutistico non avrei forse avuto la cortesia di Ferraris, giacché, come diceva Ortega Y Gasset, la chiarezza è la cortesia del filosofo.
Ci sono alcuni passaggi, però, sebbene minori rispetto all’economia complessiva del lavoro svolto, su cui non sono molto d’accordo. Uno di questi ci riguarda qui oggi. Si tratta della mia quinta obiezione alla tesi di Ferraris.
In un brano del testo, laddove all’inizio l’autore descrive la Registrazione, ossia la rete prima della rete, egli propone una similitudine con un brano del Timeo[6], quando Platone “teorizza la chora, che letteralmente significa «spazio», «luogo», «posto»”[7]. Ferraris ci avverte subito che chora in Platone ed oltre, “in senso metafisico indica un «genere intermedio», e consiste in una grande capacità di isteresi”[8]; cioè che il valore assunto da un fenomeno, in un dato istante, non dipende soltanto da se stesso, ma anche dai valori assunti in istanti precedenti da fenomeni diversi a cui è correlato. Una similitudine con il web[9], non corretta.
I greci, che conoscono il greco certamente meglio di noi, utilizzano ancora comunemente il termine chora per indicare un villaggio, uno spazio, un luogo, un posto. Ora, per dirla con March Augé[10], il web è un “non-luogo”, percepito inizialmente come liminalità, svelato come condizionalità, oggi interpretato come possibilità, comunque un tempo senza spazio.
È vero che la rete c’è sempre stata e c’è, non soltanto per il genere umano, ma come molti anni fa ci ha indicato Fritjof Capra[11], per la vita intera.
Non è vero però che la rete abbia concettualizzato lo spazio. La forza della rete, specificamente per il genere umano, è che può essere concettualizzata senza spazio, nell’ovunque, in ogni indefinito, in ogni dimensione diversa e diversificata di diversi e diversificati presenti.
Per giustificare questa similitudine scorretta e questa interpretazione sbagliata, Ferraris deve necessariamente spazializzare il web nella registrazione, che ovviamente a questo punto diventa l’argomento centrale della sua teorizzazione. Secondo Ferraris, per questo motivo, il web porterebbe con sé la registrazione, di cui ha indispensabile bisogno per congiungere il tempo con lo spazio.
In ogni caso, se fosse così, questa non sarebbe affatto una innovazione e dunque non giustificherebbe la transizione che abbiamo attraversato e i tempi nuovi della mutazione che stanno avvenendo. Da sempre, infatti, noi già conosciamo uno spazio “in cui il passato è ripetuto dalla materia e ricordato dalla memoria, con una forza tale da dispiegare tutte le potenzialità della registrazione, trasformandola in qualcosa di qualitativamente diverso”: è la città.
Bertrand Russell temeva che il tempo della cognizione non avesse la velocità di raggiungere le rapidi accelerazioni della nostra condizione nello spazio. E temeva che in questo vuoto, tra la cognizione lenta e la condizione veloce, precipitasse l’uomo moderno. Era un timore giustificato. È un timore concreto, percepibile continuamente nelle vacue argomentazioni che ci stordiscono, nella banalità ricercata perché necessaria ed opportuna per popolazioni indefinibili di utenti delle tv generaliste; un timore palpabile nella noiosa ripetizione dell’eternamente uguale, nell’ovvio replicato continuamente in modo che venga memorizzato esclusivamente; un timore verificabile nei numeri allucinanti e colpevolmente mistificati dell’analfabetismo funzionale. Eppure, esistono parole semplici di Russell, come di ogni incommensurabile filosofia, che pesano sulla nostra coscienza come un masso inamovibile: “Ogni incremento dell’abilità, se si vuole che produca un incremento anziché una diminuzione della felicità umana, richiede una corrispondente crescita della saggezza. Negli ultimi centocinquant’anni si è verificata una crescita dell’abilità che non ha precedenti, ed il ritmo di questo avanzamento non da segni di stanchezza. Al contrario, la saggezza non ha fatto registrare il benché minimo progresso. Le parole d’ordine della politica sono ancora le stesse che erano in voga nel diciottesimo secolo. Gli slogan che fanno vincere le elezioni sono ancora quelli folli del passato. Oggi più che mai un’avidità miope rende le comunità cieche di fronte alla prospettiva dei propri interessi di lungo periodo. È l’abilità disgiunta dalla saggezza la causa dei nostri guai.” [12]
Era il 1954. Il testo fu pubblicato per la George Allen & Unwin a Londra. Dalla prima fase della società della comunicazione, se la datiamo dalla caduta del Muro di Berlino (1989), ad oggi, sono passati 32 anni. Da quando scrisse Bertrand Russell ne sono passati 67. La saggezza non è progredita di molto rispetto alla crescita delle nostre abilità. Ancora oggi “il rimedio, quindi, non starà in un puro e semplice aumento dell’abilità, ma nella crescita di quella saggezza che i tempi richiedono”.
Come ho già scritto[13], siamo di fronte alla quarta mutazione della storia dell’umanità. Mutazione non è mutamento. Il mutamento è il cambiamento del fenotipo sociale, come quando da magro divento più grasso, o i miei capelli diventano bianchi da neri che erano, o quando mi cresce una barba che non avevo. La mutazione invece riguarda il genotipo sociale, come quando, se fosse possibile, un gatto diventa cane, o come quando un’ameba è diventata un animale, una cellula procariota è diventata eucariota conquistando la dimensione sessuale e la diversità della complessità dettata dal processo di adattamento della sopravvivenza.
Nella storia dell’uomo noi abbiamo avuto solo 4 mutazioni, cambiamenti del genotipo sociale. La prima, quando abbiamo acquisito la posizione retta e siamo vissuti in comunità costituite essenzialmente da una relazione parentale. La seconda mutazione quando abbiamo iniziato ad autorappresentarci nel mondo, l’epoca della grande edificazione, quando siamo passati dal villaggio della comunità alle città della società, alle polis, all’urbs. La terza mutazioni l’abbiamo vissuta con la rivoluzione industriale e l’avvento dei sistemi, che hanno assemblato comparti socio abitativi in metropoli enormi, gigantesche che spesso diventavano affollate necropoli. Noi siamo fortunati. Viviamo nei tempi interessanti della quarta mutazione, l’avvento della società della comunicazione in cui la vita è organizzata in network e noi abbiamo nuove polis da riprogettare. La saggezza non ha ancora raggiunto le abilità e noi siamo di fronte, in questa quarta mutazione genetica, alla responsabilità e al privilegio di dover riformulare i parametri interpretativi del mondo. La sintesi tra l’epistemica (le abilità) e l’ermeneutica (la saggezza) nella vita concreta, nella vita nuda, spetta alla politica ricondotta alla primigenia derivazione di polis. Come si dice che quando uno deve inventare una nuova cosmogonia deve necessariamente tornare alle origini. Il compito nuovo della politica è quello di trovare il punto di equilibrio storico nella sintesi tra gli opposti: tra il tempo vivente nello spazio vissuto. Le nostre città, in questa generale mutazione, sono passate dall’essere villaggi all’essere polis prima ed urbs dopo, dall’urbs alle metropoli, dalle metropoli stanno diventando oggi wetware town.
La reciproca coniugazione tra tempo e spazio è avvenuta per la prima volta nei villaggi delle comunità, nelle polis delle società, nelle metropoli dei sistemi e continua ad avvenire ora, oggi, nelle wetware town, come le chiamo io, cioè nei network urbani della comunicazione. Voglio dire che la forza, più forte di sempre, della politica, ciò che è sempre stato ed oggi è assai di più, incommensurabilmente più importante e determinante, è proprio questa congiunzione, o meglio, questa reciproca coniugazione tra il tempo della nostra cognizione, disvelato con il web, e lo spazio della nostra condizione, rappresentato dalle nostre città.
Riprogettare una wetware town significa appunto questo: ridare agli individui, nel tempo vivente, il loro spazio vissuto. Non si tratta di aggiungere tecnologia alla nostra vita quotidiana. Una wetware town non è semplicemente una smartcity. Wetware significa simbiosi tra hardware, software e umano. In termini urbanistici e ancor di più in termini di urbanizzazione, significa integrazione tra habitat (comprensivo di ambiente), tecnologia e umanità.
Simbiosi è lo stadio successivo della integrazione. Non si tratta di incastrare nel modo opportuno la tecnologia con l'habitat, l'habitat con l'uomo e la tecnologia con l'umano.
Nell'integrazione, una volta decostruiti, l'uno può continuare a vivere e funzionare senza l'altro.
Nella simbiosi no.
La differenza tra integrazione e simbiosi è che l'integrazione è un metodo, la simbiosi è una condizione. La mia amica Liuva Capezzani suggerisce l'immagine del puzzle, dove ogni pezzo va integrato all'altro, non ha significato senza l'altro è sono tutti simbiotici rispetto a sé stessi e alla figura complessiva. È una immagine corrispondente.
Si tratta allora di rendere simbiotico l'uno rispetto all'altro e tutti e tre insieme i fattori connotativi del wetware. Ormai la logica quantistica sta sempre più disvelando la simbiosi fenomelogica della nostra esistenza. Siamo permanentemente in simbiosi e senza il wetware simbiotico delle nostre città moriremmo. Se habitat, tecnologia e umanità non fossero stati da sempre in simbiosi non saremmo sopravvissuti. Non sappiamo, non potremo mai sapere chi è l'ospite e chi è il simbiosi. Forse lo sono entrambi contemporaneamente. Sappiamo che è sempre stato così e lo sarà per sempre a maggior ragione. Il nostro compito allora è saper progettare la complessità simbolica di wetware town multimedimensionali.
Dall'umano bisogna partire. Ho sempre qualche resistenza a pensare una città monodimensionale. Non esiste, non è mai esistita una città dei bambini o dei vecchi, dei maschi o delle femmine, dei lavoratori o dei disoccupati, degli immigrati o degli emigrati, dei ricchi o dei poveri. In ogni suo momento una città, ogni città, è sempre una realtà multidimensionale. La città è di tutti, costantemente, e progettare per uno o per l'altro è solo un pretesto. Da qui bisogna ricominciare. Non pianificare e nemmeno programmare, ma progettare una città che nel futuro del nostro presente sappia integrare habitat, tecnologia ed umano.
Progettare i diritti, che non siano soltanto complementari ai doveri, ma siano scaturiti dai bisogni dei cittadini.
Progettare la semantica urbana, trasformare cioè spazi organizzati in luoghi identificati. E che siano progettazioni di vita. Non solo modelli o moduli, ma luoghi cognitivi, riconoscibili nella loro unicità.
Progettare la bellezza. Nelle nostre città c'è una fruizione estetica che va tutelata perché è in sé stessa educativa, formativa, gratificante. Una bellezza intenzionale che è il segno e i. Significato della nostra presenza nel mondo.
Principalmente però occorre progettare la multidimensionalità che si chiama convivenza, vivere con, insieme. La città non è più il prodotto inqualificabile di una assemblamento estensivo di comparti che impropriamente assumono il nobile nome di borghi. Il termine stesso di "aggregato urbano" è orripilante ed obsoleto. L'epoca degli aggregati è finita con i sistemi. Ormai siamo nei network a morfologia variabile. Le città sono network multidimensionali. Non saremo più costretti a vederle crescere all'infinito.
La pandemia ci restituisce network urbani più gestibili, più vivibili, più governabili. A patto però di saper progettare la simbiosi di habitat, tecnologia e umanità in nuove wetware town multidimensionali. Uno strumento di valutazione degli impatti di ogni progettazione lo abbiamo, anche se colpevolmente non lo utiliziamo. Si chiama "bilancio sociale", appositamente elaborato per permettere agli amministratori e ai cittadini una valutazioni degli impatti, in termini di vita reale, di ogni progettazione proposta (Bilancio Sociale Preventivo) o realizzata (Bilancio Sociale Consuntivo). Sono strumenti di valutazione etica dell'azione politica ed è probabilmente per questo che non vengono usati.
Non si tratta, dunque, di connettere o di riconnettere. Quello di connessione o riconnessione era un termine utile a decodificare la prima fase della mutazione verso la società della comunicazione. Oggi è un termine obsoleto e non esplicativo. Fuorviante. Sempre nella sua affascinante storia l’umanità si è organizzata in funzione della tecnologia necessaria. È stata la tecnologia a dettare i criteri necessari per sviluppare le abilità e la saggezza. Nella prima mutazione, l’epoca delle comunità, l’umanità ha organizzato i suoi spazi favorendo gli strumenti indispensabili per la propria sopravvivenza e ha concettualizzato prevalentemente il problema della sicurezza. Gli strumenti erano funzionali alla propria tutela e la comunità doveva garantire la propria sicurezza. Nella seconda mutazione, l’epoca delle società, gli strumenti erano funzionali alla propria autoaffermazione sulla natura, simboleggiata dalla infinita edificazione, e gli umani si sono concentrati sulle proprie competenze, quelle che Russell chiama genericamente abilità. Gli strumenti erano funzionali alla affermazione di sé e la società doveva garantire la reciproca appartenenza, quella che chiamiamo genericamente identità. Nella terza mutazione, l’epoca dei sistemi, gli strumenti dovevano sviluppare differenziazione sociale e gli umani hanno acquisito specializzazioni talvolta de-responsabilizzanti. Gli strumenti differenziavano funzionalmente i sottosistemi che dovevano garantire l’attribuzione di status, ciò che noi chiamiamo genericamente professione.
Ora, nella quarta mutazione che stiamo vivendo, gli strumenti sviluppano quotidianamente integrazione simbiotica, non sono semplicemente connessi, sono integrati e in simbiosi tra loro (computer, tv,telefono tendono a diventare un solo strumento) e gli umani, nelle loro wetware town, nei network urbani della comunicazione, saranno sempre più in simbiosi, non solo integrati, non solo connessi, ma organizzati in luoghi simbiotici del tempo, spazio e tempo in simbiosi con la relazione sociale. Altrimenti, senza questa simbiosi indispensabile, vivremo devastanti situazioni di isolamento e solitudine.
Isolamento e solitudine sono i due fattori del degrado dell’era moderna. La generale condizione di degrado è la novità della crisi contemporanea: non vivo o morto. Il degrado non è né vivo né morto. Il degrado è una condizione di abbandono. Il degrado è trascuratezza. Il degrado è indifferenza delle cose e delle persone. Il degrado è generale deterioramento.
Nel degrado, che è anomia e solitudine, vive una moltitudine di soggetti che non riescono ad essere e non saranno mai una classe. Ralph Dahrendorf l’ha appositamente chiamata underclassmen, la classe degli uomini che sono fuori rete, che scivolano quotidianamente nel vuoto. Fuori rete, fuori connessione. Fuori da ogni livello di socializzazione e di vita collettiva. Impossibilitati a qualsiasi integrazione. Valeva già nell’epoca dei sistemi. Vale di più nell’epoca dei network. Sono individui che non riescono a diventare soggetti, non vivono né sopra né sotto. Vivono nel degrado. Un degrado che non riesce ad essere degenerazione e per questo non permette alcun recupero. Tutto va sempre quasi bene, quasi tollerabile, sopportabile. Il degrado che s’insinua nei nostri habitat quotidiani. Non sono un ceto. Sono soli e si esprimono come possono, come sanno, con la violenza o con il mutismo. Cercano un’identità e un’identificazione. Vogliono posizionarsi in una qualsivoglia prossimità, laddove il degrado della vita non riesce ad identificare un altrove. Un altrove che è più facilmente recuperabile in una rete in cui la fisicità non è percepibile, nei social network che li proteggono con un avatar. Tentano di sfuggire dal degrado, talvolta con un gesto di violenza, talvolta con un’incubazione solitaria, talvolta con il ritiro. Purtroppo però, questa è la sua caratteristica, dal degrado non si esce con un singolo gesto, ma con un processo.
Intanto bisogna averne cognizione, e questo è già molto difficile.
Poi bisogna avere delle soluzioni, delle scelte.
Prima però bisogna avere dei progetti da realizzare.
Entrambe le cose, idee e progetti, rompono la nostra più potente nemica, l’endemica inerzia che genera il degrado fisico e cognitivo, sociale e culturale che è il pericolo più grande, subdolo e devastante della vita contemporanea.
E allora?
Dobbiamo prendere coscienza che le città contemporanee, specie dopo la devastante esperienza della pandemia, non sono più come prima. Non lo sono nei desideri e nelle esigenze dei suoi cittadini. Il virus improvviso e inatteso, come ha scritto benissimo Donatella Di Cesare[14], ha interrotto la frenesia capitalistica, la crescita sfrenata, l’ha rallentata, l’ha trasformata in sviluppo. Le città, dopo la pandemia, non saranno più “un organismo proliferante”, come le ha definite Pier Luigi Cervellati[15]. Non saremo più costretti a veder crescere all’infinito gli aggregati urbani, connotati nel loro degrado dal termine stesso di aggregato.
Il post- pandemia ci restituisce centri urbani più gestibili, città a dimensione d’uomo più governabili: sia perché la popolazione è minore; sia perché la tecnologia consente; sia perché le relazioni sociali sono più gratificanti.
E allora?
Allora bisogna evitare di costruire. Bisogna ri-costruire nella sua duplice accezione: costruire di nuovo, cioè abbattere il degrado insignificante e costruire il nuovo; ripristinare al nuovo, restaurare il degrado significativo. Però, evitare di costruire oltre. O almeno farlo quando è proprio indispensabile. Tutto questo però sarà possibile se noi riusciremo ad integrare simbioticamente l’habitat sociale dove siamo posizionati con la rete a cui siamo cognitivamente connessi. Solo progettando la simbiosi tra la città e il web saremo in grado di costruire una wetware town di nuovo tipo, il cui principale obiettivo deve essere superare costantemente ogni forma di degrado.
Se abbiamo oggi un compito, questo impegno, questa responsabilità etica collettiva consiste nella realizzazione di progetti di simbiosi sociale come generale condizione di rieducazione. Ne abbiamo indispensabile bisogno. Abbiamo bisogno che il multiforme e il molteplice siano simbiotici ai diritti dei cittadini. Abbiamo bisogno di una lebenswelt della urbanistica, cioè di una competenza tecnica in simbiosi con la saggezza della vita.
Siamo passati dal know-how al know-out.
Oggi più che mai "felicità" (autorealizzazione) significa saper convivere nella multidimensionalità simbiotica; e significa saper governare la complessità di ogni wetware town: questo è il grande compito politico di fronte al quale si trova la nostra generazione.
I filosofi devono riformulare.
Gli architetti devono riprogettare.
Torno a casa.
Il convegno è finito.
Io sono sfinito.
Mi sento come diceva sentirsi Pasolini: bambino mandato in giro per il mondo, con il suo cappotto troppo grosso e le sue cento lire.
Salgo le scale bianche della stazione.
Un via vai di persone e valigie si accalca formicolando, stanca, con evidente fatica. Chi va e chi viene.
Venezia, penso, con la sua bellezza assolutamente intenzionale e la confusione di sé che trasmette, è il simbolo definitivo di questa umanità su una zattera di fortuna, naufraga nell'universo infinito.
ooo/ooo
[[1] Il mio lavoro al Centro Nazionale Italiano Tecnologie Educative
[2] Il mio insegnamento di Pedagogia Sociale
[3] Borges Jorge Luis, Atlante, in Opere, vol.2, Mondadori, Milano 1986, p.1335
[4] Ferraris Maurizio, Postverità ed altri enigmi, Il Mulino, Bologna 2017
[5] Ferraris Maurizio, Documanità. Filosofia del mondo nuovo, Laterza, Bari 2021
[6] Platone, Timeo, 49a 6-51a 5
[7] Ferraris M., Documanità., cit. 2021, p.11
[8] Ferraris M., Documanità., cit. 2021, p.11 “Isteresi, da hysteron, … indica in generale un fenomeno di ritardo per cui un evento precedente interviene nel presente, e deve dunque essere tenuto in conto”, p.8.
[11] Capra Fritjof, La rete della vita, Rizzoli, Milano 1996
[5] Ferraris Maurizio, Documanità. Filosofia del mondo nuovo, Laterza, Bari 2021
[6] Platone, Timeo, 49a 6-51a 5
[7] Ferraris M., Documanità., cit. 2021, p.11
[8] Ferraris M., Documanità., cit. 2021, p.11 “Isteresi, da hysteron, … indica in generale un fenomeno di ritardo per cui un evento precedente interviene nel presente, e deve dunque essere tenuto in conto”, p.8.
[9] “Da quando il web ha fatto la sua apparizione, dapprima nei computer, poi nei telefoni e negli orologi, e adesso all’ambiente, è come se la chora fosse diventata, se non visibile, almeno concepibile, superando la difficoltà che ci trovava Platone, quella di un «terzo genere» che non è né sensibile né intellegibile”. Ferraris M., Documanità., cit. 2021, p.11
[10] Augé Marc, Nonluoghi, Elèuthera, Milano 2018[11] Capra Fritjof, La rete della vita, Rizzoli, Milano 1996
[12] Russell Bertrand, Un’etica per la politica, Laterza, Bari 1994, p.190






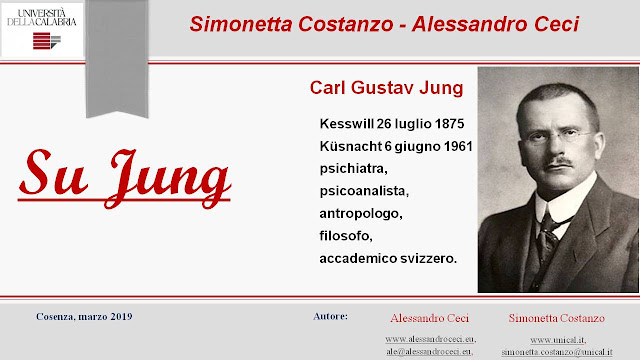


Commenti
Posta un commento