SICUREZZA - 3 concezioni propedeutiche: paura madre e matrigna
3 - Concezioni di sicurezza: la paura genetica, madre e matrigna, è il fondamento della nostra insicurezza, perché archetipica, perché ancestrale, perché sa chi saremo.
Ho paura. Confesso e confermo di aver paura. Non della morte certo. O almeno non soltanto di quella. Ho molto più radicale e onnipotente paura di finire relegato nel mondo e nella dimensione che disprezzo, nel lamento insensato e ricorrente, nel cupo e frenetico agire, nell’assenza di acume ed anche di arguzia, nell’ambizione soffocante del potere, nell’ossessivo cercarsi e ricercarsi della ricchezza come una vendetta indirizzata a se stessi per il mondo che non si è avuto e che mai si potrà comprare. Ho paura certo, ma non di finire. Ho paura di non riuscire a concludere. Non ho paura della solitudine che tuttavia mi attrae. Ho paura della emarginazione. Ho paura, come tutti di precipitare nell’insignificanza della vita. Ho paura, come tutti, del disfacimento fisico, dello sfacelo, della malattia, del dolore. E tutta questa paura mi produce insicurezza, talvolta terrore. Ho paura di sbagliare. Mi indebolisce indubbiamente. Mi rende insicuro.
Elias Canetti, forse mentre frequentava uno dei funerali a cui l’educazione ci costringe, ha capito che noi non piangiamo il morto, esultiamo della nostra la sopravvivenza. Di fronte alla disgrazia degli altri, fingiamo di soffrire, mentre, in realtà, gioiamo con un triste rito della nostra fortuna. Il riconoscimento della morte dell’altro è, quindi, l’attestazione e l’esaltazione della propria esistenza. Questa consapevolezza ci rende una sicurezza assoluta.
Non è soltanto un atteggiamento individuale, personale. Vale anche per la dimensione collettiva, sociale. È dall’accettazione del diritto di sopravvivenza dell’altro che deriva il riconoscimento e la garanzia della sicurezza collettiva.
Hobbes aveva paura. Una paura implacabile. Una paura di ferro e fuoco. Una paura certamente sua, personale emozionale, individuale come la nostra. Hobbes aveva una paura irrefrenabile. Addirittura Hobbes credeva di essere stato generato dalla paura, come tutti, come la società intera. La madre, fecondata dal vicario di Westport, “se n’era sgravata in anticipo, terrorizzata dalle notizie sull’arrivo dell’Armada”. Per Hobbes, abbandonato dal padre e sostenuto da un ricco zio, quella paura era la vera forza di ogni genesi, la causa primaria e primordiale di ogni aggregazione umana. Appunto, madre paura, come dirà Rosellina Balbi[1]. Madre e matrigna, nel senso che non solo ci ha generato, ma ci ha anche allevato.
Madre perché genetica.
Gled Shumyatsky e i suoi colleghi, tutti ricercatori della Rutgers University, hanno scoperto che il gene della statmina - normalmente frequente nella regione del cervello denominata amigdala – controlla la paura, sia quella innata, sia quella acquisita nel processo di adattamento della specie all’ambiente. C’è quindi un luogo, un posto anatomicamente individuabile dove la paura si deposita e dove si conserva. Lo studio, pubblicato il 18 novembre 2005 sulla rivista scientifica CELL[2], dimostra che i topi del gene della statmina diventano eccessivamente audaci e temerari, con livelli di ansia insolitamente bassi, anche in circostanze insicure, minacciose e addirittura rischiose. Questi topi, geneticamente modificati, non avrebbero la capacità di reagire con una paura appropriata davanti all’incombente pericolo[3].
Matrigna perché sociale.
Paura è timore e terrore, oppressione e ansia, preoccupazione e fobia, inquietudine e panico. Una emozione a stati diversi di intensità, potremmo dire, circoscritta in un intervallo che va dalla paura esistenziale, positiva, alla paura clinica, negativa[4]. È una sensazione pervasiva che coinvolge e travolge l’organismo sociale. Paura è una previsione di futuro, una percezione di incertezza, una condizione pervasiva, una soluzione imprevista che porta a stati di tensione somatica e di agitazione collettiva. Paura è intuizione di un pericolo, ipotesi di emergenza o di aggressione, attacco furioso, allarme, perseverante, predominante insicurezza che produce ulteriore disorganizzazione. La paura è innata, fisiologica, già precostituita nel codice genetico e che si avverte come confusione, dolore, ignoranza, minaccia alla sopravvivenza, freddo, perdita di orientamento. Ha variabili dipendenti che sono gli eventi; variabili indipendenti che sono i comportamenti e variabili intervenienti che sono i rapporti tra eventi e comportamenti. La paura è anche appresa, prodotta dalla esperienza individuale e collettiva di individui e soggetti, condizionamento, eterodirezione, psicosi. Può essere focale, cioè circoscritta, o diffusa. La paura che molte volte ci prende è un meccanismo di difesa dell’individuo e del gruppo dai pericoli dell’ambiente e dell’habitat. Mio padre, a ottantenni, travolto da una crisi iperglicemia prodotta da un diabete incontrollato, quando riemerge dal rischio dell’abbandono parla del suo lavoro e lo dimentica, parla della sua vita e la dimentica. Non parla. Cerca una certezza di vita per superare ogni paura, quella paura di tutti, di tutti noi che rifiutiamo la finitezza, che rifiutiamo di averne coscienza, la paura di tutti noi e a cui tutti siamo sottoposti permanentemente, ogni volta che da un nodulo al seno risaliamo ad un tumore probabile, da una raceudine ad una possibile malattia, da un dolore intercostale a un infarto prevedibile, permanentemente sottoposti ad una paura esistenziale che man mano negli anni abbiamo imparato a gestire. È una presenza ineliminabile, una volta scrissi, come un’ombra che, quando diventa patologica si trasforma in paura clinica che va curata.
Mi chiedo se la paura esistenziale dell’homo homini lupus, descritta da Hobbes, su cui per anni è sta istituita la nostra democrazia, sia diventata oggi una paura clinica che ci blocca, ci immobilizza, ci rende succubi di un terrore costante, di un panico estremo che svilisce ogni decisione e nullifica ogni comportamento. Mi chiedo se il terrorismo di ultima generazione, prima ed ora la pandemia acerrima, non abbiano inciso così profondamente nella già labile condizione della democrazia liberale da farci trasbordare. Mi chiedo se davvero il terrorismo o le incontrollabili crisi ambientali o infettive non ci abbiano fatto superare quel confine che, da una paura che ci protegge, logica, positiva, normale, la cui intensità è proporzionata alla minaccia, ci separa da una paura patologica, clinica, negativa, una fobia collettiva sproporzionata che si attiva senza un reale pericolo, sulla base di un distratto input comunicativo, su uno stimolo mediatico che produce una intensità eccessiva ed eccedente. Mi chiedo infine se non siamo ormai arrivati alla paura della paura, che è lo spavento che l’Occidente globalizzato ha per il fatto stesso di esistere, perché in fondo sa che ogni elemento della sua supremazia è, al tempo stesso, un elemento della sua debolezza, perché sa che il suo privilegio minoritario di casta non è più tollerabile, non è più sostenibile, perché sa che la sua ricchezza complessiva è la sua stessa minaccia. Forse per questo l’Occidente non sa più agire e reagire bloccato da un attacco di panico che ti fa chiudere le frontiere per scappare o ti fa aggredire per nascondere.
E non è una stessa fobia quella dell’indefinibile, dell’etereo nemico, la fobia secolare di chi, in ogni momento storico, costruisce la sua presenza e la sua identità sulla debolezza, o addirittura sulla patologia dell’altro, utile scorciatoia di tutti gli individui e dei soggetti in cerca di legittimazione?
“La paura è un sentimento fondamentale per capire due delle espressioni più gravi nell’ambito dei disturbi del comportamento: la violenza e la depressione”[1].Quale spetta all’uno e quale all’altro?
La depressione “rappresenta una furia psicologica, di fronte ad un ambiente percepito come ostile e che quindi spaventa. La violenza è una reazione opposta alla precedente. Invece di fuggire dall’ambiente che spaventa, lo si assale per distruggerlo. Se si vuol capire la violenza, è necessario prima conoscere la paura”[2].
Come facciamo a stabilire quando una paura cambia di intensità e da esistenziale diventa clinica, da logica a patologica, da positiva a negativa? Quale è il Dio in grado di definire oggettivamente se siamo sani o malati? Come facciamo a sapere se una variazione di intensità corrisponde ad una variazione di stato? Quando la reazione alla minaccia della democrazia diventa una minaccia per la democrazia?
La paura che sovrasta le democrazie contemporanee è una paura senza oggetto che si proietta sui soggetti, sui nemici, sui terroristi. Una paura mediatica, immateriale. Una paura che non sappiamo gestire semplicemente perché non ha una causa principale, non è riconducibile a nulla, perché si fonda sullo stesso sistema che ci permette di vivere quotidianamente e che permette a me, ora, di scrivere questo testo[3]. Il nostro terrore dei terroristi raccoglie una paura eterea, senza che sia mai stata trasferita ad alcun altro oggetto, una paura soggettivata in un nemico, in qualsiasi nemico sia esso un immigrato, un criminale, un arabo, un cristiano o un islamico, un drogato o un clochard. E crediamo di ridurre la nostra insicurezza cercando di proteggere gli oggetti, gli aeroporti, le olimpiadi, i centri commerciali, il luoghi affollati e i siti delicati. I nostri apparati di protezione sono numerosi e sofisticati, costosi, ma la paura non scompare, anzi, aumenta d’intensità e di frequenza. Forse l’eccessivo consumo di cocaina in Occidente nasce proprio da questa profonda paura e dalla voglia di scappare nella forza artificiale, in un eroismo da immaginazione. Non sappiamo gestire la nostra paura patologica e senza oggetto per la forza che sappiamo di avere e per come sappiamo di usarla. E abbiamo paura che la risposta alla paura sia la nostra negazione. E allora fuggiamo, prede senza predatore. Il nostro negare è un modo per denigrare.
O non sarà che l’Occidente vive ancora la sua adolescenza, cioè una metamorfosi da uno stato a una condizione e quindi questa paura non è che una crisi di passaggio verso un nuovo modo di essere?
La crisi dei criteri di legittimazione internazionali della Sicurezza e dell’Equilibrio, successivi alla caduta del muro di Berlino, ci hanno fatto perdere tutto di un colpo le nostre certezze. Non abbiamo più né padre, né madre. Ci è rimasta la paura. Ma questa paura non è forse necessaria per acquisire una nuova identificazione, per cambiare gruppo di appartenenza, per superare l’Occidente e rivolgersi finalmente alla umanità intera? O si tratta di “una paura che diventa vigilanza e critica” e che “in questa metamorfosi” rischia di trasformarci “in un brutto ranocchio”[4]?
Gli psichiatri dicono che per superare la paura bisogna stare insieme. Ma se la paura è quella di stare insieme? Tacciamo. Tacere è il meccanismo di difesa di chi non vuole e non sa andare all’origine delle sue paure, perché non sa quale sia l’origine e, forse, perché non c’è una origine.
Paura Madre, genetica, innata, quella di Hobbes. Forse un evento che ha rinforzato il gene statmina nel ventre di sua madre; quando Lei ha sentito la paura della minaccia proveniente dalla presenza di navi nemiche nel porto. Paura del rischio di sopraffazione e di invasione. Una paura ambientale, appresa e, dunque, matrigna.
È quella della sopravvivenza l’origine degli umani?
La società di Hobbes è una società della cooperazione parziale contro la paura, una società che nasce dalla lotta alla paura e dal rifiuto della lotta per paura. Hobbes è un darwinista ante litteram. Egli pensava che il contratto sociale fosse lo strumento, l’artificio indispensabile per superare gli effetti distruttivi della lotta dell’uno alla eliminazione dell’altro, cioè la lotta per la selezione della specie sulla base della forza.
Le nostre città sono il luogo in cui il contratto di sopravvivenza tra individui prende forma fisica e attribuisce ai sopravviventi l’attributo di cittadini. In questo senso la città “è figlia delle grandi istituzioni politiche”. E quando cresce con il capitalismo e il processo di massificazione, diventa una istituzione “splenditamente” malata. Malata di ingovernabilità politica. A “partire dall’avvento del capitalismo” infatti la città diventa il luogo “delle grandi organizzazioni produttive che traggono giovamento dalla contiguità fisica, perché in questo modo più direttamente si rispecchia nel tessuto urbano il meccanismo del mercato e della concorrenza”. È un trauma. Il passaggio dalla città politica alla città economica determina un surplus di paura incontrollata e definitivamente incontrollabile. “La grande città è essenzialmente città-fabbrica, città-officina, luogo in cui una gigantesca invisibile catena di montaggio che costringe tutti a ripetere quotidianamente, oltre alla cerimonia del lavoro, una serie infinita di atti inutili”. Sono i grandi sistemi urbani che non hanno sconfitto la paura madre e matrigna del genere umano e hanno anzi interiorizzato il conflitto che Hobbes voleva scacciare appunto con il contratto sociale cittadino. Scrive Riuox: “Dalla bottega artigiana alla fabbrica, dal lavoratore al proletario, il cammino è lo stesso. Ma gli uomini sono più lenti dei capitali e delle tecniche: tarderanno spesso a prendere coscienza della loro nuova condizione, per mezzo del quotidiano contatto, soprattutto per mezzo della lotta. Prima che sia raggiunta questa consapevolezza della propria e dell’altrui identità, molto spesso una intera generazione sarà stata schiacciata senza pietà.”. Insicurezza. Ma altra insicurezza economica che si somma alla insicurezza politica. Insicurezza da divisione sociale del lavoro. Insicurezza di mercato, di merci di scambio. Il passaggio dalla città verde alla città nera è “una legge naturale del capitalismo in espansione”.
Forse però, alla fine, la paura che genera l’insicurezza ancestrale delle società e degli individui è più sfacciata perché più intima, più collettiva perché più privata, maggiore perché minima; una paura archetipica, una paura del passato che non riusciamo ad abbandonare, una sanguisuga, una piattola che ci prosciuga e che toglie possibilità ad ogni nostro futuro. La nostra insicurezza nasce, non dall’oscuro e indecifrabile futuro. La nostra insicurezza nasce dal passato, da ciò che siamo stati, dalla mancata accettazione di sé. La nostra insicurezza è il prodotto della paura di ciò che continueremo ad essere.
ooo/ooo
[1] BALBI Rosellina, Madre paura. Quell’istinto antichissimo che domina la vita e percorre la storia, Mondadori, Milano 1984
[2] SHUMYOTSKY Gled et al.: Starhmin, a gene Enriched, in Lateral Nucleus of Amigdala and in the CS and USpathways, controls both learned and innate fear, Cell, 18 novembre 2005, vol. 123, 697 – 709.
[3] ANDREOLI Vittorino, La paura, Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche, http://www.emsf.rai.it/grillo/tramissioni.asp?d=95
[4] ANDREAOLI V., cit. http://www.emsf.rai.it/grillo/tramissioni.asp?d=95
[5] È la stessa paura descritta da Freud,
[6] ANDREAOLI V., cit. http://www.emsf.rai.it/grillo/tramissioni.asp?d=95opedia Multimediale delle Scienze Filosofiche, http://www.emsf.rai.it/grillo/tramissioni.asp?d=95
[7] Gli animali mostrano anche minori reazioni di fronte a condizioni che in precedenza si erano dimostrate poco piacevoli, segno che i topi sono privi della normale memoria per la paura. “Anche se uno dei circuiti neutrali meglio conosciuti nel cervello dei mammiferi è proprio quello che controlla il condizionamento alla paura – commenta Shumyatsky – si sa ben poco dei meccanismi molecolari alla base di queste reazioni. Ora abbiamo scoperto che il gene della statmina ha un compito fondamentale nel controllo delle paure innate e di quelle acquisite. Va ricordato che la paura svolge un ruolo essenziale per la sopravvivenza”. SHUMYOTSKY Gled et al., cit. 2005, vol. 123, pg. 697 – 709.
[8] ANDREAOLI V., cit. http://www.emsf.rai.it/grillo/tramissioni.asp?d=95A





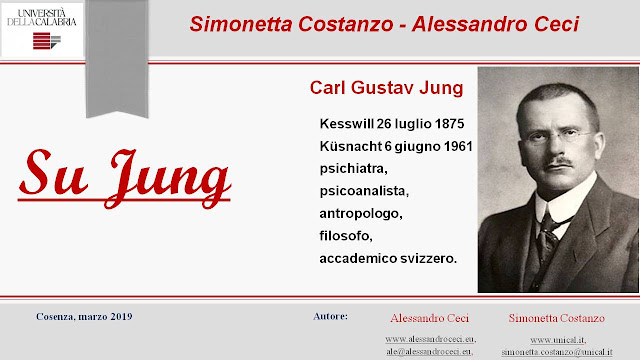


Commenti
Posta un commento