WETWARE PEDAGOGY 1 - Premessa
“… si spostò leggermente.
La stanza le parve improvvisamente ruotare.
Allora uscì sulla terrazza.
La paura si distese sulla strada, tra un palazzo e un altro, sotto il giallo sabbia pallore di un lampione. Gli umani si distendono sulle cose. Si trasferiscono all’esterno e allargano il loro mantello di sensazioni e immagini sulla strada. Ricordò un verso del poeta Texero, che vedeva il futuro esteso dalla finestra all’orizzonte. Il suo futuro era disteso e atterrito. Prono. Non aveva più casa, non aveva più soldi, non aveva lavoro. Scomparse le amicizie, amore minacciato, sopravvivenza a rischio. Era un momento così. Obbligata a tornare in famiglia. Le restava solo la paura.
Caterina aveva coltivato la paura fin da bambina. Ansimava e forse l’asma diagnosticata non esisteva, era soltanto il palpito affannoso della paura repressa.
Caterina camminava nella paura con disinvoltura, cercando di ricoverarla dentro il suo universo di silenzio e dietro la sua pigrizia. Poi la depositava sugli usci, sulle orme degli animali, su una sedia. La poggiava e giocava e saltava e correva.
Quand’era bambina, Caterina, sapeva salvarsi. Ed oggi ancora, per salvarsi, torna bambina. Oggi quando ha paura, Caterina, si rifugia nei suoi coetanei, nel gruppo di pari, in altri bambini, possibilmente nei nipoti, li porta alle giostre e li controlla, li carica in macchina, li porta al mare e corre con loro sul bagnasciuga o nell’acqua, gli compra le paste e li riporta a casa, dove ricomincia a correre e a gridare. Oggi ancora, tra la casa e la strada, forse nel suo giardino, o forse svicolando per le strade del mondo con la sua macchina nuova, cerca scampoli di sicurezza, angoli di fiducia, almeno un posto dove non ci sia minaccia, il luogo di un sereno consenso alla vita. Non tutti preferiscono ardere o morire. Tantomeno sappiamo se ardere o morire sia preferibile. Molti si rifugiano semplicemente nelle cose che hanno, preferiscono consumarsi nelle stagioni, disperdersi nelle ore di svago, confondersi negli appuntamenti e frequentare ricorrenze e compleanni.
Da sempre Caterina sapeva che questi lenti rituali nascondono il terrore delle età, il terrificante ritmo della degenerazione dei corpi.
La minaccia è occulta. Ogni giorno ti sembra un presente irrinunciabile, sei sempre uguale, dietro alle tue urgenze giornaliere e non ti accorgi di trascinare, in ogni minuto che passa, il tuo potenziale autodistruttivo. Forse te ne rendi conto solo quando sei giovane, prima ancora di cominciare. Ma rinunci a capire. Scarti il pensiero di lato. L’unica cosa che puoi fare è darti una forma, uno status giuridico, una competenza professionale, una condizione sociale. Ti serve la forma che è una tutela, l’abito per mille occasioni, lo scrigno della paura esistenziale del tempo.
La strada tagliava una campagna incolta di sterri e detriti e si infilava dentro case scomposte, nate spontanee, con una urbanistica incerta. A quell’ora di primo mattino si vede bene. La confusione non distrae. Di qua e di là della curva, può sempre venire qualcuno, a piedi, con calma o a velocità spavalda e pericolosa. Può comunque passare qualcuno in un’ora di primo mattino. Il mondo aspetta sempre lo stesso nuovo sole.
Caterina sapeva che per gestire quella spinosa, negletta paura, quella compagna che ti accompagna, bisogna tenerla con sé, portarsela dietro come un handicap insuperabile e dunque fraterno. Se non la possiamo eliminare, la possiamo gestire. Ancora oggi Lei deposita la sua paura sulla pietra del giardino di casa e poi la riprende, dopo essere tornata bambina, per salvarsi.
E non parla.
Evita.
Perché non parlava, perché già allora, nella sua infanzia, evitava. Per tanti anni, tutti, tutti i parenti, i fratelli e gli insegnanti, i cugini, gli amici perfino i suoi genitori credevano che Lei fosse incapace di pronunciare parole, quando invece era stupefatta dalla linea dell’orizzonte, dall’ampio cielo e dalle numerose stelle. Vedeva le figure immaginarie dei suoi immaginari animali, calcolava la dimensione di spazi incalcolabili ed aveva un suo personale e preciso sistema contabile. Gli altri non le sentivano emettere un suono; non a Lei e nemmeno alla sua amica paura. Perché in realtà non è mai stato vero che Caterina non parlava. Anzi, era loquace, chiacchierava e chiacchierava come quando si acciacca il tappeto di foglie morte della campagna d’autunno. O come quando si sgragnocchiano le patatine. Parlava e parlava di tutto, con un’amica, una sua cara amica che le viveva al fianco in ogni momento, per ogni suo attimo; un’amica che capiva perfettamente quel lessico anomalo, ma molto più ricercato e vero. Parlava in silenzio con il suo doppio: Lei chiacchierava a lungo con Caterina e non aveva bisogno di nulla. Talvolta emetteva un urlo, quello sì, un grido di ribellione e dolore, oppure gridolini di libertà e gioia, oppure due lacrimoni, soltanto due lacrimoni di miele, non di più, due splenditi lacrimoni lenti che le carezzavano le guance, in discesa. Ma niente suono; il tono muto dell’introspezione permanente, del passo discreto, delle parole senza rumore.
Per circa 6 anni nessuno aveva sentito da Lei pronunciare una sola sillaba. Ed era strano, perchè invece Caterina, con Caterina era molto spigliata. Parlava, eccome se parlava. Tante frasi composte a suo modo, termini pronunciati e ripronunciati a ripetizione. E non si rammaricava, non ne aveva bisogno. Caterina parlava con Caterina e sapeva di andare bene. Piuttosto si stupiva, si stupiva dello stupore degli altri. Se qualcuno la chiamava, il suo nome rimbalzava come un’eco dentro di sé, sballottolava sulle pareti immateriali del suo pensiero; e poi lo ripeteva alla perfezione a Caterina, la sua amica, la sua anima, che di rimando rispondeva nell’andirivieni della reciproca confidenza, una bella partita di parole tentate e pronuncie abbozzate. Così è il feedback della comunicazione biunivoca, una partita che, alla lunga, diventava un canto di lettere e suoni rimbalzanti.
Giocando, esaltata, con la voce squillante che nessuno sentiva, Caterina arrivava saltellando e allegra, con Caterina. Ma nessuno Le sentiva, perchè nessuno Le ascoltava.
…accadde un giorno...
...succede ai genitori di lasciare i figli, talvolta, a casa da soli. Specie se sono costretti a restare fuori per un poco di tempo, all’improvviso. Se uno dei fratelli è maggiore, di circa 4 anni, se é tanto assennato da poter badare all’altra bambina, già buona per suo conto e dunque priva di ogni dispetto, succede che i genitori si fidano, chiudono a chiave la porta d’ingresso ed escono un attimo solo.
Quel giorno successe così.
Era una mattina d’estate, quando non si va a scuola e nemmeno in primina. Caterina aveva disposto in bell’ordine le bambole sul letto e le presentava, una per una, qualcuna più grande di Lei, a Caterina. Erano le Loro amiche, le coetanee di ogni generazione. Una si chiamava di certo Carmela, nel rispetto della tradizione napoletana della famiglia, le altre non so.
Si sanno, invece, le asprezze che i fratelli si scambiano e il primogenito maschio vuole sempre occupare ogni spazio. Dovremmo costruire un mondo di ragioni, ma non ne siamo capaci. La nostra civiltà è nella giustizia, la nostra civilizzazione è nell’educazione. Al contrario della razza animale da cui lentamente si è differenziato nel corso dei secoli con la cultura, l’uomo trae la sua forza dal diritto. Per le bestie è vero l’opposto: la forza dà ogni diritto. Il bambino, più alto, fisicamente superiore, impose la sua regola animalesca e dispose che Caterina dovesse cedergli tutti gli spazi. Lei, muta e testarda, rifiutò. Sorse il conflitto. Tira e molla, metti e sposta, una bambola, proprio Carmela, subì una decapitazione violenta. La bambola rotta giaceva per terra. Caterina vide la testa di qua e il corpo di là. Fu un insulto che bruciava più di un rimprovero, più di qualsiasi frustata. Eppure Lei non aveva dato fastidio, aveva occupato il suo posto di sempre, lo spazio ricavato dentro i fragorosi movimenti della casa, la nicchia della propria intimità. Caterina cominciò ad urlare, senza tregua. Un grido tremendo, con il tono tenuto alto dalla rabbia. Era una forte arma di difesa contro i deboli attacchi di deboli uomini. Il povero ragazzo saltò. Poi cominciò a tremare. Infine, incredulo e imbarazzato cercò di sistemare la cosa. Ma non vi riuscì. Anzi, più ci provava, con tutti i mezzi di convincimento che conosceva e con ogni regalo di cui disponeva, e meno riusciva. Alla fine quel bambino si rese colpevole ed offrì alla sorella ogni disponibilità, ogni giocattolo ed ogni sua resa. Cercava una tregua, soltanto una tregua all’acuto infinito. Correva in fretta da un lato all’altro della stanza, recuperando regali e capricci. Dalla porta alla finestra, dalla finestra sul lettino, correva ovunque, correva e basta per sfuggire a tutti gli acuti e a tutte le urla. Finchè, ormai definitivamente atterrito, non vide entrare la madre.
Di colpo Caterina tacque.
La madre la prese con sé. È incredibile come le madri sappiano distinguere, d’istinto, il momento della tenerezza, il momento in cui darsi.
La donna sorrise. Accarezzò la testa del mortificato fanciullo. Sedette sul letto. Non proprio al centro, per non disturbare l’ordine illogico delle bambole. Sedette discreta su di un angolo. Prese Caterina in braccio e la cullò.
La made accennò una filastrocca, il ritmo lento e melodico della canzone che ogni volta acquietava la figlia e la tranquillizzava. “Il signor pensiero fa rumore / bussa alla porta del mio cuore, / bussa alla porta e porta l’amore / porta la gioia e sopporta il dolore.”
Lenta nenia di carillon, era la voce intonata di mamma, che cullava Caterina e le carezzava i capelli. La bimba era commossa, non certo abituata a queste effusioni che pure tanto desiderava. Sua madre era una donna severa e sempre più severa sarebbe diventata nel corso degli anni. Barbaro pulsare di violenza in ogni sguardo, dentro ogni errore, dietro tutte le incomprensioni. Le illusioni educative di chi obbliga senza insegnare producono l’abissale lontananza di uomini persi. Tanto preziosi sono i riposi, rubati all’amarezza della sfida, il luogo dove il corpo rinasce e l’anima respira.
La madre sentì i muscoli tesi della figlia distendersi tra le sue braccia, vide gli occhi socchiusi e il bordo nervoso del labbro cedere. Il mento aggrinzito si allargò, le tensioni sul viso si allentarono, gli zigomi si rilassarono. Aspettò ancora. Quando si convinse che la bambina stava per cadere nel sapore del sonno e forse nelle remote profondità del sogno, la spogliò, Le infilò il pigiamino, rassettò i giocattoli sparsi per la stanza, condusse il fratello, impietrito mentre assisteva alla scena, con una carezzevole spinta della nuca fuori la porta, accese la piccola abat-jour del comodino, spense la luce grande, aprì la leggera sopracoperta che proteggeva l’igiene e la pulizia e distese il tenero corpo bianco dentro bianche lenzuola. La rimboccò. Tirò su la copertuola a tutela di ogni reazione fisica della tensione nervosa che aveva depredato le piccole carni della bambina. Si chinò su di Lei e le baciò la fronte ancora sudata di rabbia.
E Caterina parlò.
“Buonanotte”, disse con la sua strana voce alitata. La madre, già sulla porta, si voltò e pianse commossa. Il fratello dette l’allarme e di corsa in un attimo tutta la famiglia si precipitò in quella cameretta, di un’altra casa, dove i figli stavano insieme, quadrata, con un largo spazio centrale per i giochi, per le lotte e per le sconfitte. E per le sorprese. Corsero ad assistere al miracolo. Lei si trovò seduta sul letto disfatto di nuovo, a ripetere con calma e con precisione le parole che gli altri volevano sentire, increduli, e che altrimenti già conosceva da tempo. Ancora una volta si stupirono in coro e, per l’ennesima volta, Caterina si stupì del loro stupore.
…se, tornando a casa, una sera, stanchi dalla confusa presenza del giorno o dal passare del tempo e degli anni trascorsi dentro entusiasmi spenti, uno dei vostri figli, ignaro del racconto e del rimpianto, magari il figlio più impunito e dispettoso, all’ora di cena, tra una portata tiepida e la paura di affondare, rompe un piatto e voi, braccati dalla sconfitta, con cortesia e delicatezza gli spiegate che non si deve fare e lo sostituite, perché vi attanaglia il ricordo di guerre infinite per scherzi puerili, e lui ne rompe un altro, e voi, con cortesia e senza delicatezza, lo sostituite e lui lo rompe ancora, quel piatto maledetto, e voi senza cortesia e senza delicatezza, ne mettete uno nuovo, perché non volete rassegnarvi alla cattiveria, che lui puntualmente rompe, vittima dell’impertinenza, e voi ormai alterati sbattete sul tavolo un piatto, lo stesso piatto dello stesso servizio, per vedere chi è più tignoso e lui testardo lo frantuma per terra, e voi irritati gli mollate uno schiaffo perché non ve ne frega più niente di ogni didattica e di tutta le calme pedagogiche dell’intellettualismo borghese: che cosa gli avete insegnato?
Niente, ma ci si è tolti una grande soddisfazione, penserà qualcuno.
A non rompere i piatti, diranno i più.
Ebbene, gli avete comunque insegnato che i conflitti relazionali si risolvono a ceffoni. Di piatto in piatto quel bambino, da grande, saprà bene di quanti muscoli di soldi, potere e carne avrà bisogno per sistemare le sue cose.
…Caterina invece rifiutava la violenza e quando Le hanno insegnato l’amore parlò”.


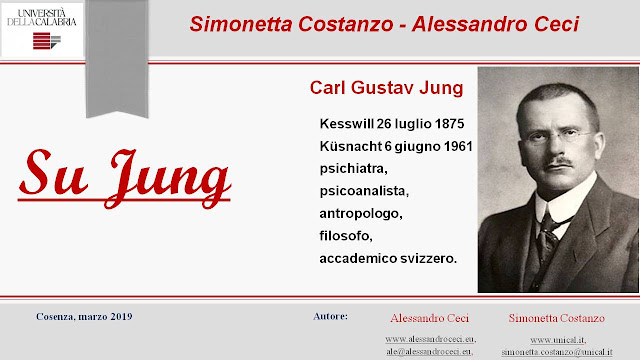


Commenti
Posta un commento