LETTERA SULLA QUASI PANDEMIA DA COVID 19
Per molti, la fine della quasi-pandemia da Covid 19 rappresenta un evento e, al tempo stesso, un avvento: l’alba di una nuova era, sembra un’accelerazione potente per l’evoluzione ulteriore dell’umanità.
Perché?
Eppure, a ben guardare, il COVID 19 ha minacciato la sopravvivenza della specie umana più di altri virus, pur avendo avuto molti decessi in meno.
Da dove proviene allora questo ottimismo nonostante una minaccia che si è trasformata subito in rischio per assenza di strutture e strumenti di contrasto?
Secondo Edward O. Wilson il fattore che ha assicurato all’umanità la sopravvivenza in un mondo estremamente pericoloso e la sua unica fitness evolutiva, è stata la particolare dimensione sociale, in grado di trasformare l’addestramento in educazione, generando così una memoria collettiva a cui attingere, un archetipo junghiano che evitasse alle generazioni successive ogni volta di ricomincia da capo. Si chiama il dente di leone della cultura il connotato della nostra intelligenza nel mondo. Anzi, egli afferma che gli esseri viventi che hanno conquistato la Terra, sono quasi tutti animali eu-sociali, cioè da quegli animali che sono in grado di costruire delle reti indispensabili alla propria sopravvivenza.
Wilson intende per eu-socialità “la condizione in cui vi sono generazioni multiple organizzate in gruppi grazie a una divisione altruistica del lavoro” e considera questa “una delle maggiori innovazioni nella storia della vita” che “ha creato i superorganismi, il livello successivo di complessità biologica al di sopra degli organismi”[1]. La socialità avrebbe assunto la funzione di “network di regolazione dello sviluppo”[2] che è dato dagli stati evolutivi superiori dovuti alle loro interazioni. Una evoluzione accelerata per gli umani che “creano le culture tramite linguaggi malleabili. Inventiamo simboli che dovrebbero essere comprensibili da tutti, e cosi creiamo reti di comunicazione di un ordine di grandezza molto superiore a quello di ogni animale.”[3].
Dunque, è sempre più vero scientificamente accertato che la società è ciò che siamo, in quanto travolti da un vortice autopoietico: la società genera soggetti sociali, che, con la loro azione e le loro relazioni, generano società. Siamo noi i genitori del nostro stesso habitat, con un’eccezionale competenza adattativa. La società, si dice, è un’ameba. La sua principale caratteristica consiste nelle trasformazioni della sua organizzazione mutante. Si altera, si riduce, si espande, diviene isterica, si calma, si commuove, s’inaridisce: cambia. Ad ognuna delle sue situazioni corrisponde una distinta connotazione. La complessità dell’habitat sociale è il prodotto del suo essere anche organismo, della molteplicità genetica delle sue forme. I soggetti sociali (partiti, sindacati, categorie, individui) sono gli elementi di questo complesso alveo protettivo; non gli effetti, non i prodotti, ma le determinanti, le connotazioni. In altri termini, i soggetti sociali non sono le apparenze di questo fenomeno, ma le sue essenze. È il loro modo di essere che caratterizza il modo di essere della società, il loro modo di comportarsi indirizza, qualifica.
Tuttavia la nostra preziosa socialità pesa sulla terra, pesa fisicamente, pesa sulla natura. E pesa a causa della duplice natura umana, di arte e artificio, libertà e coercizione: “…il nostro ambiente sociale, nella misura in cui è ambiente sociale, si manifesta come permanente ed universale coazione. Nell’uomo ci sono due nature: quella socievole, che si mostra, che appare evidente, e quella insocievole, che si desidera ad un certo momento. La prima è la nostra situazione normale. La seconda è una situazione utopica perché non si può stare fuori dalla società.”[4]
La società pesa anche per se stessa. Purtroppo, via via che la società diventa più tecnica, più specialistica, più fondata sulla competizione, un numero crescente di individui si dimostra incapace di reggere i ritmi di vita e di cambiamento così incalzanti. Si tratta del popolo dei barboni, degli inquilini delle stazioni ferroviarie e metropolitane, dei disadattati, dei disperati che attendono soltanto la morte, di coloro che soffrono per mancanza di amore, o pure a causa della propria solitudine e dell’indifferenza altrui. Insomma, il popolo degli infelici, per i quali è assurdo parlare di un progetto di felicità. Per migliorare la qualità complessiva della vita di tutti sarebbe sufficiente farli riemergere dall’inferno in cui vivono. Milioni di persone danno vita ad una città infernale che sta sotto la nascente città del sole in cui, al contrario nascono i vari modi di affrontare la vita e la cultura che molti chiamano nuovo umanesimo. Tutto accade a causa del progresso tecnico – scientifico, che non è demonizzante e che trasforma ogni vita quotidiana. E mentre trasforma la società, l’influenza della tecnica e della scienza, cambia anche il nostro modo di essere umani.
Poi, all’improvviso, un virus naturale e informatico ci paralizza come groviglio di serpi d’inverno.
Noi che eravamo educati all’ecumene, ad abitare la terra come se fosse solo casa nostra, considerando gli altri viventi un’eccezione, convinti che la società fosse una sorta di protesi utile (Hobbes) o inutile (Rousseau), o meglio, positiva o negativa; un artificio innaturale che si contrappone all’ambiente, improvvisamente un virus invisibile ci ha trasformati tutti in perseguitati, in “esiliati in casa come una malattia”[5] nella porzione di terra conosciuta, dall’appartenenza infettante e dall’apparenza inquinante. Ci siamo accorti improvvisamente che non possiamo vivere bene se altri stanno male. Non possiamo sentire decente la nostra vita, se ad altri non sono garantire pari condizioni fondamentali di salute e d’informazione, d’espressione e di comunicazione. Improvvisamente ci siamo ricordati che l’uguaglianza è componente fondante della qualità della vita, come un certo reddito, una certa ecologia e certi servizi. È l’uguaglianza che rende possibile la diversità, che a sua volta rende a ciascuno la sua unica possibilità di valere in quanto persona. Ci siamo accorti di vivere in un rischio concreto di tornare dallo Stato all’Orda, dalla forma all’informe, abbiamo ripreso a fare le cose che si fanno quando si crede che non si ha nulla da fare.
Alle porte della vita ci siamo riconosciuti uguali, povera gente che sa morire, che sa fantasticare, con qualche dignità ricevuta, data, trattenuta, in un mondo in cui il volto, la cui figura, la cui fisicità passa completamente in secondo piano rispetto alla divisa: mascherina, guanti, protezioni.
Albert Camus, di fronte al salto quantico dell’esplosione atomica, prese coscienza del fatto che “ogni generazione, senza dubbio, si crede destinata a rifare il mondo. La mia sa che non lo rifarà. Il suo compito è forse più grande: consiste nell’impedire che si distrugga”.
In realtà non è mai stato scritto in nessun luogo che l’uomo dovesse trionfare, e che una specie dovesse vivere in eterno. “L’umanità – diceva Sartre – è in possesso della sua morte.” Ogni passo avanti, ogni giorno di civiltà, è sempre stato una conquista, al prezzo di una minaccia complessiva che si è fatta sempre più definitiva, che è diventato un patrimonio culturale, che è incastonato nell’archetipo della umanità. Quel virus ci ha ricordato che possiamo regredire o precipitare addirittura ogni giorno e che ogni giorno dobbiamo far fronte al rischio con un successo relativo alle sfide che abbiamo davanti.
Folgorati dal flash di luce e verità del virus, esorcizziamo questa paura ancestrale, risorta paradossalmente a pasqua, con la ostentata credenza, con la presuntuosa arroganza della vendetta faticosamente dipinta in un futuro baldanzoso.
Torniamo alle nostre fraudolenze.
Dovremmo seguire il consiglio di Schumacher, secondo cui “il compito dell’uomo saggio è di capire i grandi ritmi dell’universo e sincronizzarsi con essi”[6] e invece siamo ancora al venditore di almanacchi di Leopardi, certo che il domani non potesse declinare. Siamo ancora fideisticamente illusi che nel futuro ci sia la completa soluzione esistenziale di ogni presente. Con una logica banale si crede, d’altronde, che se quel risultato non è negli anni che, semplicemente non c’è più.
Venditore - Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari nuovi. Bisognano, signore, almanacchi?
Passeggere - Almanacchi per l’anno nuovo?
Venditore - Si signore.
Passeggere - Credete che sarà felice quest’anno nuovo?
Venditore - Oh illustrissimo si, certo.
Passeggere - Come quest’anno passato?
Venditore - Più più assai….
Mi sono sempre chiesto se il venditore incontrato nel 1832 da Leopardi fosse veramente convinto o se fosse suadente soltanto per vendere più almanacchi e lunari. Propendo per la seconda ipotesi e, quindi, contrariamente al poeta, credo che quella illusione apparentemente salda, fosse in realtà un trucco smaliziato da ambulante, un marketing da strada che blandiva semplicemente le aspettative, più orientato alla soluzione delle crisi finanziarie individuali nel presente che alla cognizione delle future possibilità.
Almanacchi, almanacchi: oggi non possiamo muoverci di casa ma tra qualche anno le macchine voleranno, ogni malattia sarà curabile e la morte sempre più allontanata.
Almanacchi, almanacchi, comprate almanacchi: oggi il potere degli altri è arcigno, ma domani, il nostro, sarà cordiale e costruirà una società conviviale.
Almanacchi, almanacchi: il futuro sarà la giostra dei nostri desideri, purché compriate da me, ora, subito, questi almanacchi o qualche lunario.
Almanacchi, almanacchi e lunari: ogni demone verrà assorbito nelle oscurità delle tenebre dalla luce abbagliante di Dio, purché, nel presente occultato compriate i nuovi almanacchi magici in cambio di soldi pratici.
Il presente deve essere sempre un imbroglio, se il futuro vuole essere evangelico.
Così siamo invasi da una pletora di invasati venditori di almanacchi, che volgarmente ci propinano un futuro fantasmagorico per defraudarci del presente possibile.
L’idea che dopo il coronavirus il tempo sarà migliore, con una relazionalità ridotta e una connettività indotta, è un altro colpevole furto da venditore di almanacchi.
Diceva Kiekergard “ciò che sono è nulla, questo procura a me ed al mio genio la soddisfazione di conservare la mia esistenza al punto zero, tra il freddo e il caldo, tra la saggezza e la stupidaggine, tra qualcosa e il nulla, come un semplice FORSE”[7].
Come sarà il futuro non lo sappiamo. Non lo possiamo sapere. Sappiamo, possiamo sapere come siamo oggi e questo ci può bastare: perché soltanto se saremo noi, oggi, il futuro che desideriamo, il futuro che desideriamo sarà migliore del presente che siamo, oggi, qui. È sempre e solo nel presente che si gioca tutta intera la partita. Soltanto nel presente vigile.
Siamo noi qui, ora, il futuro che vogliamo essere se, nonostante il virus corruttore, vinceremo “quotidianamente il suo invito all’inerzia”, perverso, “la nostra nemica”, “il nostro vizio fondamentale”. In questo, semplicemente in questo, c’è tutta intera l’assoluta grandezza della politica, la sua inequivocabile egemonia. Ogni volta che, con superficialità e opportunismo, deroghiamo a questo principio, bruciamo un almanacco. Ogni volta che evitiamo una mascherina, incrementiamo la possibilità che la minaccia per noi stessi divenga un rischio per tutti gli altri.
Questo ci insegna davvero questa esperienza di quasi-pandemia: non meno socialità (è impossibile), ma più responsabilità.
Molta più responsabilità.
La responsabilità di essere per esistere. La responsabilità di conoscere prima di credere. La responsabilità di offrire prima di chiedere. E poi, la responsabilità di favorire la riflessione critica allo schiamazzo fideista, contro “il cra-cra delle ranelle” come diceva Pascoli. La responsabilità, infine, di preferire sempre l’etica alla morale. L’etica è collettiva o pubblica. La morale è individuale o personale. Bartuglia e Vaio descrivono la situazione così: “I trasporti pubblici, nell’ipotesi che si mantengano soltanto con i proventi della vendita dei biglietti, possono fornire il servizio cui sono destinati solo se un numero sufficientemente elevato di viaggiatori paga il biglietto. Non è necessario, tuttavia, che ogni singolo passeggero paghi il biglietto affinché il servizio possa essere effettuato: basta che il biglietto sia pagato da un numero di viaggiatori sufficienti a coprire le spese. Ora, per ciascun viaggiatore la situazione più vantaggiosa si ha quando egli non paga, ma gli altri viaggiatori si, in modo da permettere il servizio pubblico. Se ciascun viaggiatore, però, libero di decidere,adottasse questa strategia ritenendola la migliore, allora nessuno pagherebbe il biglietto e il servizio cesserebbe; la conseguenza sarebbe che ciascun viaggiatore dovrebbe ricorrere al trasporto privato, molto più costoso di quello pubblico. Si configurerebbe così, per ciascun viaggiatore, una situazione economicamente peggiore di quella che si avrebbe se ciascun viaggiatore pagasse regolarmente il biglietto”[8]. Vale per ogni cosa, per ogni furbizia malcelata, per ogni biglietto simbolico non pagato. È l’Italia piena di morali soggettive senza un’etica oggettiva.
La socialità, invece, quella socialità che secondo Wilson ci ha resi umani, ha il suo fondamento nell’etica che trasla l’interesse personale e privato di ogni morale nella dimensione collettiva, pubblica dell’etica, quale arricchimento fisiologico della nostra intelligenza.
In questi anni siamo stati sopraffatti, invece, da morali personali urlate per farle sembrare collettive. Siamo stati travolti da una sovrabbondanza di parole vuote e vacue d’interessi privati, nel doppio senso ambiguo del termine: di interessi personali e di interessi che ci sono stati sottratti. È un’insolenza nota: quell’insolenza, al dire di Roberto Calasso “della civiltà che vuole essere cosciente di se stessa, e intanto si distrugge”.
Travolti dalla sovrabbondanza illusoria di venditori di fortuna, oggi abbiamo la responsabilità etica di tutelare la nostra specie e la nostra intelligenza. “L’intelligenza organizza il mondo organizzando se stessa”, diceva Piaget.
La responsabilità che ci insegna questa violenta esperienza di quasi-pandemia è quella etica di ripristinare i meccanismi, le strutture, i ruoli, le funzioni e le prestazioni della socialità per rispettare una realtà della vita prim’ancora della verità di ogni fede. È una responsabilità epistemologica, un’etica della lebenswelt[9], della scienza della vita che tutela e accresce la nostra intelligenza nel mondo. E la nostra sopravvivenza.
È, dunque, inevitabile.
ooo/ooo
[2] WILSON O. E., cit.2014
[3] WILSON O.E., cit. 2014
[4] ORTEGA Y GASSETT José, L’uomo e la gente, Armando Editore, Roma 2002
[5] Thomas Mann diceva che una volta scacciato dalla Germania Nazista – come racconta Ralf Dahrendorf -, “sentiva l’esilio come una malattia”.
[6] SCHUMACHER F. Ernest, Piccolo è bello, Musia Editore, Milano 2011
[7] KIERKERGARD Søren, La malattia mortale, SE, Milano 2019
[8] BERTUGLIA C.Sergio – VAIO Franco, Complessità e modelli, Bollati Boringhieri, Torino 2016, p.504
[9] HUSSERL Edmund, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Il Saggiatore, Milano 2016


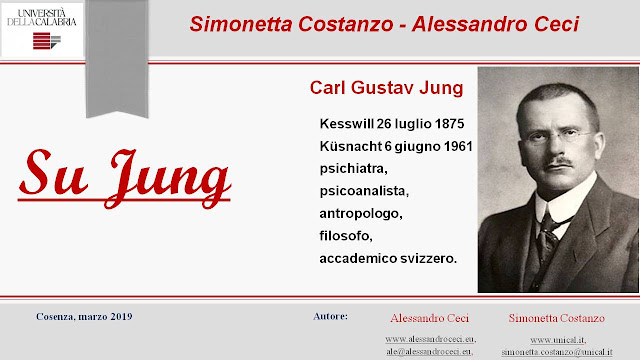


Commenti
Posta un commento