INTELLIGENCE: LO STAND DI ELVIO CECI
La perversione genetica che ho trasmesso a mio figlio è la passione per i libri.
Non so se vantarmi o no.
So che Lui li cura più di me, li annusa più di me, più e meglio di me li riconosce e poi li conosce.
Un giorno, vagando con il corpo e con lo sguardo, lungo gli stand della ricorrente fiera del libro “più libri più liberi” di Roma, Elvio scruta e scorge un volume strano, veramente corposo, abbandonato, isolato in un angolo nello scaffale in alto della piccola libreria commerciale. Sembrava un obeso, nella solitudine della emarginazione; un ciccione accomodato in una poltrona in disparte, impigrito e rimpinguato in un angolo di una festa tra atleti.
Attratto, come tutti gli intellettuali, dalla estraneazione del difforme nella folla etero diretta del gruppi di pari, mio figlio si avvicina, prende quel libro grosso e grasso che sembra un personaggio di Bodero, lo valuta, lo pesa e lo compra. Costava 50 euro. Uno sforzo finanziario per un ragazzo. E anche per me. Lui però non molla. Porge il libro al venditore per lo scontrino e prepara i soldi. Quello, stupìto, lo guarda, esterrefatto, lo interroga:
“voi davvero sto’ libro?”
“Si”, risponde Elvio.
“Ma sto’ libro nun lo vo nessuno”.
Elvio, mio figlio, più educato di me, tace e pensa: “lo voglio io!”.
Il bravo venditore interpreta e anticipa: “vabbhé… damme 30 euri, va!”
Un bel risparmio. Quasi il 40% del prezzo di copertina.
Elvio non perde l’occasione.
Felice, paga e accaparra il voluminoso libro.
Lo standista si era liberato di un mattone. Elvio aveva scoperto un nuovo amico: aveva conosciuto Melandri.
Fu un amico molto prezioso, molto importante perché cambiò, in qualche modo, la struttura della nostra ricerca sugli ordini logici, di cui avevamo abbondantemente discusso e disvelò, a lui per primo e, tramite lui, anche a me, l’analogia e la logica endofasica.
Analogia e logica endofasica, per dirla in estrema (molto estrema) sintesi, è ciò che ci ha distinto dagli animali, l’acquisizione della intelligenza nella fitness evolutiva. Dunque, ci sono 2 ambiti precisi a cui questa soluzione (per non dire scoperta) ci coinvolge: sia in merito alla logica, sia in merito alla antropologia.
Lasciamo stare l’antropologia. Per l’intelligence qui ci interessano le dimensioni logiche.
In ogni testo c’è un punto da centrare.
Nello studio di Elvio Ceci sulle dimensioni logiche il concetto da tenere a mente è implicito. Noi siamo stati abituati a pensare che nel nostro cervello, o in qualche altra parte, come l’anima che non si sa dove sia, anche la logica vaga tra neuroni e sinapsi. Comunque dentro di noi.
Invece, non è così. Nella nostra concezione, invece, la logica è nei fenomeni, esterni a ciascuna persona (se questa demarcazione tra interno ed esterno vale ancora), a cui ci adattiamo per sopravvivere. E sopravviviamo perché, in varie epoche storiche, abbiamo acquisito diverse dimensioni logiche dall’habitat in cui viviamo e che noi stessi abbiamo costruito. L’intelligenza, diceva Piaget, organizza il mondo organizzando se stessa. La logica sta li, in quell’habitat, in quei fenomeni, forse a dimensioni molto superiori a quelle che noi abbiamo appreso, incorporato, interiorizzato. Dunque, corrispondentemente alle 4 mutazioni sociali di habitat (la conquista della posizione retta e il potere della sopravvivenza – ontopower -, la verticalizzazione delle strutture fisiche e sociali – egopower -, la rivoluzione industriale e l’era atomica – biopower -, e oggi l’avvento dei network e della società della comunicazione – epipower -) noi abbiamo acquisito 4 dimensioni logiche (logica endofasica, logica formale, logica computazionale, logica quantistica).
Grazie all’incontro con Melandri, Elvio Ceci ha capito profondamente la funzione dell’analogia nella organizzazione logica dell’umano e la spiega così: “Melandri (1968) ha individuato sette famiglie di argomenti analogici che permettono la formazione di interpretazioni e concettualizzazioni di un fenomeno: esempio o paradigma, proporzione o analogia di proporzionalità, interpretazione o analogia attributiva, entimema o argomentazione retorica, induzione intensiva o merkmalsinduktion, tropi induttivi, tropi retorici. Hofstadter e E Sander (2015) affermano che dagli atti più banali alle intuizioni geniali, alla base c’è sempre una categorizzazione continua attraverso la creazione di analogie. Da qui, noi possiamo avere cognizione del mondo: alla base di ciò non c’è la classificazione, la quale tende a inserire enti e eventi in insiemi rigidi e stabili; ma il fenomeno della categorizzazione tramite la creazione di analogie, che rende il pensiero assai flessibile. Le analogie producono concettualizzazioni in diversi ordini della produzione linguistica: nomi (i confini semantici delle parole sono ampliati dalle analogie), espressioni idiomatiche, avverbi temporali, interazione con il contesto, analogie inconsce, analogie consce, analogie ingenue o scientifiche.”[1]
Dunque all’origine dei nostri pensieri c’è l’analogia e, questa analogia che rende flessibile la nostra mente, è all’origine anche della nostra fitness evolutiva, che ci ha fatto diventare più intelligenti di tutti gli esseri viventi noti. Seguono poi, in successione regolare a causa delle mutazioni sociali: “LOGICA FORMALE. - Informatività. Misurazione degli elementi dell’informazione che sono attesi o meno, noti/ignoti/incerti. Incentrata sul contenuto, è fondamentale nella scelta e disposizione delle varie opzioni di testo. Si ricerca la corrispondenza o meno con i dati: si valuta se una informazione rientri o meno in una categoria che già si possiede. – Situazionalità. Insieme di fattori che rendono rilevante un testo/informazione per una situazione comunicativa reale o ricostruibile. Correlazione tra testi/informazioni. Credibilità e rilevanza assunte da un testo/informazione per l’atteggiamento dei parlanti verso la situazione. LOGICA COMPUTAZIONALE. – Coesione. Legato alla grammaticalità di un testo di superficie, che è conservato nella memoria attiva, di lavoro, «a breve termine». - Coerenza. Legato allo stato conoscitivo di un testo, cioè alla connessione fra i contenuti presenti nel testo; la continuità di senso all’interno del sapere attivato con le espressioni testuali. Analizza che le strutture di superficie siano meglio conservate nella memoria «a breve termine», il contenuto contestuale resta impresso nella «memoria a lungo termine». LOGICA QUANTISTICA. – Intertestualità. Analizza le interdipendenze fra produzione e ricezione di un testo/informazione dato/a e le conoscenze di altri paesi possedute dai partecipanti alla comunicazione.”[2]
È errore pensare che tutto questo non c’entri nulla con l’intelligence.
Invece questo è l’intelligence.
Abbiamo delle informazioni, possibilmente clusterizzate, di vario tipo. Le scremiamo in qualche modo, cioè metodologicamente e/o tecnologicamente. Poi le analizziamo. La prima fase è comparativa, di ordine endofasico. Si studiano le analogie tra eventi con un alto grado di similarità. Poi, sempre metodologicamente o tecnologicamente si passa ad una valutazione complementare o paradigmatica (evidenziazione delle anomalie), di ordine formale, relativa alla razionalità dei casi o degli eventi con analogia positiva. Queste informazioni logiche devono essere valutate sul piano della loro capacità informativa e dalla loro congruenza (correlazione e credibilità) situazionale. Il terzo step alternativo o dialettico consiste nel vagliare le informazioni selezionate in dimensione computazionale, cioè considerando se siano giuste o sbagliate, sulla base della loro coesione e della loro coerenza. Infine la quarta fase integrativa, cioè l’analisi oggi più importante per definire la morfologia reticolare di un evento, è la quarta dimensione quantistica, cioè l’analisi delle sue connessioni, il posizionamento dei soggetti, la valutazione del loro peso, la ponderazione del caso, l’interdipendenza delle variabili.
A conclusione dell’applicazione di questo modello denominato COMP (Complex Order Multiphasic Program), sia metodologicamente sia tecnologicamente, è possibile rappresentare l’intero processo analitico con mappe connettografiche di nuovo tipo.
IL GIOCO
Un osservatore italiano deve capire la regola che associa la parola alla controparola d’ordine per l’ingresso in un importante sito nazionale.
Si apposta e osserva.
All’improvviso si avvicina una persona che, raggiunto il cancello d’ingresso suona al citofono. Una voce da dentro dice “24”, lui risponde “12” e gli viene aperto.
Dopo poco la scena si ripete: arriva un altro uomo, citofona. Da dentro gli dicono “12”, l’uomo risponde ”6” e gli viene aperto. Passa del tempo e, per la terza volta, qualcuno si avvicina al cancello. Citofona. Una voce metallica da dentro dice “6”. Il terzo uomo risponde “3” ed entra.
Stanco di essere stato fermo per un’intera giornata, il nostro osservatore torna a casa. Si riposa per ricominciare il giorno dopo.
Il giorno dopo ritorna. Si apposta e vede la stessa scena: arriva un uomo, citofona, gli dicono “10”, lui risponde “5”, gli aprono ed entra; ancora un altro uomo, citofona, da dentro dicono “8”, lui risponde “4”, aprono ed entra.
Forte della sua informazione, la nostra spia si sente sicuro e decide di entrare nel sito segreto. Si avvicina con fare normale al citofono e preme il campanello.
Una voce metallica dice “4”.
Che cosa avreste risposto voi?
Sta di fatto che il nostro improvvido esperto di intelligence risponde “2” e un cecchino preciso dalla finestra lo fredda.
Perché?
Perché in italiano, visto che il sito segreto è italiano, il numero ventiquattro è composto di dodici lettere, il numero dodici di sei lettere, il sei di tre lettere. Anche il numero dieci è composto da cinque lettere e il numero otto da quattro lettere, ma il numero quattro non è composto da due lettere (da sette).
C’era una ambiguità ancora alta e almeno due diverse dimensioni logiche.
L’errore del nostro eroe è stato di agire in condizione di forte ambiguità
Nella società della comunicazione, più di ogni altra della storia dell’umanità, di ambiguità di questo tipo ce ne sono una infinità. E noi possiamo dipanarle parzialmente utilizzando soltanto 4 dimensioni logiche, quelle che abbiamo potuto adottare per adattarci alla complessità del nostro habitat.
Seguendo lo schema di Elvio Ceci, nella nostra attività di intelligence, partiremo dalle analogie, per passare alle coerenze, continuando con giustificazioni epistemologiche, fino alla analisi della simbiosi tra verità e realtà.
Senza un approccio multidimensionale di questo tipo, l’intelligence non è null’altro che una rincorsa tra guardie e ladri, tra spie e spioni.
Invece…
(continua…)







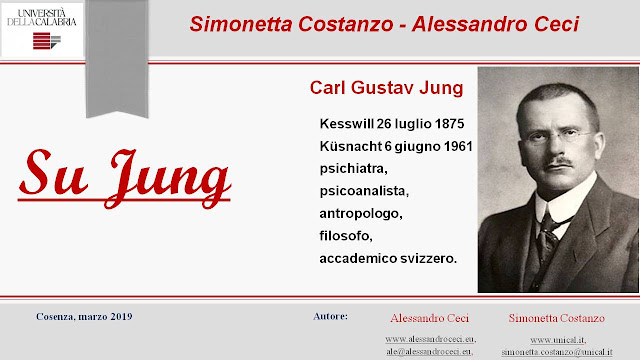
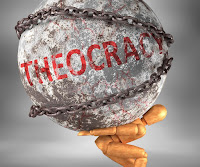

Commenti
Posta un commento