INTELLIGENCE: L'ENERGIA DI RUSSELL
In termini di epistemologia delle scienze sociale, l’economia ha fatto più danno che altro.
L’economia, o in modo più preciso l’economia neo classica e marginalista di Warlras, ha mutuato il concetto di energia e di equilibrio dalla fisica. “L’economia neoclassica cerca di impostare la scienza economica come un’economia matematica, lungo la stessa linea seguita dalla fisica, e di descrivere le dinamiche economiche nella società secondo le modalità del L’economia ha mutuato questa dinamica della fisica e l’ha introdotta nelle scienze sociali; cioè “si cerca così di identificare una funzione adatta a svolgere il ruolo che l’energia svolge nella fisica, una funzione di cui cercare massimi e minimi per definire gli stati di equilibrio.”[3] In questo modo si è fatta una operazione che ha confuso e corrotto le scienze sociali e definitivamente rovinato l’economia.
Dove sta l’errore? Soltanto nell’utilizzazione del linguaggio matematico nelle scienze sociali, necessario ma non sufficiente perché, come ho già sostenuto, permette di contabilizzare i dati ma non di ponderare i valori?
No, non solo, sebbene questa differenza fa gran parte della differenza.
In questo caso l’errore è un altro e molto più determinante.
Si tratta di un errore logico.
Utilizzando come in fisica l’energia quale fattore fondamentale nella dinamica economica, si cercano stati di equilibrio, prima competitivi e poi – grazie al notevole contributo di John Nash – collaborativi, endogeni, se non addirittura (talvolta) automatici. E questo è uno dei motivi principali per cui gli economisti interpretano bene, ma prevedono male.
L’errore che si compie è un errore di simmetria della funzione: si considera la simmetria della funzione di energia, laddove questa simmetria non c’è o, meglio, laddove la simmetria è altra..
Facciamo un esempio.
Ilya Prigogine, da buon chimico, afferma che “un liquido è uno stato della materia nel quale le molecole si muovono in tutte le direzioni e non si riconoscono l’una con l’altra lungo distanze maggiori di poche centinaia di milionesimi di centimetro.”[4] Esiste dunque una energia che spinge tutte le molecole in tutte le direzioni, senza riconoscersi e, dunque, senza connettersi tra di loro.
Mi chiedo: è questa la energia che si considera in economia e nelle scienze sociali?
Le molecole anarchiche e solitarie sono pur sempre un elemento, se non addirittura un elemento fondamentale, della energia che deve essere preso in considerazione perché, proprio il loro movimento e la loro assenza di riconoscimento sono il presupposto della reversibilità fenomenologica, cioè del fatto che i fenomeni possano ripetersi nelle medesime condizioni.
Nelle scienze sociali questo processo non si verifica mai perché non esiste proprio. Ogni fenomeno delle scienze sociali è irreversibile, si verifica una volta soltanto e poi non si verifica più. È l’equivoco del coeteris paribus che in economia si utilizza frequentemente; l’equivoco cioè di cercare una regola ripetibile a parità di condizioni. Il fatto è che nelle scienze sociali la parità delle condizioni, il coeteris paribus, non c’è mai. Assolutamente mai. È una variabile semplicemente inesistente. E ragionare su variabili inesistenti è la più piacevole condizione del fantasticare.
Perché, però? Perché i fenomeni sociali sono sempre irreversibili mentre alcuni fenomeni fisici possono essere perfettamente reversibili?
Iliya Prigogine spiega benissimo che non è la simmetria, in qualche modo statica, ma la rottura di simmetria che genera l’energia necessaria alla dinamica dei sistemi: “la rottura di simmetria è concomitante all’apparizione di nuove proprietà che ci fanno ritenere il materiale ordinato.”[5]
In un mondo in cui le molecole vagano all’infinito, in ogni direzione e senza riconoscersi, una rottura di simmetria consiste nel riconoscersi e nel connettersi. Quando c’erano solo cellule procariote, queste disperdevano la propria energia (entropia) in uno stato di equilibrio immutabile. Quando una di queste cellule è diventata eucariota, la diversità le ha fatte conoscere e riconoscere, si sono connesse tra di loro, c’è stata una rottura di simmetria, una “fase di non-equilibrio sulla base dei loro raggi d’azione molto diversi”[6]. Così si è generata la vita sulla terra e si è scoperta la funzione del tempo. Scrive Prigogine “la storia dell’inizio dell’universo e, in particolare, la sua espansione, è effettivamente segnata dal passaggio da uno stato di equilibrio termico a uno stato nel quale viene rotto sia l’equilibrio fra diversi costituenti della materia sia quello fra materia e radiazione”[7]. Continua: “in un tale ambiente di non-equilibrio possono aver luogo transizioni di rottura di simmetria su larga scala”. E conclude “sotto questo aspetto dunque, la materia differenziata come la osserviamo oggi si può pensare come il risultato di un primordiale non-equilibrio.”[8]
Questo è il punto: poiché si occupano, non della energia, ma delle connessioni, le scienze sociali (e anche l’economia che tenta comicamente di sfuggire) affrontano sempre e soltanto fenomeni irreversibili in stato di non-equilibrio. Insomma, i fenomeni che generano e governano la vita.
E, poiché si occupano non della energia ma delle connessioni (o al limite delle relazioni, che sono la forma di energia prodotta dalle connessioni), le scienze sociali (pure l’economia, nonostante tutto) hanno come gestore fondamentale dei loro stati di non-equilibrio, il potere, cioè il regolatore della ponderazione, quello che fa pesare più o meno determinate connessioni rispetto ad altre, che curva, più o meno, lo spazio relazionale e accelera, più o meno, i tempi di realizzazione.
Il potere.
Le scienze sociali si occupano (e si preoccupano) delle connessioni e non dell’energia. Il loro dominus, da sempre nella storia dell’umanità, è il potere.
In un libro pubblicato in Inghilterra, per le edizioni Allen e Unwin nel 1938, Russell sostiene che “il concetto fondamentale della scienza sociale è il potere, allo stesso modo che nella scienza fisica il concetto fondamentale è quello di energia”[9]. Il potere in valore assoluto, in quanto funzione permanente di ogni habitat sociale: “le leggi della dinamica sociale possono essere enunciate soltanto in termini di potere, non in termini di questa o quella forma di potere.”[10]
Volendo mantenere il rigore del linguaggio matematico, possiamo enunciare la formula:
P : S = E : F
il Potere sta alle scienze Sociali come l’Energia sta alla Fisica.
Dunque sarebbe stato il caso che l’economia avesse tracciato principalmente la funzione del potere per la dinamica dei sistemi sociali, piuttosto che quella della energia.
È chiaro allora che il rapporto tra intelligence e potere è un rapporto essenziale ed esclusivo; specie nella società della comunicazione, nell’epoca dei network, in cui tutto il dominio fenomenologico del potere è dato soltanto dalle connessioni. Anzi, si può addirittura stabilire il punto in cui l’intelligence svolge una funzione omogenea al potere e il punto in cui l’intelligence sfugge al controllo democratico. È facile. Da questo punto di vista è una formula addirittura banale.
Quando l’intelligence è funzione del potere [I = f(p)], siamo tranquilli, sappiamo con chi prendercela per le sue eventuali deviazioni e le connessione mantengono la forza della legittimità politica, indispensabile sempre per articolare un network sociale..
Viceversa quando il potere è funzione dell’intelligence [P = f(i)], tranquilli lo siamo molto meno, perché gli apparati sfuggono al controllo e il network sociale perde di legittimazione e rischia di disarticolarsi.
È un problema che riguarda la democrazia e, come ho scritto una volta[11], il problema della sua ontogenesi. Lo vedremo meglio la prossima volta.
(continua… )
ooo/ooo
[1] BERTUGLIA Cristoforo Sergio e VAIO Franco, Complessità e modelli, Bollati Boringhieri, Torino 2016, p.481
[2] BERTUGLIA C. S. e VAIO F., cit. 2016, p.481
[3] BERTUGLIA C. S. e VAIO F., cit. 2016, p.481
[4] PRIGOGINE Ilya, La Complessità, Einaudi, Torino 1992, p.49
[5] PRIGOGINE I., cit.1992, p.49
[6] PRIGOGINE I., cit.1992, p.52
[7] PRIGOGINE I., cit.1992, p.52
[8] PRIGOGINE I., cit.1992, p.52
[9] RUSSELL Bertrand, Il Potere, Feltrinelli, Milano 1970, p.13
[10] RUSSELL B., cit. 1981, p. 13
[11] CECI Alessandro, Intelligence e democrazia, Rubettino, Soveria Mannelli, 2006.
[5] PRIGOGINE I., cit.1992, p.49
[6] PRIGOGINE I., cit.1992, p.52
[7] PRIGOGINE I., cit.1992, p.52
[8] PRIGOGINE I., cit.1992, p.52
[9] RUSSELL Bertrand, Il Potere, Feltrinelli, Milano 1970, p.13
[10] RUSSELL B., cit. 1981, p. 13
[11] CECI Alessandro, Intelligence e democrazia, Rubettino, Soveria Mannelli, 2006.





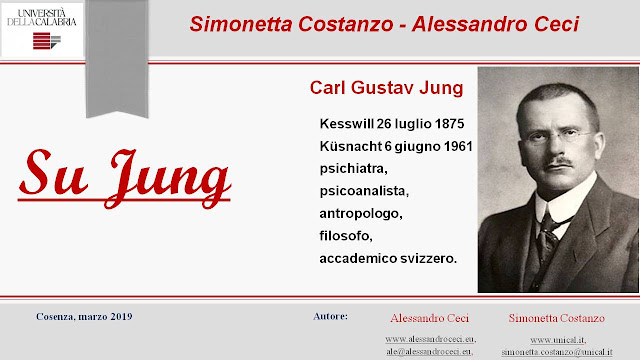
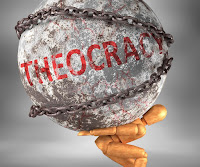

Commenti
Posta un commento