INTELLIGENCE: LA FEBBRE DI SARTORI
Dunque i dati in Intelligence vanno conteggiati e ponderati.
Conteggiarli è più facile.
Ponderarli molto meno.
Il primo concetto propedeutico alla ponderazione che dobbiamo fissare nella nostra mente è che, come l’universo di Einstein, i dati (e più in generale le informazioni) curvano lo spazio delle relazioni comunicative. Proprio perché pesano, le informazioni e le comunicazioni rendono lo spazio relazionale concavo.
È chiaro, ad esempio, che una informazione, oggi, sul COVID 19 curva lo spazio più di una informazione sul calcio fermo e quindi determina, proprio come nella teoria della relatività generale, un’attrazione e una accelerazione dell’attenzione collettiva. E questo accade appunto perché il peso della notizia ci fa scivolare dentro la curvatura di spazio comunicativo che esso stesso genera. Se poi quella notizia, che curva lo spazio relazionale della comunicazione e ci fa scivolare dentro il suo dominio con l’incredibile accelerazione della sua attrazione, sia vera o falsa (o meglio, se sia vera o reale) è tutto un altro discorso.
Un discorso proposto alle scienze sociali (e all’intelligence) da Giovanni Sartori.
In un libro di molti anni fa[1], pubblicato in italiano nel 1980 (e credo mai più colpevolmente ripubblicato), decisamente sottovalutato dal punto di vista della epistemologia delle scienze sociali, tra le altre tutte molto importanti, il problema della ponderazione è ben espresso in 5 succose pagine, dalla 135 alla 140. Il sottocapitolo si intitola appositamente “il peso delle parole”.
Egli stesso ci dice come impostare la questione.
“Mettiamola in questo modo: nell’analisi logica le parole non hanno peso o – potremmo anche dire – pesano tutte uguali, hanno sempre lo stesso peso. Così, «acqua» per denotare l’acqua contenuta in una bacinella, è lo stesso che «acqua» per denotare il contenuto dell’Oceano Pacifico. «Dolore» per denotare un mal di testa, è lo stesso che «dolore» per denotare la sensazione di chi resta schiacciato da un’automobile. Dunque, una stessa parola può essere usata non solo in significati diversi, ma anche – in ordine allo stesso significato – con un peso profondamente diverso. Naturalmente tutti noi avvertiamo questa differenza di peso.”[2]
Tuttavia più esplicativo è il secondo esempio.
“Ovviamente, nessuno nega l’enorme vantaggio di passare da vaghi attributi qualitativi – come «molto» e «poco» - a precise misure espresse da valori numerici. Ci regoliamo tutti meglio se invece di «molta febbre» sappiamo che è di 38 ma non 42 gradi. Ma la conversione del qualitativo nel quantitativo ci ha fatto perdere di vista che esiste anche un problema di riconversione della quantità in qualità. I gradi 34 e 44 di un termometro centigrado non significano niente, sono numeri come tutti gli altri, se non li ricolleghiamo al fatto che al di sotto o al di sopra di quei valori numerici un essere umano muore. Non è che 45 è 44+1; è che a 45 gradi siamo morti: e questo si converrà, è un bel salto, una discontinuità (qualitativa). Nel nostro termometro lo 0 è importante perché indica che l’acqua si congela; il 44 è importante perché indica la nostra circolazione sta per incepparsi; il 100 è importante perché indica che l’acqua va in ebollizione (e sparisce), e così via. Quando percentualizziamo, il 51 per cento è importante perché – nell’ambito di un principio maggioritario – può spartire tra chi prende tutto e chi perde tutto.”[3]
Qual è la differenza tra il primo e il secondo esempio?
Questa è una bella questione.
La differenza tra il primo e il secondo esempio è il “punto di sella”.
Nel primo esempio non c’è.
Nel secondo si.
Derivato direttamente dal noto teorema delle condizioni di Karush-Kuhn- Tucker sulla soluzione di problemi di programmazione non lineare[4], il “punto di sella” è stato correttamente utilizzato da Thom nella celeberrima “teoria delle catastrofi”; perché, definiti alcuni vincoli fondamentali, permette di determinare il valore massimo e il valore minimo di un trend fenomenologico (funzione).
Sostanzialmente, la doppia diseguaglianza L(x,y0)≤L(x0,y0)≤L(x0,y) definisce, rispetto ad un determinato punto [L(x0,y0)], un intervallo preciso con un minimo [L(x0,y)] e un massimo [L(x,y0)]. Oltre quel minimo e quel massimo, la curva, disegnata dalla funzione lagrangiana L, si interrompe e potrebbe determinarsi un cambiamento di stato.
Nel primo esempio, infatti, l’acqua, o nella tazzina o nell’Oceano Pacifico, è sempre acqua. Nel secondo esempio, come dice Sartori, essere o vivo o morto è una bella differenza. Anzi, la condizione di vivo o morto fa tutta la differenza. C’è un cambiamento di stato.
Ho denominato questo intervallo, definito dal valore minimo e il valore massimo (cioè dai punti in cui la curva disegnata dalla funzione si interrompe al minimo e/o al massimo) del “punto di sella”, “intervallo di sostenibilità”, intendendo con questa denominazione l’intervallo in cui un determinato fenomeno è ancora tollerato, cioè un intervallo in cui un determinato evento o un determinato fenomeno, pur subendo possibili mutamenti, non subisce tuttavia mutazioni del suo stato iniziale.
Personalmente distinguo tra mutamento e mutazione.
Per mutamento si intende un cambiamento del fenotipo sociale. Come e più dei singoli organismi le società hanno una serie di caratteri e di caratteristiche, come ad esempio l’aggregazione familiare, gli usi, i costumi e, in generale, i comportamenti sociali, che sono percepibili e osservabili. La sociobiologia contemporanea distingue questi caratteri in fenotipi negativi, quelli che cadono in desuetudine e tendono a scomparire nel corso degli anni, e i fenotipi adattativi, quelli che si riscontrano nell’habitat, si propagano rapidamente come moda, restano come background culturale e si solidificano in tradizioni[5]. In ogni caso, il mutamento di una qualsiasi organizzazione è sempre un cambiamento fenotipico.
Per mutazione, invece, si intende un cambiamento del genotipo sociale. Infatti il cambiamento del genotipo non modifica i caratteri di una determinata organizzazione, ma la sua connotazione. Si tratta di un cambiamento dei geni sociali, di una trasformazione strutturale del DNA di una determinata società. Ad esempio, il modello di vita degli umani passa da migrante a sedentario, da agricolo a industriale, da fisico a bionico. Una mutazione cambia dunque definitivamente il corredo genetico di un contesto politico o di una determinata società.
L’intervallo di sostenibilità compreso tra il valore massimo e minimo del “punto di sella” ci permette di individuare i mutamenti e le possibili mutazioni. Il mutamento avviene quando l’acqua della tazzina viene versata nell’Oceano Pacifico. La mutazione avviene quando passo dalla vita alla morte. L’ho chiamato “intervallo si sostenibilità” perché, finché ci sono mutamenti, un fenomeno o un evento (comunque una funzione) è sostenibile a se stesso. Quando invece si supera il valore minimo e/o il valore massimo del "punto di sella" si determinano mutazioni e semplicemente quell’evento o quel fenomeno (comunque quella funzione) non è più se stesso, cambia di stato.
Si converrà che, in ottica di scienze sociali (e in particolare d’intelligence) sapere quando un cambiamento è un mutamento o una mutazione è notevolmente utile.
Per dirla in termini miei, che forse sono più esplicativi, si tratta di sapere se l’incremento o il decremento di entropia in un intervallo di sostenibilità conduce quel determinato fenomeno sociale verso una crisi implosiva o esplosiva. Vediamolo in termini di programmazione urbanistica: si tratta di sapere, analizzando l’andamento della curva (tensione) che definisce un problema, se una costante decremento di entropia conduce a una implosione, come accade in molti piccoli comuni in cui i giovani emigrano e che depauperano e muoiono, o se una eccessivo incremento di entropia conduce ad una esplosione delle relazioni sociali, come quando per un nonnulla la gente si accapiglia nelle invivibili megalopoli metropolitane.
Ho utilizzato una concezione di politica urbanistica, ma vale per ogni cosa, naturalmente.
Noi sappiamo come valutare il trend di un determinato fenomeno e la variazione della sua entropia (cioè gli effetti sull’habitat dell’andamento della curva/funzione e del suo intervallo di sostenibilità) con uno strumento che ho denominato “gradiente di sostenibilità”.
Tramite il “gradiente di sostenibilità”, che tuttavia presenterò prossimamente, possiamo sapere PRIMA se la febbre di Sartori porta quel paziente alla morte o se generosamente lo lascia in vita. È un termometro dell’intervallo di sostenibilità dei fenomeni sociali.
C’è tuttavia un’altra informazione che la definizione del "punto di sella", del suo valore minimo e del suo valore massimo, ci trasferiscono, molto importante per le scienze sociali.
Ci dice quale e quanto è la curvatura dello spazio.
Naturalmente noi vediamo empiricamente la curvatura della linea disegnata su uno spazio bidimensionale, cioè su un sistema di assi cartesiani. Ma quella curvatura è una illusione. Se avessimo una rappresentazione su uno spazio tri o quadridimensionale vedremmo la intera modulazione dello spazio a cui la linea o traiettoria si adatta.
Se la funzione lagrangiana L, tale che L (x,y)=f(x)−∑yigi(x) con la sommatoria è estesa a considerare tutti i vincoli gi, può definire le connessioni che la funzione/evento determina (impatto), allora si può individuare la curvatura dello spazio di riferimento.
Si tratta soltanto di trovare un criterio di qualificazione dei vincoli delle connessioni.
Facciamo un esempio pratico.
Se in epoca di pandemia, l’assenza di mascherine alza l’entropia dell’intervallo di sostenibilità negli ospedali perché i medici si ammalano e i pazienti non li cura più nessuno, l’acquisto di un miliardo di mascherine da mandare ai medici e agli infermieri mostra che lo spazio è curvato perché il problema della cura dei malati, ovviamente, ha un peso maggiore. Se viceversa il leader di un paese afferma pubblicamente che dobbiamo pazientare e aspettare serenamente la morte dei nostri anziani e cari, significa che il suo spazio è curvato dal peso del criterio economico determinato da un valore meramente contabile. Tutto questo mi dice che, probabilmente, la Brexit sta costando troppo e i leader inglesi sono ossessionati dalle preoccupazioni economiche indotte fideisticamente da decisioni ideologiche. Questa informazione, decodificata o addirittura anticipata può indurre i mercati a ridurre gli investimenti in Inghilterra.
Il contrario è ciò che interessa più l’intelligence.
Sappiamo che il teorema dello spazio concavo può essere invertito in ipotesi di convessità. Se conosco la situazione economica inglese e la interpreto rispetto al problema del COVID 19, so anche che la soluzione di quella pandemia è l’isolamento fisico, cognitivo ed economico (insieme convesso). È presumibile che il leader inglese dovrà cambiare la sua dichiarazione e trovare una diversa soluzione alla sua economia, senza più nemmeno l’ausilio dell’Unione Europea (funzione obiettivo). Se analizzando le connessioni e le funzioni di vincolo convesse, possiamo soddisfare una condizione di qualificazione dei vincoli (cioè che la paura e la morte dei cittadini inglesi ha un valore che pesa in modo esorbitante sullo spazio relazionale e comunicativo), allora esiste un moltiplicatore y0 a componenti non negative (ad esempio la malattia del leader sprovveduto) tale che riequilibri il nostro fenomeno verso il punto di sella (x0,y0) (ad esempio l’Inghilterra partecipa alla lotta planetaria contro la pandemia senza dissociarsi in autarchia, se ne assume i rischi e il sostegno internazionale).
Con un modello funzionante tutto questo avremmo potuto prevederlo.
Ora, e concludo la già troppo lunga e forse noiosa trattazione, se lo spazio è curvato dal peso di una determinata informazione-valore[6], allora deve esistere un moltiplicatore comunicativo (critico) che induce il decorso della funzione-evento verso il suo esito più probabile (ad esempio, lo shock di morti inglesi induce il decisore ad invertire la sua strategia).
L’intelligence all’altezza dei tempi, monitorando e qualificando i vincoli con mappe connettografiche[7], può prevedere questo sviluppo e predisporre le strutture dello Stato al fine di prevenire un eventuale esito catastrofico.
(…continua)
ooo/ooo
[1] SARTORI Giovanni, La Politica, logica e metodo in scienze Sociali, Sugar, Milano 1980
[2] SARTORI G., cit.1980, p. 135
[3] SARTORI G. cit. 1980, p. 135
[4] Si tratta di una generalizzazione del metodo dei moltiplicatori di Lagrange, applicato a problemi in cui siano presenti anche vincoli di disuguaglianza in cui i vincoli soddisfino una delle condizioni di regolarità dette condizioni di qualificazione dei vincoli
[5] Liliana Montereale ha individuato perfettamente come i fenotipi (che possono anche essere considerati funzioni sistemiche) trasportano energia in forma di informazioni (teoria cibernetica) ai genotipi (che possono anche essere considerati strutture). E lo fanno con i Conemi che sono …. Comunque vogliamo denominarli, resta il fatto che alcune funzioni depositano energia-informazione dentro alcune strutture, processo decisivo e centrale per l’intera epigenetica.
[6] Ricordare la precedente distinzione tra dati e valori
[7] KHANNA Parag, Connectography, Fasi Editore, Roma 2016







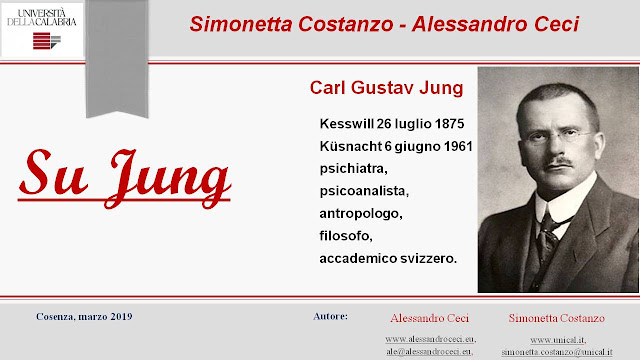
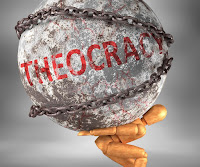

Commenti
Posta un commento