INTELLIGENCE: IL PARADOSSO DI KEYNES
John Maynard Keynes non fu soltanto “un economista geniale – fra i massimi di ogni tempo – la cui opera ha rinnovato dalle basi la scienza economica”[1], come ha scritto Alberto Campolongo, a Milano, il 30 dicembre del 1977 nella introduzione alla sua opera più importante.
Egli fu principalmente “un grande teorico, il quale ha elaborato le sue idee in vista della loro applicazione alla realtà economica”[2], come ha scritto Alberto Campolongo, a Milano, il 30 dicembre del 1977 nella introduzione alla sua opera più importante.
In altri termini, dobbiamo più a John Maynard Keynes per il suo contributo alla epistemologia delle scienze sociali (proprio nella versione della lebenswelt) che per il suo contributo alla economia e al problema della occupazione.
Un contributo che consiste essenzialmente in un paradosso.
John Maynard Keynes, nel cercare di ripristinare un equilibrio, lo ha definitivamente annullato.
Il paradosso è questo.
Si tratta di un paradosso che interessa meno i modelli economici o econometrici.
Interessa molto di più la epistemologia delle scienze sociale e l’intelligence. E questo, se volete, è un paradosso dentro il paradosso.
Leggiamolo direttamente dalle sue parole “Dimostrerò che i postulati della teoria classica si possono applicare soltanto ad un caso particolare e non in senso generale, poiché la situazione che essa presuppone è un caso limite delle posizioni di equilibrio possibili”[3]. E, per quella che Edmund Husserl ha chiamato lebenswelt[4] (cioè la scienza della vita), Keynes specifica:”Avviene inoltre che le caratteristiche del caso particolare presupposto dalla teoria classica non sono quelle della società economica nella quale realmente viviamo; cosicché i suoi insegnamenti sono ingannevoli e disastrosi se si cerca di applicarli ai fatti dell’esperienza”[5].
Che cosa era accaduto?
Keynes proveniva dall’esperienza traumatica della crisi del 1929, quando – come aveva perfettamente previsto Karl Marx – i capitalisti falliti si buttavano dai loro stessi grattaceli. Le industrie non vendevano più per assenza di liquidità e quindi di consumo. Il mercato interno, che ancora dominava su quello internazionale, piuttosto che un automatismo di riallineamento della curva della domanda e dell’offerta – come prevedevano gli economisti classici sulla base di un paradigma interpretativo di ordine matematico -, si erano definitivamente sganciate e il mondo era stato travolta dalla inattesa crisi di a-simmetria.
Altro che equilibrio automatico.
Disequilibrio totale e assassino.
Da questa situazione non si riusciva a venir fuori, essendo gli scienziati sociali nel loop dei loro calcoli inutilmente ripetuti.
Keynes capisce che c’era bisogno di un salto epistemologico. Bisognava interpretare gli eventi sulla base della “eloquenza dei fatti”, come diceva Cicerone; a quei fatti adattare, o da quei fatti derivare, la teoria, non il contrario. Un salto epistemologico.
Così fa. Inverte l’ordine logico e, nel cercare un nuovo stato di equilibrio minimo, attiva un processo controllato dentro infiniti equilibri di sostenibilità economica. Crea liquidità per sostenere i consumi e far riprendere la produzione. Costruisce una barriera di sussidi e distribuzione di fondi su cui far rimbalzare la curva dell’offerta e spingerla ad incontrarsi con la curva della domanda. Per sostenere le spese, lo Stato è costretto a una nuova fiscalità, cioè ad una barriera opposta, necessaria per far rimbalzare anche la curva della domanda e connetterla con la curva dell’offerta. Dunque, in questo modo, la curva dell’offerta non esce mai dall’intervallo per la funzione di sostegno della liquidità e la curva della domanda non esce mai dall’intervallo grazie alla funzione di investimento della fiscalità.
Keynes sostituisce il concetto di equilibrio, con il concetto di intervallo.
Questo è il salto epistemologico.
Il paradosso consiste nel fatto che lui cercava uno stato di equilibrio possibile e ha realizzato un intervallo in cui ogni stato è un equilibrio possibile.
La seconda innovazione epistemologica di Keynes la lasciamo dichiarare da lui stesso: “Così il comportamento di ciascuna impresa singola nel decidere la propria produzione giornaliera sarà determinato dalle sue aspettative a breve termine, aspettative riguardo al costo di produzione nelle diverse dimensioni possibili ed aspettative riguardo al ricavo dalla vendita di tale produzione; mentre, nel caso di ampliamento degli impianti ed anche nel caso di vendite a distributori, queste aspettative di breve termine dipenderanno largamente da aspettative a lungo termine (o a medio termine) da parte di terzi.”[6]
Il passaggio dalla razionalità alle aspettative è la seconda grande innovazione epistemologica di Keynes. Si potrebbe dire meglio, alla Sartori[7], distinguendo la razionalità delle scienze esatte dalla ragionevolezza delle scienze sociali.
Ora senza eccedere troppo, a cosa servono queste due fondamentali innovazioni di Keynes alla scienze sociali e specificamente all’intelligence?
La seconda innovazione keynesiana, cioè la scelta di considerare le aspettative piuttosto che la razionalità degli attori, inverte notevolmente l’impostazione rispetto alle utilizzazione della Teoria dei Giochi in Intelligence. Sapere che i decisori scelgono, non in funzione della razionalità, ma in funzione delle proprie aspettative cambia decisamente la prospettiva. Quali sono state le aspettative dei terroristi rispetto alla decisione di abbattere con aerei di linea le Twin Towers? Certamente fare emergere Al Qaeda come soggetto politico globale, mostrare la vulnerabilità del suolo americano, legittimare la propria rete in tutto il mondo arabo. Rispetto a queste 3 aspettative, ad esempio, la reazione dell’Occidente che ha messo sotto pressione gli Stati Canaglia, ha favorito la crescita della immateriale rete del terrore. Molti militanti di organizzazioni militari sconfitte sono entrati in clandestinità e si sono associati a Bin Laden. Viceversa, la decisione di Bin Laden di passare, come tutti i gruppi arabi, da organizzazione del terrore a movimento politico continentale, in grado di tenere uniti tutti gli Stati islamici, la sua aspettative cioè di leadership istituzionale legittimata, era forse razionale, ma ha tradito le aspettative che alcune nazioni islamiche, come il Pakistan, avevano rispetto al movimento di Al Qaeda e ha favorito la sua cattura. Tutte le decisioni dei protagonisti (giocatori) sono state prese secondo le aspettative di ciascuno. Nessuna su un calcolo puramente razionale. Lo schema costi/benefici, nelle scienze sociali, conta relativamente. L’intelligence non può non tenerne conto. La sua valutazione, rispetto alla “eloquenza dei fatti” non deve essere presa sulla base di ciò che è razionale, ma sulla base delle aspettative dei protagonisti. È stato uno dei clamorosi errori della Teoria dei giochi aver creduto e presupposto che i giocatori giocassero in condizione di piena informazione e con azioni razionali. I giocatori decidono le loro azioni in carenza di informazioni e sulla base delle proprie aspettative.
La prima innovazione keynesiana invece, cioè la scoperta dell'intervallo di sostenibilità, ci dice che gli eventi non si stabilizzano mai, sono sempre dinamici, non verso un solo punto di equilibrio ma all’interno di un intervallo in cui infiniti punti di equilibrio diversi sono in condizione di sostenere una qualsiasi organizzazione sociale. Infatti, ciò che rende sostenibili un sistema o network a se stesso è un intervallo, non un punto (o stato) di equilibrio. Definire un intervallo di sostenibilità di una organizzazione significa stabilire i suoi margini di libertà e le sue possibili evoluzioni.
In ogni caso, pensare ad un intervallo piuttosto che a un punto di equilibrio ci fa considerare le cose non dal punto di vista del modello, ma dal punto di vista del processo.
Il modello è uno schema di riproduzione, talvolta in scala ridotta, delle politiche finalizzate al raggiungimento di un determinato obiettivo. Si tratta di individuare e definire i punti di riferimento da riprodurre, da incentivare, da sostenere, talvolta da emulare.
Un processo invece riguarda il sistema di metabolizzazione di input ed output, in un network territoriale definito, in cui è indispensabile trovare la energia e la materia, per reggere le politiche di sviluppo, consolidando le strutture conservative o provvedendo alle opportune trasformazioni. Un processo assorbe ed elabora informazioni, le seleziona con una metodologia di comunicazione e verifica che coinvolge principalmente le reali esigenze dell’elemento umano. I processi devono essenzialmente controllare gli impatti che decisioni di micro e/o di major event determinano.
Ad esempio, i modelli di sviluppo locali sono sempre stati interpretati come se il territorio fosse destinatario passivo di risorse e d’interventi decisi in relazione alle competenze gerarchiche tra diversi processi decisionali. Negli ultimi anni, con l’incremento di politiche di governance, il livello locale viene interamente riconsiderato. Non è possibile, infatti, comprendere i nuovi processi di economia di sviluppo locale senza comprendere le differenze e gli equilibri tra funzioni e prestazioni necessarie per il governo del territorio (qualunque sia la sua dimensione) e per la sua governance.
L’ipotesi simbiotica ci fa uscire definitivamente dal concetto di modello e ci entrare nel concetto di processo. Lo sviluppo simbiotico degli elementi, di qualsiasi elemento (agricolo, industriale, sociale, culturale), determinano necessariamente la sostituzione del concetto di modello con il concetto di processo. La differenza, apparentemente accademica, in realtà fa tutta la differenza tra diverse politiche e dinamiche di sviluppo. In un processo di sviluppo, le caratteristiche fondamentali sono le funzioni e le prestazioni, piuttosto che le strutture e le infrastrutture che riguardano il modello. È necessario concentrarsi sul processo e quindi sulle politiche di governance che indirizzano i flussi e cicli di qualificazione del territorio. Nella logica del processo di sviluppo simbiotico pertanto l’intelligence è indotto a seguire l’azione piuttosto che l’organizzazione: perché, come si dice, i fatti parlo inequivocabilmente.
Forse la ipotesi di Keynes è stata paradossale, perché cercava un nuovo equilibrio e ha trovato un intervallo, ma questo paradosso ci è stato molto utile.
E ci è utile ancora.
prossimo testo: “Il Premio di Hannah Arendt”
ooo/ooo
[2] CAMPOLONGO Alberto, cit. 1978, p.9
[3] KEYNES John Maynard, Teoria Generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, Utet, Torino 1978, p.161
[4] In HUSSERL Edmund, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Il Saggiatore, Milano 1965
[5] KEYNES J.M. cit. 1978, p.161
[6] KEYNES J. M., cit. 1968, pag. 205
[7] SARTORI Giovanni, Politica – logica e metodeo delle scienze sociali, Sugar, Milano 1979





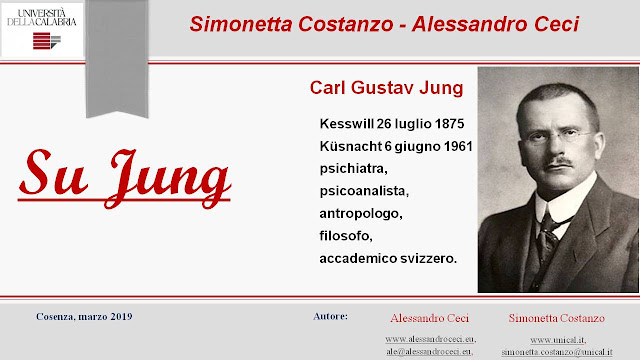
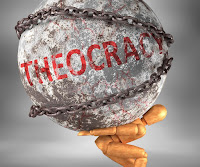

Commenti
Posta un commento