TURISMO: SAGGIO DI POLITICA LOCALE - 2.e)
Turismo
Una esperienza mediterranea
anno 1998
anno 1998

2 - …il paradigma di riferimento
(ovvero: la connotazione situazionale)
2.e) il ciclo di vita
Com’è stato possibile?
Quando è accaduto tutto questo?
Esiste, nella programmazione turistica delle località il ciclo di vita delle destinazioni in base al quale, “se nella fase iniziale della valorizzazione di un’area, il potenziamento delle risorse ambientali (in senso lato) può innescare un processo positivo, ad un certo stadio del suo sviluppo si può avere una rottura dell’equilibrio tra la potenzialità del contesto ricettivo e il livello delle prestazioni richieste, con una caduta della redditività”[1].
Come tutti i prodotti, anche le destinazioni hanno un loro ciclo di vita: un momento in cui possono nascere, un altro in cui o crescono o si sviluppano ed un terzo momento in cui o periscono o si rinnovano.
Abbiamo suddiviso gli anni di economia turistica della nostra città in queste cinque fasi.
1. PRIMA FASE
Dal 1950 al 1975, Terracina si è imposta sul mercato nazionale ed internazionale come località turistica.
Non interessa ora stabilire i connotati della immagine cittadina. Interessa cogliere il processo.
Interessa stabilire soltanto ciò che è avvenuto, quando è avvenuto, non ancora come sia avvenuto.
Resta il fatto che in questa prima fase la nostra città è nata come città turistica, un po’ perché effettivamente la sua collocazione geografica indicava una irreversibile vocazione, un po’ per la meno nobile giustificazione di espropriazione delle terre ai contadini a favore della urbanizzazione irregolare ed anzi sregolata in epoca di ricostruzione postbellica.
Voluta o dovuta, come si dice, per amore o per calcolo, questa prima fase è stata caratterizzata da una attività di programmazione dell’accoglienza e di promozione dell’immagine.
La battaglia stessa per la collocazione nella nostra città della sede dell’Azienda Autonoma di Soggiorno Turismo e Cura è indicativa del fatto che questa natura turistica, oggi così inscindibile, non era allora così riconosciuta, nonostante che i romani avessero già molti secoli prima istituito qui una sede delle loro Terme Marine.
Non bisogna dimenticare che allora vigeva il teorema della disgraziata industrializzazione nazionale, che ha creato, al fianco di una delle città più belle e turisticamente rilevanti del mondo (Venezia), piuttosto che un adeguato indotto di accoglienza, uno dei più significativi siti industriali europei (Mestre). Soltanto nel 1983, la Legge Quadro sul Turismo (L. 17 maggio 1983, n.217) riconoscerà la funzione economica di questo comparto; limitata però a dimensione secondaria, successiva alla prevalente funzione sociale[2]. Ancora oggi, a ben 14 anni di distanza, la delega del turismo, in sede di distribuzione dei settori di competenza in seno ad una qualsiasi Giunta di Governo, viene affiancata dalle deleghe relative allo Sport ed alla Cultura[3]. Sono rari i casi in cui il comparto turistico viene collocato all’interno del dipartimento degli Affari Economici[4]. Non bisogna dimenticare che, secondo il paradigma economico dominante, il terziario – ed in particolar modo il turismo – non era da considerare fonte strutturale di reddito e di occupazione. Era settore economico leggero, attività sovrastrutturale, riservata alla organizzazione dello svago e quindi tutto sommato poco rilevante, per non dire poco seria. La crescita economica italiana poteva, a modello delle grandi democrazie occidentali, essere garantita esclusivamente dalla industrializzazione. Con l’evidente risultato che le maggiori bellezze storiche del mondo sono state violentate dai silos e dagli stabilimenti (Genova); e che sul golfo della più bella città europea del settecento (Napoli), abbiamo costruito un insediamento industriale (Bagnoli). E non è nemmeno necessario andare troppo lontano. Basta visitare Tivoli e la sua “Villa Adriana”; uno dei monumenti italiani maggiormente frequentati, che accoglie costantemente tour di svariate tipologie di turisti, che attrae target differenziati dagli studenti agli anziani, italiani o stranieri. Quella villa bellissima ed evocativa confina con lo stabilimento industriale della Pirelli, piuttosto che con una apposita area di accoglienza e di ristoro. Di esempi simili potremmo riempire intere biblioteche, e molti ve ne sono anche nella nostra città. Il turismo proclamato in ogni occasione, non è presente nel momento di ogni decisione.
Ciò nonostante la sua forza è comunque travolgente.
Oggi il terziario, ed in modo specifico il turismo, è diventato il settore trainante delle moderne economie sviluppate, e i danni prodotti dalla industrializzazione e dalla urbanizzazione spontanea sono ormai irreversibili. La vendetta è stata consumata: dal 2000 il turismo ha prodotto, secondo le Nazioni Unite, nel mondo un reddito maggiore dell’industria siderurgica ed automobilistica.
In ogni caso allora era così.
Il territorio nazionale non aveva una intera valenza turistica[5]. Il Ministero aveva il compito di individuare le aree in cui fosse evidentemente riscontrabile una vocazione turistica ed in queste aree, volendo, poteva istituire la sede di una Azienda che, con criteri privatistici di gestione, potesse provvedere all’assistenza ed alla cura degli ospiti, sostenendosi con la riscossione autonoma di una apposita tassa.
Inizialmente, nella provincia di Latina, Terracina non era considerata tra queste aree. La volontà e, per certi versi, l’esigenza dei gruppi dirigenti cittadini di quell’epoca di spingere sul terreno della valorizzazione turistica, quasi costrinse il Ministero, sottoposto ad una vera pressione politica, a qualificare appunto come “turisticamente rilevante” il nostro perimetro urbano e quindi a istituirne la sede di un apposito Ente.
Come la storia successiva della città ha abbondantemente dimostrato, non fu una proposta, frutto di una reale valutazione collettiva e di coerenti politiche di sviluppo.
Fu una pretesa delle élite dominanti per assicurarsi una facile crescita e la giustificazione per la trasformazione urbanistica del territorio. Basti pensare che ancora per molti anni dopo, contemporaneamente alla pretesa turistica, i nostri decisori si sono impegnati nella definizione della Piana Industriale di Mazzocchio, a ridosso della città, tentando di replicare, sebbene in miniatura, l’obbrobrio di Mestre. Molti degli interlocutori pubblici, singoli politici, individui singolari, sindacati e partiti, vedevano in questa piana l’unica prospettiva di modernizzazione della pianura pontina; e il nostro porto doveva essere asservito alle generali esigenze industriali.
Tutto questo è abbondantemente riportato nelle cronache d’epoca. Fortunatamente però ciò che ha rilevanza nella cronaca non sempre ha valore nella storia e i protagonisti di una stagione, quando non siano portatori di progetti di sviluppo, non lasciano il segno della loro presenza.
Così la città è stata spontaneamente ricondotta alla sua valenza. Terracina era un luogo, con una sua identità, con una caratteristica e caratterizzante “dimensione simbolica nella vita urbana”. Infatti “la natura di molti luoghi della società contemporanea è sempre più data dalla loro capacità di ospitare entro un certo preciso quadro di vincoli materiali e geografici una moltitudine di significati e proiezioni.”
Nel bene o nel male, condivisibili o meno, nel periodo che va dal 1950 al 1975, la nostra città ha diffuso questi significati e queste proiezioni. Il nostro stesso nome era diventato un codice di riconoscimento per i gruppi di pari che si trasmettevano immagini e s’incontravano nelle località turistiche prestabilite, come fossero veri e propri santuari del loro pellegrinaggio. La città era relativamente invasa. Più che altro era vissuta. Il Capitale Naturale Critico era ad un livello di minimo sfruttamento; in grado di garantire, per le generazioni successive, la riproducibilità biologica del sistema.
2. SECONDA FASE
Gli anni che vanno dal 1965 al 1990 sono la seconda fase. Naturalmente non è possibile demarcare un confine. Non c’è mai nella storia una traccia prima della quale ed oltre la quale tutto cambia. Specie nella storia di una località minore tutto si trasforma in un processo talvolta impercettibile, talvolta rapido, talvolta incomprensibile. Quando ce ne rendiamo conto, quando riusciamo a decodificarne i simboli, questo processo spesso si è conclamato e mostra semplicemente i suoi irreversibili effetti. Tuttavia, in modo convenzionale, nell’intervallo compreso tra il 1965 e il 1990 avremmo dovuto scegliere lo sviluppo. In quel periodo di forte dinamismo attivo avremmo dovuto programmare l’evoluzione della città con il criterio della sostenibilità, per regolare l’entropia del sistema urbano.
Invece non abbiamo gestito: abbiamo assistito.
Abbiamo visto venire turisti a frotte e li abbiamo rincorsi, dimentichi di una città che necessitava servizi. Piuttosto che impegnarci nel progettare lo sviluppo, abbiamo preferito subire la crescita. E Terracina si è rapidamente trasformata nella dependance al mare di due aree metropolitane (Roma e Napoli). La città, sottoposta al fenomeno del pieno e ipnotizzata da un miraggio economico, ha semplicemente assorbito la indistinta moltitudine di consumatori del mare e dello svago.
Noi abbiamo vissuto la massificazione del terziario, prima ancora di vivere il terziario.
I nostri luoghi, con la loro identità storicamente radicata, sono stati trasformati in spazi organizzati di accoglienza, uno standard generico che ha cancellato tutti i codici di significazione della città. La nostra spiaggia diventava una qualsiasi spiaggia affollata – e con meno servizi -; le nostre case erano uguali a tante altre case; strade e piazze simili a tutte le strade e a tutte le piazze. Il target di turista medio, non riconoscendo alcun codice di significazione cittadino, sceglieva, al posto della qualità, la comodità; al posto della fruizione, il consumo. In pochi abitavano il Centro Storico. I molti occupavano il litorale. La gran massa dei turisti prenotava gli spazi immediatamente vicini al bene prevalente di consumo, indifferenti al resto.
E noi abbiamo subito: anzi, noi abbiamo assorbito.
Non avendo scelto lo sviluppo, ci è toccata la crescita. Nessuno, troppo concentrato sul suo guadagno quotidiano, si è preoccupato delle generazioni future, di garantire cioè la possibilità di sfruttamento delle risorse alle generazioni future. Nessuno si è preoccupato della sostenibilità del sistema. Una questione che, viceversa, doveva pregiudizialmente essere posta per una politica turistica rispettosa della propria località e dei flussi di accoglienza. Laddove ciò non avvenga, dove ciò non è avvenuto, quando non si pre definisca il tasso accettabile di pressione turistica, i danni del sovraffollamento diventano altissimi. Tra questi danni va, in primo luogo, annoverata la diminuzione della redditività degli investimenti e delle prestazioni turistiche.
Certo, in un primo momento, siamo stati vittime di una illusione collettiva. Il facile guadagno ha indotto al facile guadagno in periodi di lavoro sempre più ristretti. La riduzione della diuturna fatica del lavoro è un’ambizione permanente dell’umanità. La quantità è facile e comoda. La tenace e impegnativa azione di qualificazione ne viene spesso sopraffatta. La massificazione turistica della città, in uno sfrenato processo di crescita, ha seriamente minacciato il sistema di tenuta urbano ed urbanistico, esorbitando notevolmente la Capacità di Carico del nostro habitat.
Per un po’ abbiamo retto, ma non per molto. La rana non diventa bue impunemente. A forza di gonfiarsi alla fine scoppia. Una città non può essere rana per tutto l’anno (circa 30 mila abitanti) e bue nei due mesi estivi (300 mila presenze all’incirca), impunemente.
Il sistema oltrepassa la capacità di carico e scende oltre il limite del proprio Capitale Naturale Critico. In generale, scendere al di sotto di quel limite significa abbassare il livello di entropia del sistema stesso e la città, preda di frotte di “domenicali scalzi”, implode.
3. QUARTA FASECerto, in un primo momento, siamo stati vittime di una illusione collettiva. Il facile guadagno ha indotto al facile guadagno in periodi di lavoro sempre più ristretti. La riduzione della diuturna fatica del lavoro è un’ambizione permanente dell’umanità. La quantità è facile e comoda. La tenace e impegnativa azione di qualificazione ne viene spesso sopraffatta. La massificazione turistica della città, in uno sfrenato processo di crescita, ha seriamente minacciato il sistema di tenuta urbano ed urbanistico, esorbitando notevolmente la Capacità di Carico del nostro habitat.
Per un po’ abbiamo retto, ma non per molto. La rana non diventa bue impunemente. A forza di gonfiarsi alla fine scoppia. Una città non può essere rana per tutto l’anno (circa 30 mila abitanti) e bue nei due mesi estivi (300 mila presenze all’incirca), impunemente.
Il sistema oltrepassa la capacità di carico e scende oltre il limite del proprio Capitale Naturale Critico. In generale, scendere al di sotto di quel limite significa abbassare il livello di entropia del sistema stesso e la città, preda di frotte di “domenicali scalzi”, implode.
È quanto accaduto nella quarta fase convenzionale, dal 2001 al 2020: assenza di una politica di sviluppo, stasi, blocco del criterio di sostenibilità, superamento della Capacità di Carico delle strutture e dei servizi, disequilibrio organico, caduta dell’entropia per discesa oltre il limite del Capitale Naturale Critico, implosione del sistema.
È la quarta fase del ciclo di vita delle destinazioni, quella della vecchiaia, in cui tutto si decompone costantemente. Ma non per sempre. A un certo punto o si rinasce o si muore. E si può rinascere in due modi: o con una standardizzazione, cioè stratificando i processi attivi nel sistema urbano qualora questi processi fossero giudicati opportuni, utili e necessari, generalmente positivi; o con una innovazione, cioè cambiando la natura dei processi attivi nel sistema urbano quando questi processi venissero giudicati inopportuni, inutili e dannosi, generalmente negativi. Altrimenti si muore, semplicemente il sistema continua ad implodere e quindi a degenerare. I luoghi, già trasformati in spazi organizzati, si trasformano in aree di parcheggio non servite, ed ognuno occupa ogni posto senza rispetto. Tra l’altro, in una situazione di questo genere è difficile trovare pochi imprenditori coraggiosi che si assumano il rischio di un investimento cieco. La città, violata e violentata in ogni suo spazio, si trasforma in una grande area di deposito estivo, diffonde sfiducia e disaffezione. L’inerzia, causa ed effetto della bassa o bassissima entropia, la generale inerzia, la nostra acerrima nemica, fa dei suoi cittadini uomini di azioni perdute.
Così è diventata Terracina nel 2020.
I parchi pubblici trasformati in aree di ristorazione e di bivacco, durante il giorno, e affollati dormitori di notte. I Campers continuano a sostare ovunque. La città è di nuovo considerata un’area intera a loro disposizione, nessuno avendo mai provveduto alla individuazione di spazi appositamente attrezzati. Non ci sono più codici di significazione che comunicano l’identità dei luoghi, niente significati percettivi, niente proiezioni esterne, nessuna esperienza simbolica o immateriale che non fosse sempre la solita pretesa senza progetto, rivendicazione senza alcuna concezione.
Mi spiace, ma questo ritroviamo: implosione al limite della degenerazione.
Una situazione che, se continua così, presto sarà di nuovo non più sostenibile.
Bisogna ancora cambiare.
Ma cambiare non è mai facile.
E tanto più è difficile, quanto critico, implosivo o esplosivo, è il sistema.
Paradossalmente, cambiare in una situazione di crisi è molto più difficile che cambiare in una fase di sviluppo. Quando la sostenibilità di un sistema è forte o molto forte, e noi siamo vicini alla soglia di Capacità di Carico, vi è maggiore possibilità di sostituzione dei processi che minacciano l’equilibrio dell’entropia. Al contrario, quando la sostenibilità di un sistema è debole o molto debole, e noi siamo vicini alla soglia limite del Capitale Naturale Critico, il tasso di sostituibilità del pericolo è minore.
Perché?
Perché, lo ripeto, il criterio della sostenibilità è un meccanismo automatico con cui si tiene sotto controllo l’equilibrio dell’entropia. Quando la sostenibilità è forte o addirittura molto forte e, quindi, il meccanismo funziona, una volta giunti alla soglia del sovraccarico, l’entropia o sale o scende; in ogni caso rischia di uscire dalla sua circoscrizione di equilibrio, cioè dall’intervallo entro il quale la pressione entropica è ancora tollerabile. Allora, un meccanismo che funziona entra in funzione: in nome della sostenibilità del sistema, riesce a sostituire ciò che deve sostituire.
Il caso opposto è quello di un debole, o addirittura molto debole, criterio di sostenibilità. È chiaro allora che, una fase di crescita sfrenata minaccia il limite del Capitale Naturale Critico. A quel punto, se il meccanismo non funziona a causa di assenza di sostenibilità, non entra nemmeno in funzione, e quindi la possibilità di sostituire ciò che bisogna sostituire, cioè i processi che minacciano l’equilibrio della entropia, è minima.
E dunque per noi, in condizione di assenza di sostenibilità ed implosione, cambiare è ancora difficile. Adesso però, ad essere sinceri, tutte queste cose, che abbiamo capito con le esperienze politiche e professionali vissute, ora le sapiamo.
Ovviamente mancano le fasi terza e quinta: ciò che abbiamo fatto e ciò che dovremo rifare.
Cosa che discuteremo nel prossimo capitolo.
ooo/ooo
[1] Faggiani Giuliano, cit. (4).
[2] Art.1 della Legge 17 maggio 1983, n.217
[3] Com’è il caso, ad esempio, della Regione Lazio.
[4] Com’è il caso, ad esempio, del Comune di Terracina
[5] e oggi ancora non ce l’ha.

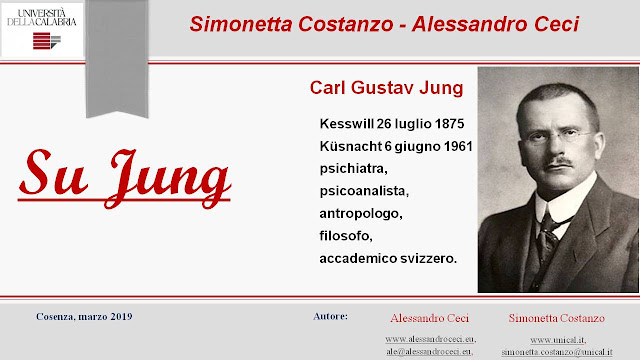
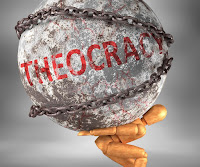

Commenti
Posta un commento