TURISMO: SAGGIO DI POLITICA LOCALE - 2.d)
Turismo
Una esperienza mediterranea
anno 1998
anno 1998
2 - …il paradigma di riferimento
(ovvero: la connotazione situazionale)
2.d) identità e identificazione
Com’è stato possibile?
Come è potuto accadere tutto questo?
Lo potremmo definire il meccanismo ricorsivo di dequalificazione turistica, quando si assiste alla trasformazione dei luoghi in spazi e degli spazi in aree.
Normalmente funziona così: una città turistica è un luogo la cui essenza “sta in un plusvalore che allarga le qualità ricettive di uno spazio altrimenti ordinato“[1].
Ad un certo punto una città turistica, se sottoposta ai ritmi della crescita invece che a quelli dello sviluppo, perde l’attenzione collettiva nella manutenzione della plusvalenza di fruizione del proprio habitat.
In genere ciò accade a coloro che, avendo ricevuto in eredità un patrimonio ambientale e storico-architettonico inestimabile, lo dilapidano nella presunzione che questo patrimonio sia infinito. Sono le città governate dalla rendita di nulla facenti, che fanno dello sperpero il loro sistema di vita. Sono città in cui i cittadini perdono la cultura dei luoghi turistici e finiscono per organizzare gli spazi della vacanza in modo indistinto, anonimo e spesso amorfo; come è accaduto, ad esempio, nella occupazione della nostra spiaggia. In un primo momento intesa come luogo di fruizione ambientale del mare, è presto diventata uno spazio di accoglienza e deposito, in stabilimenti balneari standard, di utenti occasionali. Trasformazione questa simboleggiata dalla eliminazione definitiva dello "Squero" per una anonimo e indefinito stradone che poteva essere realizzato, meglio di così, ovunque. una operazione di riconduzione all'anonimato metropolitano rappresentato da marciapiedi e parcheggi standardizzati, molti anni prima iniziato con il noto "tombinamento" del Canale Pio VI.
Di conseguenza l’intera città passa, specie quando in una fase di crescita ci si concentra su un prodotto esclusivo (il nostro mare), da essere luogo di fruizione turistica all’essere spazio di consumo della vacanza. La città dello spazio perde quel plusvalore che denota invece la identità dei luoghi e che “ci appare radicato nella biografia dei fatti urbani locali, nelle tradizioni che li identificano e distinguono”[2].
Stravolta la propria identità urbana, come accaduto con il parziale rifacimento del Lungomare Circe, “da un dirompente ampliamento delle possibilità prestazionali degli spazi”[3], la città ospita il turista, “nelle sue pause di vita intermittente”[4], in “una vasta gamma di non-luoghi”[5], misurati in termini di distanze geografiche e temporali, per favorire il consumo della ricreazione.
Priva e privata della identità dei suoi luoghi, la città non ha più “terminali verso l’esterno”[6] che riescano a connotarla, a caratterizzarla. “In nome del tracotante imperio degli open space”[7], che induce il consumo di una ricreazione indifferenziata e standardizzata, la città è costretta a fare del clima la sua unica ed univoca forza attrattiva e quindi a circoscrivere le sue fonti di reddito entro una sempre più ristretta stagionalità.
L’effetto immediato è che, per le buone ragioni del reddito, in periodi circoscritti, negli spazi disponibili bisogna portare più gente possibile. Bisogna semplicemente invadere, come nella emblematica situazione delle case tenute sfitte per l’intero anno in attesa degli inquilini estivi. Una città che subisce una invasione in tutti i suoi spazi soltanto per pochi mesi l’anno è una città provvisoria, che vive su una economia provvisoria e che non reclama troppo per la qualità dei servizi, poiché bastano quelli provvisori che già ci sono.
Fare di più non vale troppo la pena.
Se si può, va anche bene.
Se non si può, si sopravvive comunque.
E ci si dimentica che una riduzione nella qualità dei servizi, a causa della loro provvisoria natura, riduce la economicità del settore turistico.
Ad ogni fine stagione, a conti fatti, i conti non tornano.
Se la complessiva economicità turistica è bassa gli imprenditori non hanno interesse ad investire. Si genera una stasi diffusa. L’entropia dell'habitat turistico locale continua a scendere. Il tempo corrode le cose e la vita. Senza investimenti non si modernizzano nemmeno i servizi che servono ad organizzare gli spazi. La città semplicemente depaupera, si dequalifica nelle sue strutture portanti e nel suo contesto relazionale. Gli spazi della vacanza, non più adeguatamente serviti, si trasformano in aree utili per occasionali scampagnate: tende nei parchi pubblici e camper sui marciapiedi.
E’ quello che abbiamo vissuto; una città che ammassa passanti e scaccia i turisti. Così, mano a mano, nella indifferenza, in una presunta impotenza, quasi senza accorgersene, stagione dopo stagione, si disarticola l’habitat urbano, si incrementa solo l’entropia, si produce un disequilibrio ambientale, la città implode.
Succede sempre così quando le località turistiche, “dopo alcune fasi di crescita, non sono più in grado di soddisfare le esigenze della domanda e si avviano verso la decadenza”[8].
ooo/ooo
[1] Boeri Stefano, I LUOGHI, in EQUILIBRI – Rivista dello Sviluppo Sostenibile -, Il Mulino, Bologna, n.1/1997.
[2] Boeri S., cit. 21.
[3] Boeri S., cit. 21
[4] Boeri S., cit. 21
[5] Boeri S., cit. 21
[6] Boeri S., cit. 21
[7] Boeri S., cit. 21
[8] Faggiani Giuliano, impatto turistico e ciclo di vita delle attività, in Azienda Turismo, Anno 6, n.1, Gennaio/febbraio 1995


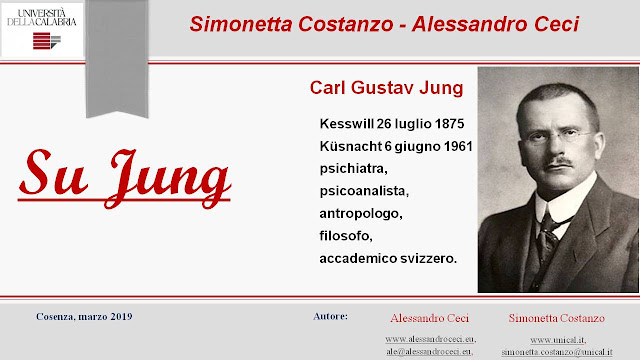
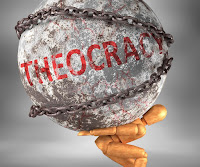

Commenti
Posta un commento