TURISMO: SAGGIO DI POLITICA LOCALE - 2.c)
Turismo
Una esperienza mediterranea
anno 1998
anno 1998
2 - …il paradigma di riferimento
(ovvero: la connotazione situazionale)
2.c) sostenibilità
IL primo problema[1] dello sviluppo turistico di una località (e il primo drammatico problema per la nostra città) è che il turismo costa e non sempre conviene. Questo aspetto dello sviluppo turistico, spesso, viene sottovalutato, se non addirittura dimenticato, nella fase di programmazione e di rendicontazione del fenomeno ciclico, dal punto di vista economico, cioè agli esordi o a conclusione di una stagione estiva, quando si fanno i conti, quando si valutano risultati e prospettive. Ma è un aspetto che un pubblico amministratore non può ignorare, anche se i privati cittadini contabilizzano prevalentemente la quantità (numero di presenze) e la qualità (propensione al consumo) dei flussi turistici.
Pochi si preoccupano dei costi.
Sulla base dei costi sociali, invece, noi abbiamo compreso che il modello turistico della nostra città, alla nostra città, così come è, ormai non è più complessivamente e collettivamente conveniente. forse lo è nella dimensione individuale; ma nella dimensione pubblica e politica, non lo è. E certo, contro la comune evidenza, che reclama sempre maggiori presenze, questa può essere considerata una affermazione eccentrica che talvolta può disorientare gli interlocutori, quando non appaia il vezzo di un vizio intellettuale.
Eppure l’apparente vezzo snobistico è una sfida enorme, come si dice: “una responsabilità planetaria“; la concreta e credibile capacità di “vivere diversamente nel proprio Paese“. E questo “progetto di vita in un mondo in cui le risorse siano provvidamente utilizzate”[2], riguarda anche e principalmente quelle città, quei sistemi urbani aperti, che convivono con un incontrollato, e per certi versi incontrollabile, flusso turistico.
Il turista, infatti, non soltanto spende, ma consuma: “L’homo ludens, infatti, modifica l’ambiente che lo circonda anche semplicemente con la sua presenza fisica e può essere nocivo quanto l’uomo faber”[3].
Ogni presenza turistica aggiuntiva ha un costo sociale sull’uso dell’ambiente e sulla qualità della vita che non sempre viene ripagato dal valore commerciale del soggiorno. In tutto il mondo si registrano moltissimi e crescenti arrivi globali. Anno dopo anno le persone in movimento per viaggi e vacanze salgono in modo esponenziale in termini di popolazione mondiale. L’Europa primeggia nella classifica delle destinazioni preferite dai vacanzieri. Il nostro continente, che già oggi ospita circa il 60% del movimento turistico internazionale, verrà preso letteralmente d’assalto dalla gigantesca massa di villeggianti che nei prossimi anni si prevede visiteranno le regioni del bacino mediterraneo. Non è un caso che appunto l’Unione Europea si è preparata approvando una serie di Direttive che costituiscono un vero e proprio momento di svolta per lo studio dell’impatto ambientale applicato a strutture o a programmi turistici[7].
Almeno dal punto di vista della elaborazione di studi specializzati, della sperimentale e della progettazione di modelli di valutazione d’impatto ambientale, nel compiere “il primo passo di un cammino lungo quello che a prima vista sembra un paradosso, ma che in realtà è una necessità: proteggere il turismo dai turisti e per i turisti “[8], l’Italia, in termini di ricerca scientifica, sembrava all’avanguardia[9]. Ormai molti anni fa aveva sperimentato un modello, che si chiamava S.I.A,D. (Sistema d’Impatto Ambientale Dinamico), che consisteva in un esperimento pilota, di due anni, nella applicazione di una specifica metodologia a parametri multipli: gli studi di impatto tradizionali, l’analisi della dinamica delle popolazioni, la tecnica degli scenari e quanto altro utile e necessario per definire pragmaticamente obiettivi strategico-gestionali da sottoporre a verifica amministrativa. In pratica si prendeva come termine di riferimento una località turistica e la si considerava come un contenitore dove due popolazioni, residenti e turisti, competevano per gli stessi beni. Si trattava dunque di un vero e proprio simulatore che permetteva di definire l’intervallo di sostenibilità turistica di una specifica e definita area. Il Turismo è Sostenibile quando è possibile circoscrivere un intervallo in cui le attese dei residenti siano in equilibrio dinamico con quelle dei turisti. Quando invece non risulta possibile circoscrivere questo intervallo, le dinamiche economiche si scaricano quasi interamente sul contenitore territoriale che, sovente ne paga irrimediabilmente le spese. In questo modo il S.I.A.D., o altri simulatori simili, si mostravano particolarmente adatti alle amministrazioni di località piccole e medie che volevano gestire il turismo piuttosto che subirne il flusso irruente. Poi tutto si è fermato e dalla elaborazione non si è mai passati all'applicazione, come troppo spesso accade in Italia.
E’ evidente, infatti, che quando una città trabocca, cioè quando passa da quarantamila abitanti nel corso dei normali periodi dell’anno alle centinaia di migliaia presenze estive, una città ciclicamente affollata, consolida una altissima diseconomia urbana. Questo effetto, da noi, si è verificato per una ventina di anni. Alla fine sono saltati tutti o quasi tutti i meccanismi di tenuta.
In generale, allora, accade che la struttura dei servizi (dalla depurazione alla viabilità) non soddisfa più le esigenze della domanda: il gap tra i costi del sistema e i benefici sociali ed economici, diretti ed indiretti, del turismo tende a crescere. I costi diventano collettivi ed incommensurabili. I benefici privati risultano sempre meno commensurabili. L’imperativo diventa “reggere l’urto in un’ottica di turismo sostenibile “[10]. E nell’analisi dei flussi turistici, per poterne correttamente valutare l’economicità, occorre considerare “l’andamento in ragione dei volumi di traffico”[11] che, a certi livelli, procede a ritmo esponenziale; proprio perché “il prezzo unitario di ogni presenza turistica aggiuntiva tende a diminuire mentre il costo marginale tende ad aumentare”[12].
Questa dinamicità endemica dell’andamento turistico rende inadatta al settore l’applicazione dei vari modelli d’impatto ambientale oggi disponibili. Gli studi, infatti, si prestano poco a decodificare le variabili e le previsioni in un sistema aperto in movimento. Normalmente la valutazione di impatto ambientale tradizionale, ad esempio quella utilizzata per il settore industriale, verifica la “compatibilità delle singole opere”. Analisi possibile in situazione statica. In situazione dinamica, invece, nei sistemi turistici, si verifica che “un ambiente insostenibile può essere il risultato di un insieme di opere compatibili”.
Non disponendo di un sistema dinamico di valutazione[13] il settore turistico è rimasto largamente indietro. Inoltre, 4 fattori tipici occultano il peso sull’ecosistema delle eccessive presenze turistiche:
1. una carente legislazione generale; 2. la inavvertibilità e la diffusione del degrado turistico sull’habitat;
3. la incapacità nel percepire inquinante qualsivoglia attività ludica;
4. la notevole frammentazione del settore.
Di fronte a questo stato, la politica di prevenzione utilizza numerosi e variamente specializzati strumenti, differenziati a seconda dei progetti, dei piani, dei programmi e delle località a cui si applicano. Talvolta si utilizza il ciclo di vita – come in un passaggio di questo stesso testo –, altre volte la valutazione del rischio, oppure i sistemi di ecogestione e audit, l’analisi costi/benefici o, infine, i sistemi multi-criteri. Altri ancora possono essere elaborati ad hoc, tarati sulle singole e singolari località amministrative.
Questo caso però non è stato il nostro. A Terracina nessuna analisi costi/benefici, nessuna valutazione del modello turistico, è stata mai veramente compiuta; nessuna metodologia è stata applicata; nessuno strumento predisposto. Non prima. Non ora. Oggi ancora domina il mito del pieno. “Semplicissimo ad essere enunciato, per quanto non sia altrettanto semplice ad essere analizzato, lo possiamo definire il fenomeno della agglomerazione, del pieno. Le città sono piene di gente. Le case, piene di inquilini. Gli alberghi pieni di ospiti. I treni, pieni di viaggiatori. I caffè, pieni di consumatori. Le strade, piene di passanti. Le anticamere dei medici più noti, piene di ammalati. Gli spettacoli, non appena non sono troppo estemporanei, pieni di spettatori. Le spiagge, piene di passanti. Quello che prima non soleva essere un problema incomincia ad esserlo quasi ad ogni momento: trovar posto.” È l’avvento della massificazione: gli inequivocabili connotati, i forti lineamenti del fenomeno del pieno[14].
La città deve essere riempita ad ogni costo, ogni spazio occupato, ogni vuoto colmato. E alla fine tutto diventa confuso e tutto è disorientato, vago, improvvisato e non specifico; perché nell’accezione generale e generica della ragione ordinaria “più gente viene meglio è”. E si perde ogni volta lo Spazio Ambientale, cioè la possibilità delle persone di usufruire di un uguale diritto ad usare la natura nei limiti della sua capacità di carico e di rigenerazione. Si tratta cioè di un quadro operativo preciso che ha l’obiettivo di mantenere globalmente inalterati i fondamenti per la vita. Non si avverte il bisogno di definire una strategia economica per l’intera comunità[15]; tutto si altera e in qualche modo si riduce; e ci si aggrappa alla speranza dei “domenicali scalzi”[16] che, di solito, affollano a frotte i nostri Week End.
Quando, invece, c’è un punto di equilibrio da dover rispettare. C’è un intervallo prima del quale ed oltre il quale il turismo in una località non è più conveniente. In modo specifico possiamo affermare che, almeno per le località caratterizzate dall’esistenza di “risorse naturali di una certa attrattività”, con una precisa “localizzazione spaziale”, “nelle preferenze di consumatori che scelgono questi beni, la qualità di una località turistica diminuisce al crescere (presumibilmente oltre un certo limite) dell’affollamento della risorsa naturale”[17]. Infatti, vi sono situazioni in cui la quantità è invariante, cioè lo sfruttamento anche intensivo di alcuni beni non cambia la loro natura qualitativa. Nel caso dei beni naturali vi è, invece, una fortissima relazione di varianza tra la quantità consumata e la loro qualità complessiva (come ad esempio per il litorale). La quasi totalità dei beni turistici in una località costiera possono essere classificati in questa seconda tipologia. L’eccessivo sfruttamento di queste risorse ne modifica anche la qualità. Occorre quindi mantenere il tasso di presenza turistica in un territorio entro e non oltre un certo limite; entro un certo intervallo; all’interno dell’equilibrio di sostenibilità.
Fuori dall’intervallo di tenuta del sistema sociale urbano, oltre l’equilibrio di sostenibilità, il turismo produce soltanto costi che si scaricano interamente sulla collettività in termini ambientali, urbanistici e comportamentali .
Il mondo economico ha sempre rifiutato il concetto di sostenibilità, patrimonio della comunicazione sociale, prima, e di quella politica, poi. Anzi, per molti anni, i fautori della sostenibilità ambientale, erano considerati gli avversari, talvolta i nemici, della travolgente dinamica del mercato autoregolato. Negli ultimi anni, però, si è sviluppata una letteratura economica sul turismo tendente ad evidenziare la capacità di crescita endogena del turismo. Si tratta di una letteratura che mira a confutare il paradigma economico tradizionale secondo cui gli alti tassi di crescita del reddito sono il prodotto della modernizzazione, proprio per la sua automatica tendenza alla innovazione tecnologica. Il tasso di innovazione tecnologica del settore turistico, specialmente di quelle località che fondano la loro politica di marketing sulle risorse naturali, è scarsa. Quindi, per assonanza, si considerano poco convenienti. Questi autori[18] hanno abbondantemente dimostrato, anche sulla base del modello econometrico di crescita endogena, che il bene il cui prezzo cresce più rapidamente nel tempo è proprio quello turistico, perché “la sua offerta aumenta meno rapidamente di quella dei beni industriali, proprio a causa dell’inferiore innovazione tecnologica che caratterizza il settore”[19]. Tuttavia questa relazione turismo-crescita, per quanto suffragata dai dati ufficiali e dalle rilevazioni specialistiche sui paesi europei[20], insiste all’interno del medesimo paradigma economico e sociale che fa del capitalismo, come diceva Schumpeter, una immensa forza di “distruzione creatrice”[21]. Il mito inconfutabile della crescita.
“Nel suo insieme il sistema di produzione industriale può essere considerato come un vero e proprio organismo: inghiotte risorse che preleva dalla natura, le sottopone a elaborati processi di trasformazione, produce oggetti, espelle rifiuti. Ma si tratta di un organismo un po’ particolare, affetto, per così dire, da una insaziabile bulimia fisiologica. L’indicatore del suo benessere è la crescita del prodotto interno lordo, ovverosia la crescita annua della quantità di beni che produce e di servizi che offre. Maggiore è l’incremento delle risorse che di anno in anno inghiotte e trasforma, maggiore è l’incremento degli oggetti che produce e, conseguentemente, dei rifiuti che scarta, migliore è il suo stato di salute complessiva”[22] . Sennonché il mito della crescita irrefrenabile vale principalmente per la produzione industriale, per la frenetica esigenza di ricambio dei prodotti di consumo. La società, per produrre, deve bruciare ciò che produce. Voler regolare e, per certi versi, regolamentare questa forza, in qualche modo significa volersi contrapporre alle irruenti esigenze della modernità. L’economia di una società deve crescere, e per crescere si deve accrescere. Se la spinta di questa crescita individuale non ha rispetto delle risorse collettive, poco importa. Nella cultura della società capitalistica immatura, la spinta economica all’accumulazione è sacralizzata in quanto emblema dell’avvento, immediato simbolo della libertà di azione d’individui intraprendenti.
Dal punto di vista ecologico, non vi sono soltanto i prodotti, ma anche le risorse. E le risorse non possono essere generate con un meccanismo artificiale. Tanto meno possono essere riprodotte. Tuttavia possono essere consumate ed eventualmente distrutte, in modo irreversibile. La società, allora, deve concentrarsi sugli aspetti qualitativi, sociali, dello sviluppo[23]. La crescita di nuovi consumi può e deve essere arginata dalla scelta di modelli autonomi di sviluppo e da una tempestiva stabilizzazione demografica. Altrimenti la vita diventa muta. I suoni le forme, i sapori, i colori, gli odori di un luogo non si sentono più e noi soggiacciamo ad una grande e graduale esperienza di perdita dei significati.
La tendenza a collocare il concetto di sostenibilità nella Teoria Ecologica dello Sviluppo, piuttosto che nella dinamica delle organizzazioni sistemiche o dei network, non è stata ancora superata. E non può essere superata perché, in gran parte, questa impostazione è da considerarsi esatta, anche se non completamente esaustiva. “In tutto il mondo, la produzione industriale sembra indirizzata verso la crescita inesorabile. Ma se gli attuali modelli di produzione e di consumo si affermassero globalmente, causerebbero gravi alterazioni dei sistemi ecologici. Questa cognizione si traduce dalla fine degli anni ’80 in un nuovo concetto di sviluppo. SUSTAINABLE DEVELOPMENT è la denominazione per uno sviluppo in cui le necessità delle generazioni odierne vengano soddisfatte senza mettere a repentaglio le basi per la vita delle generazioni future. Con questa nuova idea guida si collega la nozione che i problemi di politica ambientale non possono essere considerati in modo separato rispetto agli sviluppi economici e sociali.”[24].
Così inizia lo studio di Wuppertal per il clima, l’ambiente e l’energia sulla riconversione ecologica della Germania, prodotto per conto della LEGA PER L’AMBIENTE E LA PROTEZIONE DELLA NATURA DELLA GERMANIA (BUND) e di MISEREOR, che è la più grande organizzazione cattolica tedesca per la cooperazione allo sviluppo dei popoli poveri. Un esordio felice: sia perché riferito al significato più frequente di sviluppo sostenibile; sia perché rivolto contro la ricorrente demagogia intellettuale dei mezzi di comunicazione di massa, contro le parole emblema di cui si ciba la platea telematica, contro la minaccia alla qualità della vita quotidiana che il concetto di globalità continuamente incute.
LINEE DI RIFERIMENTO DI UTILIZZO DELLE RISORSE
1 – una risorsa non può essere sfruttata oltre la sua capacità di rigenerarsi;
2 – non si possono immettere nell’ambiente più sostanze di quanto l’ambiente riesca ad assorbire;
3 – i flussi di energia e di materiali devono essere ridotti ai livelli che generano i minori rischi.
L’esigenza di valutare in modo sistematico, se non proprio sistemico, gli effetti di breve, medio e lungo periodo della trasformazione di un determinato ambiente, si afferma politicamente a partire dagli anni ’70. Un’esigenza che scaturisce direttamente dai fallimenti, dalle impreviste conseguenze, o meglio ancora, dagli “inaspettati effetti negativi di numerosi progetti e piani settoriali “. Si tratta di un approccio finalizzato a modificare la struttura del processo decisionale, cioè la struttura vera e propria della funzione politica d’ogni forma e tipologia di organizzazione. Da un certo momento in poi ci si basa “sulla PREVISIONE delle conseguenze e sulla VERIFICA della loro ACCETTABILITA’ SOCIALE”[25]. Soltanto 17 anni dopo, però, venne formalmente enunciato il concetto teorico ed empirico della sostenibilità ambientale.
Il concetto di sostenibilità si configura immediatamente come un momento, un passaggio fondamentale della più ampia metodologia relativa al controllo dell’azione sociale, nei modi e nelle forme con cui viene interpretata e compiuta negli U.S.A., per diffondersi rapidamente al mondo intero. In altri termini, il concetto di sostenibilità diventa uno strumento tecnico di politica della prevenzione, sebbene tenuto circoscritto all’interno del paradigma dello sviluppo ecologico. Da un certo momento in poi, dunque, gli osservatori internazionali maggiormente sensibili ai meccanismi di tenuta dell’ambiente, assumono l’ipotesi centrale che le questioni ecologiche degli ultimi dieci anni nelle società complesse siano diventate questioni strategiche dello sviluppo. In questo modo, infine, negli ultimi anni, “lo sviluppo sostenibile è divenuto un obiettivo dichiarato delle politiche economiche e ambientali dei vari paesi e degli accordi internazionali aventi per oggetto materia ambientali”.
Oggi, ancora non sappiamo se la disponibilità generale ad acconsentire, quando si pongono in generale i temi del controllo ecologico ed in modo specifico quelli della sostenibilità ambientale, sia una convinzione o un atteggiamento. L’impressione è che, sia per la politica turistica sia per la politica ecologica, la maggior parte dei soggetti a cui ci si indirizza adottino prevalentemente un atteggiamento di disponibilità senza alcuna convinzione reale. Anche perché i comportamenti che seguono gli apprezzamenti non mi sembrano proprio corrispondenti alle esigenze sociali. Politica turistica e politica ecologica appartengono a quel tipo di attività che non si realizza con una delibera votata all’unanimità. Occorre un comportamento costante e quotidiano, occorre una coscienza culturale, occorre costruire un apposito modello culturale che faccia da riferimento all’azione sociale. Aderire alle problematiche dell’equilibrio ambientale, alle esigenze di vivere in un habitat controllato e con un tasso di inquinamento tutto sommato sostenibile, è molto semplice, con una certa superficialità e molta disposizione d’animo; “mentre molto più difficile è trovare un accordo per definirle in modo preciso e operativamente significativo”[26].
A rigore già quando per la prima volta il concetto di sviluppo sostenibile fu sottoposto all’attenzione della pubblica opinione internazionale[27], il legame tra sviluppo economico e ambiente era molto forte. Un legame che, nel tempo, si è rinforzato ed oggi addirittura la stessa teoria economica “suggerisce in realtà di non accondiscendere ad una lettura riduttiva del concetto di sviluppo sostenibile”[28]. Il problema consiste nella capacità dell’ambiente di “fornire utilità”[29], di assolvere alla singola funzione economica sia in quanto ambiente preservato che in quanto ambiente sfruttato. È l’ambiente che deve essere messo in condizione di sostenere lo sviluppo del sistema economico, contravvenendo alla sensazione che le risorse siano infinite o infinitamente rinnovabili o almeno rigenerabili. In ogni caso è l’ambiente che deve reggere il peso della crescita, mantenendo nel tempo lo stock di risorse disponibili al tasso di sfruttamento del loro consumo. Se questo tasso risulta contenuto entro il limite della capacità di rigenerazione dell’ambiente, allora è possibile ottenere “contemporaneamente sfruttamento e preservazione delle risorse”[30].
PARAMETRI DELLO SPAZIO AMBIENTALE
1 – capacità di carico sopportabile dagli ecosistemi;
2 – capacità di rinnovamento delle risorse naturali;
3 – disponibilità di materie prime;
4 – uguali diritti all’utilizzo delle risorse globali per tutti gli uomini, nei limiti della compatibilità ecologica.
Di fronte al movimento di “distruzione creatrice” del capitalismo, gli attori sociali prendono coscienza del “rarefarsi delle risorse naturali”. Nel migliore dei casi acquisiscono la coscienza di dover definire il trend dello sviluppo in modo preordinato. Propongono i criteri che ritengono utili ad indirizzare il movimento dei sistemi urbani aperti. Sanno che i singoli progetti non valgono in assoluto; che le ipotesi di sviluppo non restano, non resistono sempre e comunque. Ogni esperienza, e ancor di più ogni esperimento, si scontra con le tendenze direzionali degli spazi e con la frequenza dei ritmi nel tempo.
Ci si pone il problema della loro ragionevole utilizzazione, in relazione alla possibilità di fruizione per le generazioni successive. E porsi il problema delle generazioni future significa chiedersi, prima di ogni decisione, quale città troveranno fra 20-30 anni i bambini che nascono oggi. Gli ecologisti si preoccupano di “progettare lo sviluppo” che, nella dinamica irreversibile dei sistemi aperti, è praticamente (e teoricamente) impossibile. Al limite si potrebbe, ed è già tanto, governare il processo di differenziazione funzionale per fare in modo che, con maggiori probabilità, possa condurci o alla complessità sociale o all’asociale caos. In ogni caso, ci si rende conto che l’avanti tutta! del nostro modo di vivere e di fare economia non è più sostenibile; che “viviamo oggi una lacerazione: si parla di ambiente e di mondo, ma non si pongono le fondamenta per il necessario cambiamento di struttura”[31]. Si tratta di una divaricazione che coinvolge, e per certi versi assorbe, ogni generosa speranza, sia politica che privata.
Per superare questa divaricazione l’approccio ecologico propone una sfida enorme; ci affida una responsabilità planetaria: nella sua completa e complessiva esposizione[32] affronta la questione del vivere diversamente nel proprio Paese.
Il peso della responsabilità di mantenimento generale dell’ecosistema urbano e dell’ambiente si scarica completamente sui nostri comportamenti: cresce la domanda di tecnologie meno inquinanti; si reclama l’aria salubre; si pone l’accento sulla nuova occupazione e sulle professioni innovative; si reclama una maggiore collaborazione tra soggetti pubblici e privati, al fine di ridurre il peso inquinante delle azioni sociali. Ma sul piano organizzativo niente. Gli osservatori si distinguono tra i fautori di una concezione puramente economicistica del mondo, che divide il mondo in poveri inutili ed inutilizzabili, i possibili mercati, i concorrenti temibili, e gli asceti di un universo puro o purificato. Manca una visione organizzativa o sistemica del concetto di sostenibilità dell’habitat e dell’ambiente.
Sul piano organizzativo l’impostazione è perfettamente opposta, ma non alternativa. Opposta e complementare. Non soltanto l’ambiente deve sostenere il peso della evoluzione dei sistemi. Anche i sistemi, e principalmente i sistemi aperti, prevalentemente i sistemi urbani aperti, hanno un problema strutturale di sostenibilità. Perché i sistemi aperti evolvono in modo irreversibile e, in questo movimento, tutti - gli individui, i contesti ambientali, le situazioni storico sociali – subiscono una trasformazione relativa, costante ed anch’essa irreversibile. Considerare il concetto di sostenibilità delle strutture di un sistema urbano aperto, significa gestire queste trasformazioni, rispettare questo divenire, governare il movimento senza perdere la dimensione temporale dello spazio come riferimento. Non si tratta più soltanto, dunque, di mantenere integro il capitale ambientale per le generazioni successive.
Nell’ambito della teoria delle organizzazioni sistemiche l’impostazione ecologica dello Sviluppo è trasversale in ogni forma di stratificazione, orizzontale e verticale, nella realtà pluridimensionale dello spazio[33] e nella unidirezionalità irreversibile del tempo[34]; è pervasiva in tutte le multiformi specie di habitat, nelle variegate turbolenze dei sistemi multistabili[35]; denotativa dell’eredità linguistica, delle combinazioni simmetriche o asimmetriche interne alla semiosfera[36].
Collocato nell’ambito dell’ingegneria dell’evoluzione delle organizzazioni, il concetto di sostenibilità, si applica a qualsiasi tipologia d’organizzazione complessa; che sia comunitaria o societaria, sistemica o network. Si tratta di organizzazioni che comunque cambiano, forme che sempre fluiscono; dove gli elementi che denotano il concetto di sostenibilità, anche nell’ambito dello sviluppo turistico di un sistema urbano complesso (come appunto è lo sviluppo di una città mediterranea), sono:
- i processi, cioè l’idea che la qualificazione dell’ambiente avvenga, come un atto e non come un semplice fatto; sulla base di una manifestazione di volontà dei suoi attori protagonisti diretti e mediati. È una decisione, una scelta, che ci conduce allo sviluppo entro un movimento sistemico e sistematico, di azione o di retroazione, a ritmi costanti o incostanti, con fasi di innovazione e di conservazione;
- i contesti relazionali, differenti, differenziati, complementari o alternativi, che tuttavia sono uno degli elementi essenziali per definire il livello di qualità della vita di una comunità e quindi la sua capacità di svilupparsi, cioè di sostenere il generale processo di crescita (nel nostro caso turistica);
- i cambiamenti sociali funzionali alle generazioni successive; mentre il criterio prevalente in base al quale si decide in una piccola comunità, consiste nello scegliere tra ipotesi immediatamente possibili in funzione delle emergenze; senza alcuna proiezione generazionale che richiederebbe dei sacrifici o comunque degli sforzi e che, quindi, risulta impopolare ai politici[37]. Nonostante l’opportunismo elettorale, sempre presente e vigile nella struttura cognitiva dei politici locali e comunali, decidere secondo il criterio di sostenibilità, in un sistema urbano complesso, significa assumere un preciso paradigma di riferimento che potremmo rappresentare con la formula banale, S = Cf(X) dove S è lo sviluppo, C sono i cambiamenti attuabili X le generazioni future che non conosciamo. Appare dunque evidente, anche soltanto con una percezione ottica, che la tipologia dei cambiamenti, per garantire livelli di sviluppo reali, deve essere selezionata in funzione al valore riconosciuto all’incognita generazionale;
- la dimensione temporale: anche questa è una variabile di cui normalmente non si tiene conto e che invece caratterizza in modo determinate il lavoro svolto nelle Amministrazioni Locali. Un piano d’intervento, e nel caso specifico una programmazione o una promozione turistica, cambia notevolmente in relazione ai tempi della sua attuazione e anche i ritmi di sviluppo assumono un diverso valore relativamente alla congruenza con i tempi di attuazione delle scelte. Lo sviluppo – direbbe Ortega Y Gassett - deve essere “all’altezza dei tempi”;
- gli individui, che si emancipano come gli ambienti, dentro, assieme, talvolta contro le condizioni generali del loro habitat, e che sentono sulla loro pelle, sempre più, la pressione massmediologica della società complessa. Il futuro dovrà avvenire. Il passato è avvenuto. I cittadini della nostra società telematica vivono in proiezioni virtuali di sé, entro ambienti immaginari e non sentono più l’avvenente, il presente, sottoposti alle frustate della fisicità, fatta di incomprensioni o di incomunicabili passioni generazionali;
- il ciclo di vita, che raccoglie tutto questo in un intervallo circoscritto, che scandisce le modalità, la tipologia ed il ritmo della evoluzione organizzata e che, quindi, deve essere gestito in ogni sua fase. Alla fine, se c’è una fine, il ciclo di vita di una qualsiasi organizzazione o di un organismo o si rinnova, o si standardizza, o decresce. In ogni caso prosegue anche con traumi, ma senza salti, in un continuum.
Queste caratteristiche tipiche, e forse esclusive, ci permettono “di inquadrare i processi dello sviluppo umano nei differenti contesti, considerando la dimensione temporale sia negli individui che si sviluppano sia nei contesti ambientali che si modificano anch’essi non solo durante il ciclo di vita dell’individuo, ma anche nei cambiamenti storico-sociali che riguardano generazioni successive.”[38].
Tuttavia, collocare il concetto di sostenibilità nell’ambito della Teoria Ecologica dello Sviluppo, sebbene necessario, non è sufficiente. “La stretta correlazione tra funzioni vitali critiche della città e il degrado ambientale sollecita un approccio interdisciplinare per la riconversione ambientale degli elementi costitutivi dei sistemi urbani, finalizzata a reindirizzare lo sviluppo delle aree metropolitane verso la sostenibilità ambientale, economica, sociale“[39].
Nella Teoria Ecologica dello Sviluppo la sostenibilità è “un concetto normativo che richiede studi di valore”. Il tema in discussione consiste nel “sincronizzare gli obiettivi ecologici; quelli di libertà, quelli sociali e quelli economici”. Si discute “con la ferma volontà di trovare soluzioni capaci di assicurare il futuro“; nella consapevolezza che ogni secolo prossimo venturo “sarà comunque – piaccia o no – il secolo dell’ambiente: quello delle svolte o quello delle catastrofi ecologiche”. Questo approccio si vuole qui, se non proprio contestare, almeno superare: nella consapevolezza che la crisi ambientale dei sistemi urbani aperti sia oggi il prodotto diretto della inefficienza infrastrutturale; del costo di una loro disarticolazione interna che si mostra nella forma di una cattiva gestione del territorio, che si scarica direttamente sul peggioramento della qualità della vita e finisce indirettamente ad aggravare il disaggio sociale metropolitano.
S’intende qui affermare, infatti, che la Sostenibilità di un sistema, di ogni sistema, sia qualcosa in più: sia il carattere di autoregolamentazione del processo di differenziazione funzionale. Cosa significa?
Mi spiego.
E mi spiego prima teoricamente e poi praticamente.
Un habitat, politico, economico, sociale, culturale, sportivo, non sempre è fermo, spesso si muove. Anzi, possiamo ritenere che un sistema prevalentemente si muova e che raramente sia fermo. La teoria insegna che il movimento è facoltativo per gli habitat chiusi ed è obbligatorio, invece, per i habitat aperti.
Gli habitat chiusi non ricevono input dall’esterno e possono quindi permanere costantemente nel loro stato iniziale. Avviene raramente, ma avviene. Gli habitat aperti, viceversa, scambiano per definizione con l’esterno, ricevono determinati impulsi che inducono alle trasformazioni dei loro irreversibili processi interni. E dunque posso evolvere verso una superiore (o inferiore) complessità (cioè verso una decrescente entropia) o involvere verso una situazione caotica (cioè verso una crescente entropia).
La trasformazione degli habitat avviene con un meccanismo di controllo dei processi che denominiamo differenziazione e che consiste in un procedimento in base al quale “la potenza e il numero delle trasformazioni aumentano così tanto da permettere una progressiva specializzazione delle funzioni interne”[40].
La differenziazione funzionale è una forma di potenziamento delle organizzazioni complesse che passano: da uno stato iniziale o primitivo, “in cui il comportamento del sistema risulta dalle interazioni tra parti equipotenziali”; ad uno stato successivo o stratificato, in cui “si verifica una subordinazione rispetto ad alcune parti dominanti”[41]. In questo modo i sistemi si strutturano, costruiscono un loro proprio ordine gerarchico “che controlla e supera l’iniziale instabilità”[42], attivano comportamenti meccanici e ricorsivi tra le reciproche differenziate funzioni. Questi meccanismi incrementano il tasso d’integrazione reciproca e rafforzano gli scambi tra i vari livelli.
Il movimento degli habitat aperti è, così, cumulativo. L’energia che assorbono dall’ambiente esterno viene caricata sulle funzioni interne (CAPITALE NATURALE DI CARICO). Poiché ogni funzione risulta essere diversa da ogni altra funzione, il capitale naturale di carico può essere frazionato ed il peso di assorbimento suddiviso tra le varie parti. Prive e private di reciproca identità, le funzioni sviluppano le proprie caratteristiche emergenti, che crescono autonomamente e che trasformano il sistema, in un tempo successivo, occupando uno spazio più ampio, in modo nuovo e maggiormente complesso.
Si tratta di caratteristiche emergenti di singole funzioni che entrano in uno scambio cumulativo d’informazioni e, man mano, rafforzano la propria singolarità. Assorbono energia dall’ambiente esterno e si specializzano; assumono il carattere dell’esclusività ed offrono una prestazione reale. In questo movimento autoreferenziale in cui il sistema assorbe dall’esterno energia che serve ad accrescere se stesso, le caratteristiche autonome, le anomalie[43], si espandono, si autonomizzano e mutano verso altri livelli organizzativi per controllare il rischio permanente di instabilità. “L’evoluzione dei sistemi consente il controllo della discontinuità spazio temporale attraverso informazione integrativa“[44] che, una volta assorbita dal sistema (interiorizzata), attiva le connessioni necessaria alla specializzazione, alla autonomia ed alla interdipendenza delle sue componenti. Specializzazione, autonomia ed interdipendenza, infatti, sono le tre fasi in cui si caratterizza il processo di differenziazione funzionale[45].
Il processo di differenziazione funzionale, che espande la complessità dello sfondo sociale generando continuamente habitat nuovi integrati in vari insiemi di relazioni, è abbondantemente avvenuto nel corso della nostra storia.
Ad esempio, le funzioni prevalenti di una comunità, quella politica, quella religiosa, quella scientifica, erano prima congiunte nella figura e nel ruolo del re/dio/sciamano. Poi, pian piano, i re sono diventati decisori puri; i sacerdoti hanno svolto la sacra ed esclusiva funzione degli ordini religiosi finalizzati alla cura delle anime; mentre gli scienziati medici hanno pensato esclusivamente a curare i corpi.
La complessità sociale è avvenuta con un movimento autopoietico o autoreferenziale, cioè permettendo ad ogni singola funzione di affrontare le questioni relative alla organizzazione di se stessa e di applicare meccanismi ricorsivi finalizzati allo strutturarsi autonomo in sottosistemi di rappresentanza per nuovi livelli dimensionali.
I decisori hanno cominciato a decidere su come dover decidere.
I religiosi hanno iniziato a studiare i testi sacri e la teologia[46] per supportare di un senso e di un significato il comportamento religioso; anime utili a curare altre anime.
La cura dei corpi è anche stata finalizzata allo scopo di conoscere come curare altri corpi; lo studio della medicina, infatti, è servito e serve ancora a definire termini e terapie, pratiche e linguaggi di specializzazione della medicina stessa. E così via, in un insieme articolato e autoregolamentato di meccanismi ricorsivi, azioni tradizionali e azioni innovative, strutture conservative e strutture dissipative, messaggi evocativi e linguaggi connotativi, fino alla specializzazione, alla autonomia ed alla reciproca interdipendenza; fino alla legittimazione di sistema: quello politico, quello religioso e quello scientifico.
Da quanti ambienti diversi, per diverse e ignote cause, questo movimento, il processo di differenziazione funzionale, è partito! E non si è mai fermato, è continuato, allargando lo scenario, espandendo lo sfondo, lasciando liberi di interagire nuovi habitat, specializzando nuove funzioni che si sono a loro volta potenziate e successivamente costituite in altrettanti habitat, lungo un inarrestabile processo di differenziazione funzionale che ci ha condotti dalla gemeinschaft alla gesellschaft, dalla semplice comunità alla società complessa, dai sistemi ai network.
Anche una cittadina, una località di provincia, è un sistema urbano complesso. Anche una piccola cittadina come la nostra evolve, in un processo di espansione dell'habitat delle sue relazioni, assorbendo energia, occupando lo spazio, trasformando, in determinati periodi di tempo, l’ambiente esterno in habitat interno. Anche un grande paese come il nostro partecipa al processo di differenziazione funzionale ed evolve verso nuovi livelli di complessità o involve verso uno stato di instabilità strutturale e di caos. Anche noi conviviamo con il rischio evolutivo della discordanza dell’informazione. Cosicché le nostre città di provincia ci appaiono improvvisamente troppo piccole per i grandi problemi e troppo grandi per i piccoli problemi. Solo allora, di fronte alla incapacità di costruire un ordine gerarchico successivo in grado di incrementare l’integrazione delle parti per rafforzare gli scambi tra i diversi livelli, noi prendiamo coscienza che la complessità sociale della città non è una occasionale situazione, è la sua inevitabile ed irreversibile condizione. Ignari di partecipare ad un processo, che ci coinvolge e, per molti aspetti, ci travolge, noi trascuriamo di valutare le trasformazioni generali. Ignari di essere il risultato e al tempo stesso la risultante di un movimento, noi ci accomodiamo nella stanca ripetitività dell’esistente. Questo atteggiamento, che frena e disarticola quel processo per cui le funzioni si differenziano, disarticola il nostro sistema urbano aperto e riduce la qualità media della nostra vita. La capacità di riformare una organizzazione complessa, infatti, è il modo migliore per garantirne la sopravvivenza. “In generale le trasformazioni di un sistema sono il risultato di una attività conservativa e di una risposta a stimoli esterni che richiedono un cambiamento”[47]. La statica permanenza dell’uguale è una minaccia alla nostra sopravvivenza.
Contro la staticità tranquilla e accomodante dei sistemi chiusi, noi conviviamo con il movimento e le sue forme di cambiamento degli habitat urbani aperti. La loro dinamica consiste nell’aspirare e nell’espirare energia dall’esterno sotto forma di livelli spazio/temporali. In altri termini, questo movimento, questo processo di differenziazione funzionale, è un’attività selettiva di risorse disponibili, un “processo in negativo di eliminazione e rinvio provvisorio di possibilità“[48]. È un’azione che destabilizza, in cui l’habitat perde il suo stato acquisito e tradizionale di organizzazione. La disorganizzazione, dinamica o statica, strutturale o funzionale, è sempre “una continua alterazione dell’equilibrio raggiunto”[49] che manda in fibrillazione le parti interattive degli apparati. Fratture, irregolarità, discontinuità, mancanza di linearità, sono tutti i sintomi dell’azione sistemica che tenta costantemente di ridurre il suo stato di instabilità genetica con un trasferimento di organizzazione ad un altro livello di complessità; dove almeno sia possibile l’esistenza di un osservatore interno in grado di selezionare “il dominio di pertinenza e di possibilità del sistema”[50]. La conquista dello spazio esterno, l’espansione dell’habitat verso nuovi confini, nei sistemi urbani aperti, consiste, oltre che proprio nella occupazione fisica dei terreni, anche in un diverso ordine di rapporti, in un nuovo “stato di ordine o di disordine”, come diceva von Foerster; stati di cose “che vengono via via scoperti” o che “vengono via via inventati”, e che fanno salire la pressione interna dell'habitat, la febbre della sua disorganizzazione: il livello di entropia che deve essere tenuto costantemente sotto controllo affinché si possa rimanere in equilibrio.
La letteratura scientifica sui sistemi[51] ha mutuato il concetto di entropia dalla fisica classica e, in particolare, dalla termodinamica[52]. “Il disordine, la disorganizzazione, la mancanza di configurazione o la organizzazione causale di un sistema è conosciuta come la sua entropia”[53].
Tuttavia questa identificazione tra entropia e disorganizzazione non mi sembra molto precisa. Entropia non è un sinonimo di caos.
Specie se in movimento, l’entropia è l’effetto di una mancata configurazione o della organizzazione casuale di un habitat. È una sorta di febbre che caratterizza lo stato di malattia di un corpo. Non è la malattia. Questa concezione è verificabile almeno nei sistemi aperti dove, grazie alla irreversibilità unidirezionale del movimento, “l’entropia può, infatti, diminuire, per cui essi possono svilupparsi spontaneamente verso stati di maggiore eterogeneità e complessità”[54].
In altra sede, e in altro tempo, si potranno discutere gli aspetti teorici relativi a questa diversa interpretazione del concetto di entropia.
A me interessa ora, qui, soltanto specificare, a scanso di possibili provetti censori, che il concetto di entropia applicato non è un sinonimo di disorganizzazione, ma un suo effetto consecutivo e, al limite, complementare. Di questa anomalia interpretativa del paradigma dominante ho perfetta coscienza. In ogni caso continuo a ritenere che in un sistema lo stato di disordine produca e che, viceversa, l’ordine riduca l’entropia.
Per entropia, dunque, intendo lo stato di tensione, la pressione sociale che il disordine, la disorganizzazione, la mancanza di configurazione o l’organizzazione casuale di un sistema scarica all’interno e all’esterno delle sue stesse strutture.
Una pressione che può essere o non essere sostenuta.
Se viene circoscritta entro un certo intervallo di equilibrio, l’entropia non disarticola l'habitat. Oltre i limiti di un certo intervallo di equilibrio, appunto oltre l’equilibrio di sostenibilità delle strutture, quando cioè l’entropia trasborda perché cresce troppo o troppo decresce, l'habitat si disarticola, o esplode, o implode.
Il rischio di fuoriuscita dell’entropia dall’intervallo di sostenibilità è molto più forte nei sistemi chiusi di quanto non sia nei sistemi aperti, “perché il sistema chiuso è meccanicamente reversibile ma non può ridurre l’aumento totale del disordine; il sistema aperto non è reversibile nelle sue trasformazioni ma riesce, in misura parziale, a produrre ordine e nuova organizzazione”[55] .
l'habitat aperto, proprio poiché deve procedere senza poter tornare indietro, differenziando le proprie funzioni verso nuovi livelli di ordine, in sottosistemi o in autonomi sistemi, nel tempo, ha tutte le possibilità: “l’entropia può aumentare, rimanere, diminuire”[56].
l'habitat chiuso, no. l'habitat chiuso è reversibile, può ripercorrere i suoi passi; ma questo ritorno non elimina lo stato di sordine raggiunto; anzi, quasi meccanicamente, lo accresce e quindi non elimina ma accresce la pressione sulle sue strutture, non elimina ma accresce la sua entropia interna.
L'habitat aperto, viceversa, è irreversibile, non può tornare indietro, perché assorbe energia utile alla sua organizzazione dall’esterno, modificando automaticamente in questo assorbire lo stato d’organizzazione interna e l’ambiente. L'habitat aperto, una volta trasformato l’universo di suo riferimento, deve andare oltre, continuare a muoversi in avanti, senza ritorno. I processi interni assumono così uno stato di configurazione in funzione dello scambio con l’esterno. Queste configurazioni ulteriori cambiano, dunque, in base alla tipologia dello scambio attingendo energia e trasferendo funzioni organizzative in strutture locali (decentramento) o, meglio ancora, differenziando le proprie funzioni in sottosistemi o in sistemi autonomi. Questo movimento degli habitat aperti, pertanto, genera nuovi e successivi livelli di organizzazione che, appunto, aumentano, stabilizzano o riducono il livello di entropia[57].
È questo l’inequivocabile caso di un habitat urbano aperto. Le decisioni assunte o non assunte indirizzano la crescita o lo sviluppo di una città in modo irreversibile. Il movimento si propaga e, nel suo costante processo di assorbimento può aumentare, mantenere o ridurre l’entropia. L’importante è che queste fluttuazioni di livello della pressione entropica si mantengano all’interno dell’intervallo di sostenibilità. Altrimenti se il livello di entropia è troppo basso un habitat rischia di implodere, cioè di scomporsi e man a mano di decomporsi; se il livello di entropia è troppo alto l'habitat rischia di esplodere, di scoppiare, di frantumarsi.
Dunque, dentro il processo di differenziazione funzionale, che è il movimento degli habitat verso la complessità, la sostenibilità è, al tempo stesso, l’intervallo e il criterio con cui si tiene sotto controllo l’entropia. Quando non c’è o non funziona il principio della sostenibilità, non c’è o non funziona lo sviluppo. Ad un estremo[58], può esservi la stasi di un habitat chiuso, cioè l’assenza di movimento; all’altro estremo può esservi una crescita, cioè movimento frenetico e sfrenato[59] di un habitat aperto. In entrambi i casi però lo sviluppo, il movimento regolato e regolamentato – anche se non necessariamente regolare – non c’è.
La fase di stasi rischia di abbassare troppo il livello di entropia e quindi di portare l'habitat, nel nostro caso il sistema turistico, alla implosione; caratterizzata da assenza generale e generalizzata di azione.
La fase di crescita rischia di alzare troppo il livello della entropia interna di un habitat, del nostro sistema turistico, e quindi portarci fino al punto limite e, poi[60], alla esplosione[61]; caratterizzata normalmente da uno stato rivoluzionario, oppure da una conflittualità particolarmente alta.
In conclusione, così come esordito, pertanto, il principio della sostenibilità ha una funzione determinante nella logica e nella dinamica del movimento fenomenologico e non può restare circoscritta soltanto all’interno della teoria ecologica dello sviluppo.
Forse mi spiego meglio con un esempio.
Con il nostro esempio.
Con l’esempio della nostra città, del nostro habitat aperto.
Terracina è il caso tipico di una comunità che si è tranquillamente affidata, direi quasi adagiata, sulla facile ed automatica crescita: frenetica e sfrenata.
La città, prima si popolava in inverno[62] e poi in estate, accomodata sulla economia del duplice passaggio: di chi passa sulla città, lungo la storica via Appia nel tragitto Roma Napoli; e di chi passa nella città saltuariamente o provvisoriamente per un’attività economica o per una meritata vacanza. Terracina, forse in anticipo sulla situazione nazionale, fino agli esordi del terziario ricreativo, è cresciuta spontaneamente, senza freni, in modo indistinto ed indiscriminato. La presenza turistica in città è continuata a crescere, senza porsi troppi problemi; ignara dello sviluppo che pretende nelle decisioni politiche l’applicazione del principio di sostenibilità. La città è cresciuta senza criteri finendo in una situazione complicata, piuttosto che in una condizione complessa[63].
Un habitat complicato, cioè con un disequilibrio entropico per assenza della sostenibilità regolatrice, ha alcuni caratteri tipici.
A differenza della complessità, un contesto relazionale complicato si stringe, quasi si aggrappa, esclusivamente attorno ad una risorsa prevalente e la sfrutta senza alcun ritegno e senza alcun rigore, senza controllo, priva di ogni preoccupazione per le generazioni future, senza limite.
Il mare è stato ed è ancora la risorsa turistica esclusiva per Terracina. La città nuova è stata costruita interamente lungo la battigia. In pochi metri lineari, dal lungomare alla principale strada interna – via Badino -, abita quasi il 75% della popolazione cittadina. Entro quello stesso perimetro vi è il vasto patrimonio di seconde, terze, quarte e quinte case che ci permette di ammassare circa 300 mila turisti estivi, contro i 30 mila che siamo durante il resto dell’anno.
IL MARE
Il mare, come già altrove espresso, è stato l’alibi della nostra crescita sregolata e colpevole.
Il mare, il nostro mare, principalmente negli ultimi cinquant’anni, ed oggi ancora, è per noi, oltre che una risorsa, un alibi.
- - l’alibi della crescita: è l’alibi della espansione incontrollata ed irrazionale, poiché il mare nostrum porta con sé la responsabilità di una città non distesa, ma accalcata al ridosso della battigia. Per il mare giustifichiamo la presenza di una strada (la 148 pontina) che come una tenaglia schiaccia la crescita della città lungo la costa, costringendo l’intera urbanizzazione nel breve spazio tra via Badino e Viale Circe. Le case, come una folla di ombrelloni, hanno un valore direttamente proporzionale alla loro dislocazione rispetto al mare; dipende dall’essere in prima, in seconda, in terza o in quarta fila. E restiamo accalcati, accavallati, gli uni spinti dagli altri, come lista d’attesa, con le case che si aprono entro altre case, disposte dal miraggio di uno scorcio di mare.
- - l’alibi dell’economia di rendita: ne è derivata una economia di rendita, in cui le stanze si affittano esclusivamente nei pochi mesi estivi, disponibili soltanto per coloro che decidono di venire al mare. Vendiamo ed affittiamo le case al mare così come prima, molti anni prima, abbiamo venduto ed affittato la macchia. La storia economica della nostra città è una storia di usufrutto, finalizzata più alla rendita da una proprietà acquisita che al guadagno da una attività svolta, più da una pretesa che da una impresa economica. Abbiamo venduto legna e terra con l’alibi della Macchia come vendiamo oggi la casa e la spiaggia con l’alibi del mare. D’altronde la strada (la via Pontina) ci ha portato direttamente sulla spiaggia frotte di turiste senza che noi avessimo l’obbligo di cercarli. Venivano da soli, autonomamente, automaticamente: venivano al mare. Nemmeno oggi vengono per noi, vengono da noi; nemmeno oggi vengono per la nostra città, vengono nella nostra città. Non vengono cioè a vivere con noi dentro i nostri quartieri, dividendo con noi spazi e servizi, scambiando relazioni e culture. Vengono al mare, per il mare, indipendentemente da noi, quasi senza di noi. Così l’immaginario collettivo si è costruito un idealtipo di turista quale passante occasionale, utile a riempire le nostre proprietà, assorbito senza essere gestito, pronto all’occorrenza per gonfiare la rendita stagionale. Non c’è l’impresa turistica, non c’è la sperimentazione, la selezione e il controllo di segmenti mercato. Il turista è al massimo un ospite con parziale diritto di cittadinanza, che viene da sé e per sé, puntuale al bagnasciuga, pronto all’immersione tra la massa nella grande vasca marina. E’ come se circa trecentomila individui in pochi mesi l’anno, soddisfatti i propri bisogni di sopravvivenza, venissero a raffreddare la calura in acqua. E il mare è ancora l’alibi di un’economia che non c’è, degli imprenditori assenti, di questa folla stagionale che si alfabetizza ogni anno con l’acqua; una folla indisciplinata a giocare con barchette e canotti, scomposta quando pranza o si riposa sulle panchine o nei parchi pubblici.
- - l’alibi della socializzazione forzata; E noi, ansiosi fin da ragazzi di mostrare ai nostri coetanei una superiore competenza marina e marinara, noi abbiamo finora considerato questa crescita drogata della nostra economia come una crescita naturale, perché il mare attrae naturalmente la domanda sui mercati e naturalmente supplisce alle inefficienze, naturalmente traccia i percorsi e naturalmente selezione gli utenti, dissolve naturalmente le insufficienze e naturalmente assolve le indifferenze oziose. In questo senso, dunque, il mare è l’alibi della socializzazione forzata. Per noi figli, quand’eravamo figli, c’era la scuola, ambiente di aculturazione e di prima socializzazione, e il mare. Sul mare, lungo il mare, affrontavamo le nostre esperienze, ci legavano le prime amicizie, si costruivano e si rompevano i primi amori. Il lungomare era il proscenio in cui si rappresentava l’intimità e l’ufficialità delle relazioni giovanili. In estate, il lungomare, diventava il teatro delle infinite avventure, delle occasioni probabili, delle situazioni impossibili, delle chances di autorealizzazione o di estraneazione, il successo o la sconfitta all’interno del gruppo dei pari e del sistema sociale di riferimento. L’alibi, quindi, della convivialità indotta per assenza di spazi, di luoghi di confronto e di comunicazione. Con l’alibi del mare abbiamo imparato l’attivismo ricreativo e vacanziero, senza scambio di conoscenza, senza la necessaria cultura dei luoghi. Infatti, tutte le politiche di valorizzazione del nostro patrimonio culturale utilizzano una iconografia quasi esclusivamente storica o monumentale, di natura archeologica o architettonica. Il mare non fa parte del nostro background culturale. Il mare è per noi l’immagine di una promozione turistica generica: la frivolezza del divertimento, l’accattivante frenesia dell’avventura. L’ambiente marino non ha habitat, non c’è un vero rapporto culturale con il mare come, ad esempio, quello che si legge nel racconto di pasolini ultimamente emerso. Quel mare è un altro mare, che si sente nelle strade, oltre la città, respirato non appena si scende lungo l’Appia dal Castelli Romani verso la pianura pontina, vivo nel cuore e nell’anima degli uomini.
- - l’alibi dell’ambiente marino: sul mare si sono dunque scaricate, in tutti questi anni, le nostre sensazioni ed i nostri rifiuti. D’altronde così è per le città di mare che, come dice la bella canzone, “sono i luoghi dove sfociano tutte le strade del mondo”. La città scarica nel mare i suoi rifiuti: lo facevano le comunità di pescatori senza servizi igienici negli anni ‘50[64] e lo fanno oggi i comuni dell’entroterra che portano sulle nostre spiagge i loro detriti[65]. Il degrado ambientale del mare è il nemico più grande. Il degrado marino ha due volti: l’inquinamento e la devastazione. Il primo è noto, nelle sue cause e nei suoi effetti, ma la sua soluzione è di lungo, lunghissimo periodo. Il disinquinamento del mare è il prodotto di un complessivo processo di depurazione delle nostre infrastrutture, è il risultato lento della tendenza generale alla costruzione di una città ecologica. Il secondo aspetto, quello della devastazione, un po’ tralasciato, vissuto in sordina, è forse più immediato e per questo più difficile. E’ il problema della distruzione del fondale marino e del genocidio della fauna del nostro mare; devastazione che avviene quotidianamente a causa delle varie tecniche di pesca e delle violente tecnologie di distruzione dell’habitat naturalistico.
IL PIANO SPIAGGIA
Comunque le città di mare sono tutte così: schiave del loro grande alibi. Si illudono di avere una flotta di pescherecci ed invece hanno soltanto un voluminoso commercio. Si illudono di avere un litorale attrezzato ed invece hanno vecchi chioschi, per sempre provvisori, buoni a spartirsi concessioni sulla spiaggia. Eppure è proprio dal mare, dalla sua natura, che bisogna ripartire per trasformare una perenne vocazione in una valenza turistica, cioè in una condizione permanente.
Dal mare bisogna ricominciare e dall’assetto dell’arenile. Per questo, anni fa, ci siamo tanto preoccupati affinché il piano spiaggia fosse adottato. Alla fine non è stato così. Indipendentemente, anche se non indifferentemente, dai modi e dalle forme in cui questo sarebbe accaduto, quel piano avrebbe definitivamente cancellato qualsiasi alibi. Non vi sarebbe stato più un alibi per i concessionari, in tutto questi anni costretti ad una economia di sopravvivenza, con permessi rinnovabili di stagione in stagione, sottoposti ad una osservazione mirata più ai manufatti che alle condizioni d’impresa. Non vi sarebbe stato più alibi per i turisti, privati di ogni possibilità invasoria e indotti ad una occupazione regolarizzata, ad una presenza ordinata, a comportamenti controllati e rispettosi. Non avrebbero avuto più alibi gli amministratori, costretti a dar seguito con atti concreti e coerenti alle indicazioni di riorganizzazione. Non avrebbero avuto alibi i commercianti, che finalmente sarebbero usciti dalla individualità e possono affrontare il problema definitivo della rivitalizzazione delle aree, indipendentemente dalle zone di transito.
LA RISORSA
Il mare è il nostro alibi ed anche la nostra grande, incommensurabile, risorsa. Non avremo mai alcun riscatto senza il mare. Basta leggere i pochi dati: sul litorale si concentra circa l’80% del ricettivo alberghiero, il 100% del ricettivo campeggistico, l’85% del ricettivo privato. Il mare “assorbe pressoché il totale del movimento stagionale e circa il 35% del restante movimento”[66].
3.1. fisicamente: il mare deve essere fisicamente vissuto da una città che lo interiorizzi, che lo porti dentro la sua urbanità, con la realizzazione del Porto; di un Porto che non strappi terra al mare, ma che faccia scorrere il mare dentro la nostra terra. La navigabilità interna è ormai l’unica ipotesi credibile e seria per costruire una città turistica vera. Discutere di portualità in questi anni ha significato discutere della natura della città, le sue reali ipotesi di sviluppo. Il porto non è, non può essere considerato come una protesi applicata ad un arto. Una protesi così artificiale ed artificiosa non ci fa camminare, al massimo ci aiuta a zoppicare. E d’altronde il turismo della nostra città non può fare a meno della modernizzazione nei criteri, nelle strutture e nei servizi di accesso e fruizione del mare. Quelle strutture così come sono, precarie e soffocanti, non servono più a nessuno. Da questo punto di vista vanno positivamente accolte, e se del caso sostenute, tutte le logiche di razionalizzazione, come quella della costruzione di soggetti economici unitari, in grado di svolgere con una sola mano e con una sola voce le necessarie operazioni imprenditoriali per l’adeguamento ai mercati contemporanei. Senza questi servizi di accoglienza e di fruizione non abbiamo chances di recupero; non alcuna possibilità di trasformare, nella concezione collettiva della città, l’immagine del mare, per passare dall’alibi alla risorsa. Ciò che dobbiamo oggi evitare è che l’alibi della risorsa si estenda all’alibi della funzione. Un punto deve essere chiaro: molti pensano che il turismo possa risolvere tutti i problemi della città, molti pensano che il turismo possa risollevare i nostri bilanci, ma non è così. Il turismo non viene prima, ma dopo. Il turismo ci sarà quando avremo risolto i nostri problemi, quando avremo cambiato il volto alla città. Il turismo non è la salvezza, è la scelta, non è una aspettativa, è una prospettiva. L’alibi del mare è proprio in questa credenza, in questa burla del turismo che comunque alla fine viene e che comunque alla fine sana i magri bilanci invernali. La risorsa mare invece consiste nella scelta, nella volontà, difficile, dura, ostica, di portare avanti un progetto di città, una organica ipotesi di sviluppo: lentamente, con costanza, senza operazioni di facciata, senza clamore, senza proclami eclatanti, senza fanfarate.
3.2. culturalmente: Pertanto il mare, una città di mare, non si governa con un atto. Occorrono tanti fatti quotidiani, tanto lavoro giornaliero. In questo senso bisogna interiorizzare culturalmente il mare. Le nostre città sono città aperte, approdi per ogni navigante. Devono essere pronte all’accoglienza, devono essere multirazziali e tolleranti. Devono essere efficienti ed efficaci, devono poter offrire servizi adeguati alla fluidità delle culture, devono sostenere i molteplici linguaggi e le professionalità, devono saper essere città multiformi ed accoglienti. Terracina si colloca, oggi di nuovo, dopo molti anni, al centro degli scambi della provincia. Non lasciamo questi scambi alla droga ed all’usura. Facciamo che siano scambi culturali, scambi di conoscenza, scambi ricreativi nel sistema delle relazioni internazionali. Il mare non ha patria. La maggiore città di mare della provincia di Latina può diventare oggi la città degli scambi economici, sociali e culturali. Questa è la nostra risorsa. La risorsa del nostro mare è l’infinita ricchezze delle relazioni e della comunicazione internazionale. Per ottimizzare, in questo senso, il mare, dobbiamo modernizzare tutti i servizi, dobbiamo accrescere la qualità complessiva dell’offerta. Occorre volontà, disponibilità, costanza. Per tutti gli anni ’80, fino agli inizi degli anni ’90, Terracina ha assorbito quel che poteva, quel che capitava; la città è andata avanti senza freni. E questo modo di procedere ci ha condotto alla stasi, quasi alla paralisi delle funzioni di accoglienza. Il livello di entropia del sistema economico, la temperatura del settore turistico, la tensione collettiva nella offerta di servizi di qualità, ha cominciato a ridursi drasticamente, fino a rischiare seriamente la implosione dei suoi meccanismi tenuta, che si manifesta nell’assenza generale di azioni imprenditive.
ooo/ooo
[1] Anzi, potremmo enfaticamente affermare: “il problema…”
[2] Beati i Costruttori di Pace (a cura di), PER UNA CIVILTA’ CAPACE DI FUTURO – studio dell’istituto di Wuppertal per il clima, l’ambiente e l’energia sulla riconversione ecologica della Germania, EMI Edizioni, Bologna 1996.
[3] Biscella Marco, IL TURISMO ALLA SCOPERTA DELLA “VIA”, Il Sole 24 Ore, Lunedì 20 Ottobre 1997.
[4] Secondo le stime elaborate dal WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL
[5] Non disponibile l’esatta suddivisione degli studi per tipologia
[6] Non disponibile l’esatta suddivisione degli studi per tipologia
[7] E’ il caso, ad esempio, della direttiva 97/11/Ce che estende l’elenco dei progetti, anche turistici, soggetti alla Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA): così, oggi, nell’Allegato II rientrano villaggi e porti turistici, complessi alberghieri e centri ricreativi, campeggi e impianti di risalita. In più, il Consiglio Ue sta discutendo una proposta di Direttiva sulla Strategic Environmental Assessment (SEA) che riguarda la VIA applicata non tanto alle sigole opere, a ai pioani e ai programmi, compresi quelli turistici, che sono inclusi nell’articolo 2 della bozza di proposta. Sul piano pratico, la Commissione europea (attraverso la Direttiva XI)ha affidato al Centro VIA Italia una ricerca sul campo (condotta a Vernazza sulla Riviera Ligure) per sperimentare gli studi di impatto come strumenti per “dominare” il turismo e non subirlo. Un ulteriore affinamento e perfezionamento dei progetti V.I:A. e S.E.A., arriva proprio da Vernazza e si chiama S.I.A,D. (Sistema d’Impatto Ambientale Dinamico). Si tratta di un esperimento pilota, durato due anni, che rappresenta il primo passo di un cammino lungo quello che a prima vista sembra un paradosso, ma che in realtà è una necessità: proteggere il turismo dai turisti e per i turisti. Biscella Marco, IL TURISMO ALLA SCOPERTA DELLA “VIA”, Il Sole 24 Ore, Lunedì 20 Ottobre 1997.
[8] Biscella Marco, IL TURISMO ALLA SCOPERTA DELLA “VIA”, Il Sole 24 Ore, Lunedì 20 Ottobre 1997.
[9] C’è invece una certa debolezza italiana in materia di legislazione. A differenza di altri paesi Europei, dove la valutazione di impatto ambientale applicata al turismo è regolamentata da leggi nazionali, in Italia dopo 12 anni non è stata ancora recepita la Direttiva 337/85/CEE. Le Regioni, in coerenza con il trasferimento delle competenze a partire dalla Legge Quadro sul turismo, 17/5/83 n.217, si sono viste attribuite anche le competenze di valutazione dell’impatto ambientale dei progetti turistici, con il DPR 12 Aprile 1996. Un Decreto, come è stato detto giocando sulle parole, che ha comunque avuto un “impatto” pesante su Regioni a statuto speciale e Province Autonome (che già disponevano di una legislazione ad hoc e che avevano provveduto a varare alcuni studi d’impatto legati al turismo), costringendole a una difficile rivisitazione normativa.
[10]Biscella Marco, IL TURISMO ALLA SCOPERTA DELLA “VIA”, Il Sole 24 Ore, Lunedì 20 Ottobre 1997.
[11][11] Faggiani Giuliano, costi crescenti per l’incoming e sviluppo del mercato interno, in Azienda Turismo, Anno 6 - n. 1, gennaio/febbraio 1995
[12] Faggiani, cit., 1.
[13] Anche S.I.A.D. è ancora in fase sperimentale
[14] Ortega Y Gassett, LA RIBELLIONE DELLE MASSE, in OPERE, UTET, Torino 1979, pag. 812.
[15] “chi esercita il diritto di proprietà sulla risorsa naturale capace di attrarre i turisti non è specificamente interessato a sostenere l’alta qualità nel tempo, a meno che così facendo non ottenga un alto rendimenmto economico” Pigliaru F., ECONOMIA E TURISMO SOSTENIBILE: ALCUNE NOTE, in Moro B. (a cura di), CAPITALE NATURALE E AMBIENTE, Franco Angeli, Milano 1997, pag.217.
[16] Bersani Ercole,
[17] Pigliaru F., ECONOMIA E TURISMO SOSTENIBILE: ALCUNE NOTE, in Moro B. (a cura di), CAPITALE NATURALE E AMBIENTE, Franco Angeli, Milano 1997, pag.217.
[18] Pigliaru F., ECONOMIA E TURISMO SOSTENIBILE: ALCUNE NOTE, in Moro B. (a cura di), CAPITALE NATURALE E AMBIENTE, Franco Angeli, Milano 1997, pag.217; Fisher A.C., RESOURCE AND ENVIRONMENTAL ECONOMICS, Cambridge University Press, Cambridge 1981; Lucas R., ON THE MECHANICS OF ECONOMIC DEVELOPMENT, Journal of Monetary Economics, 22, 1988; Lanza A., Pigliaru F., THE TOURIST SECTOR IN THE OPEN ECONOMY, Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali, jan.1, Erratum, March3, 1995.
[19] Pigliaru F., ECONOMIA E TURISMO SOSTENIBILE: ALCUNE NOTE, in Moro B. (a cura di), CAPITALE NATURALE E AMBIENTE, Franco Angeli, Milano 1997, pag.217.
[20] Lanza A., IS SPECIALIZATION IN TOURISM HARMFUL TO ECONOMIC GROWTH?, Nota di lavoro Fondazione ENI Enrico Mattei, 49/95, 1995; Lanza A., Urga G., TOURISM SPECIALIZATION ANDE ECONOIC GROWTH: A CROSS COUNTRYCOMPARISOM USING MULTIVARIATE COINTEGRATION, London Business School Discussion Paper, 29-05,1995.
[21] Schumpeter J., SOCIALISMO, CAPITALISMO,DEMOCRAZIA, Etas Libri
[22] Regge Tullio, Maurizio Pallante, SCIENZA E AMBIENTE: UN DIALOGO, Bollati Boringhieri, Torino 1996, pag15.
[23] Si potrebbe anche affermare che questo, della qualità dello sviluppo, è il tema del socialismo che verrà. Ma appunto non è questa la sede.
[24] Istituto di Wuppertal, STUDIO PER IL CLIMA, L’AMBIENTE E L’ENERGIA SULLA RICONVERSIONE ECOLOGICA DELLA GERMANIA, trad. it. Beati i Costruttori di Pace (a cura di), E.M.I., Bologna 1996.
[25]Schmidt di Friedberg Paolo, MESSO A PUNTO UN SISTEMA PER CONIUGARE LE ESIGENZE DI CHI PARTE E DI CHI RESTA, Il Sole 24 Ore, Lunedì 20 Ottobre 1997.
[26] Musu I., LO SVILUPPO SOSTENIBILE: PROBLEMI, POLITICHE E ACCORDI INTERNAZIONALI DI SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE, in Moro Beniamino (a cura di) CAPITALE NATURALE E AMBIENTE, Franco Angeli, Milano 1997, pag.30.
[27] nell’ambito della Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite presieduta dalla Signora Brundtland nel 1987.
[28] Musu I., LO SVILUPPO SOSTENIBILE: PROBLEMI, POLITICHE E ACCORDI INTERNAZIONALI DI SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE, in Moro Beniamino (a cura di) CAPITALE NATURALE E AMBIENTE, Franco Angeli, Milano 1997, pag.31.
[29] Musu I., LO SVILUPPO SOSTENIBILE: PROBLEMI, POLITICHE E ACCORDI INTERNAZIONALI DI SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE, in Moro Beniamino (a cura di) CAPITALE NATURALE E AMBIENTE, Franco Angeli, Milano 1997, pag.32.
[30] Musu I., LO SVILUPPO SOSTENIBILE: PROBLEMI, POLITICHE E ACCORDI INTERNAZIONALI DI SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE, in Moro Beniamino (a cura di) CAPITALE NATURALE E AMBIENTE, Franco Angeli, Milano 1997, pag.33.
[32] o almeno così come lo voleva il suo principale autore: Bronfenbrenner U., ECOLOGIA DELLO SVILUPPO UMANO, trad. it., Il Mulino, Bologna 1986.
[33] Angyal A., UNA LOGICA DEI SISTEMI, in Emery F.E. (a cura di) , LA TEORIA DEI SISTEMI, Franco Angeli, Milano, 1985, “Il sistema è una realtà dimensionale, ossia è la distribuzione degli elementi che lo compongono entro un parametro dimensionale… Dal punto di vista olistico, i componenti di un sistema possono essere collegati sufficientemente tra di loro soltanto facendo riferimento al tutto. Le parti che costituiscono un sistema non debbono essere considerate separatamente, ma facendo riferimento a un fattore superiore e più generale, ossia al sistema nel quale e per mezzo del quale esse risultano collegate tra di loro”; pag. 24-26.
[34] Miller J. G., LA TEORIA GENERALE DEI SISTEMI VIVENTI, Franco Angeli, Milano 1986: “Un sistema concreto può muoversi in ogni direzione delle dimensioni spaziali, ma nella dimensione temporale solo in avanti mai all’indietro. La unidirezionalità irreversibile del tempo è connessa alla seconda legge della termodinamica: un sistema tende ad aumentare la sua entropia nel tempo.”; pag. 25.
[35] Ashby W.R., LA CAPACITA’ DI ADATTAMENTO DEI SISTEMI MULTISTABILI, in Emery F.E. (a cura di) , LA TEORIA DEI SISTEMI, Franco Angeli, Milano, 1985.
[36] Lotman J.M. , LA SEMIOSFERA, L’ASIMMETRIA E IL DIALOGO NELLE STRUTTURE PESANTI, Marsilio, Venezia, 1985 “Alla base di tutti i processi comunicativi c’è un principio invariante che li rende simili tra loro. Questo principio si fonda da un lato sulla combinazione simmetria-asimmetria, dall’altro su un avvicendamento periodico di alti e bassi nel corso di tutti i processi vitali in ogni loro forma”; ed anche:”la coppia oppositiva simmetria-asimmetria può essere considerata la scomposizione di unità sul piano della simmetria, in seguito alla quale si formano strutture speculari, che determinano a loro volta la successiva crescita della varietà e della specificazione funzionale”, pag. 69.
[37] anche perché le future generazioni non votano oggi.
[38] Darin Dario, LA TEORIA ECOLOGICA DELLO SVILUPPO, in Di Blasio Paola (a cura di), CONTESTI RELAZIONALI E PROCESSI DI SVILUPPO, Raffaello Cortina Editore, 1995, pag.44.
[39] Coltrinari Laura, PROGETTARE LO SVILUPPO SOSTENIBILE, Inserto Ambiente
[40] De Angelis Valentina, LA LOGICA DELLA COMPLESSITA’- Introduzione alle teorie dei sistemi, B. Mondadori, Milano 1996, pag26.
[41] Bertalanffy (von) L. TEORIA GENERALE DEI SISTEMI, A. Mondadori, Milano 1983, pag.120.
[42] De Angelis Valentina, LA LOGICA DELLA COMPLESSITA’- Introduzione alle teorie dei sistemi, B. Mondadori, Milano 1996, pag27.
[43] Si potrebbe sostenere che l’intera epistemologia di T.Khun è un processo di differenziazione funzionale, in cui il paradigma rappresenta un sistema e l’anomalia l’unica porta di accesso che permette una relazione con l’esterno (o eventualmente con il paradigma alternativo), ma questo è un altro problema,
[44] De Angelis Valentina, LA LOGICA DELLA COMPLESSITA’- Introduzione alle teorie dei sistemi, B. Mondadori, Milano 1996, pag27.
[45] Miller individua alcuni eventi fondamentali nell’evoluzione dei sistemi, cioè nel processo di differenziazione funzionale:1- la mutazione (cambiamento irreversibile di informazioni); 2- l’isolamento (forma di difesa e di dipendenza dalla totalità); 3- la diffusione (contatto tra sistemi diversi); 4- la mobilità del limite (quando un sistema diventa troppo grande, si riorganizza e stabilisce nuovi confini interni). Miller J. G.,LA TEORIA GENERALE DEI SISTEMI VIVENTI, Franco Angeli, Milano 1986.
[46] Che è appunto la scienza dei religiosi che studiano la loro religione
[47] De Angelis Valentina, LA LOGICA DELLA COMPLESSITA’- Introduzione alle teorie dei sistemi, B. Mondadori, Milano 1996, pag28.
[51] Emery F.E. (a cura di) , LA TEORIA DEI SISTEMI, Franco Angeli, Milano, 1985.
[52] De Angelis V., LA LOGICA DELLA COMPLESSITA’, Mondadori, Milano 1996; o anche von Bertalanffy L., TEORIA GENERALE DEI SISTEMI, Mondadori, milano 1983: “Il base al secondo principio della termodinamica, la tendenza generale degli eventi della natura fisica è rivolta verso stati di massimo disordine e di eliminazione e di appiattimento delle differenze…Al contrario il mondo vivente mostra una transizione verso ordini di carattere più elevato, verso l’eterogeneità e l’organizzazione”; pag.77.
[53] Ashby W.R., LA CAPACITA’ DI ADATTAMENTO DEI SISTEMI MULTISTABILI, in Emery F.E. (a cura di) , LA TEORIA DEI SISTEMI, Franco Angeli, Milano, 1985.
[54] von Bertalanffy L., LA TEORIA GENERALE DEI SISTEMI APERTI IN FISICA E IN BIOLOGIA, , in Emery F.E. (a cura di) , LA TEORIA DEI SISTEMI, Franco Angeli, Milano, 1985, pag.85.
[55] De Angelis V., LA LOGICA DELLA COMPLESSITA’, Mondadori, Milano 1996.
[56] De Angelis V., LA LOGICA DELLA COMPLESSITA’, Mondadori, Milano 1996.
[57] Aspetto teorico questo che, in ogni caso, richiede naturalmente una più anaitica trattazione.
[58] Analizzo gli estremi per rendere evidenti i concetti.
[59] Letteralmente senza freni, senza alcun controllo.
[60] In base alla Teoria delle Catastrofi di Thorn
[61] come dice Sartori della differenza tra la matematica e le scienze sociali: che in matematica 44+1 = 45, nelle scienze sociali no, perché con 44 di febbre siamo ancora vivi, con 45 siamo morti. E c’è una bella differenza! Vedi: Sartori G., LA POLITICA logica e metodo dell’azione sociale, Il Mulino, Bologna 19
[62] ai tempi della palude la città si spopolava in estate, a causa della malaria e dei fumi dell’acqua stagnante, e si ripopolava in inverno quando i pastori scendevano per il pascolo del loro bestiame. Da quando il turismo ha assunto il sopravvento come principale attività economica cittadina, assistiamo allo stesso fenomeno in opposte stagioni. Ci ripopoliamo in estate e ci spopoliamo in inverno.
[63] La complessità è la situazione risultante di un processo, la complicazione è il prodotto di un disordine, della confusione, cioè dell’assenza di un processo.
[64] come inequivocabilmente attestato dalla ricerca sui pescatori terracinesi del gruppo olivetti
[65] così come denunciato con grande responsabilità dalla CONFESERCENTI e dal WWF.
[66] Sottoriva PierGiacomo, quando le risorse vengono ignorate, Latina Turismo, Anno XXVI, n.6, 15 giugno 1994.


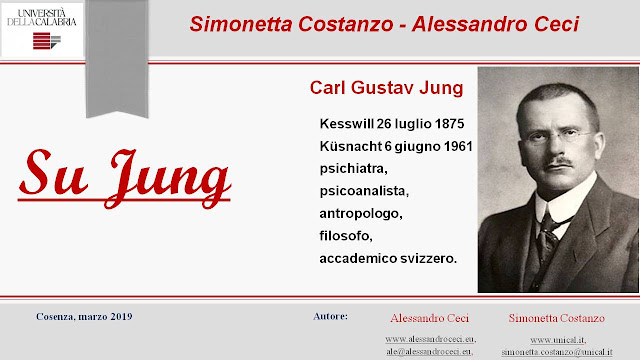
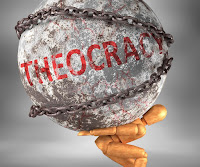

Commenti
Posta un commento