INTELLIGENCE: L'OSSESSIONE DI NASH
Venti anni, anzi, ventuno.
Sono passati ventuno anni da quando David Steele[1] ci ha insegnato che l’intelligence moderno non è più fatto di spie, spioni ed emuli di Rambo (almeno non più principalmente), ma da scienziati ed analisti. E questo perché sono ormai più di venti anni che abbiamo lasciato la società industriale e siamo entrati nella società della comunicazione. La quarta mutazione sociale ha fatto in modo che le informazioni che arrivano all’intelligence, provengono quasi esclusivamente da fonti aperte.
Questa situazione non significa, però, che sia più semplice reperirle. Poi bisogna saperle leggere. E non è per niente facile.
Riporto il testo.
“Claude Shannon[3] è l’ingegnere che ha espresso matematicamente la quantità di informazione possibile tra due poli. Shannon è riuscito a misurare in forma metrica il quantum informativo e ha denominato l’unità di misura minima in binary digit: il mitico bit. Se l’esigenza di assumere informazioni è il prodotto della incertezza dei soggetti, il bit è il contenitore di un certo grado di certezza per un determinato periodo di tempo (bit per secondo). Ma l’illusione di Shannon di una informazione entropica, cioè capace di ridurre il disordine in una organizzazione complessa, è stata definitivamente e dolorosamente squarciata. Infatti, la sua teoria «non dice alcunché sul contenuto o sul significato simbolico dell’informazione e tratta esattamente allo stesso modo parole cariche di significato e stringhe di caratteri senza alcun senso»[4].
So bene che, sulla base della «estrema semplicità del bit»[5] sono stati oggi costruiti sofisticati sistemi complessi, al confine della intelligenza artificiale; ma non è ancora disponibile nella letteratura scientifica un modello interpretativo in grado di trasformare l’infinita quantità di informazioni, a cui può attingere l’investigazione, nella conoscenza necessaria per la interpretazione degli scenari che caratterizza l’Intelligence. Credo, anzi, che sia impossibile definire questo modello teorico per il fatto che nella informazione, anche considerata come processo di elaborazione e diffusione disteso nel tempo secondo le quattro fasi di Steele, la conoscenza non c’è. Non fosse per il fatto che, quali siano le informazioni strategiche utili catalogate in un infinito Data Base, lo si può sapere soltanto a posteriori, dopo che l’evento si è verificato. Nel mondo contemporaneo l’informazione è permanente e applicata alla politica in modo continuativo. È l’evento a legarla a sé. Soltanto dopo possiamo decodificare i codici e determinare una stratificazione delle notizie più consona all’occasione”[6].
E continuavo constatando “che i nostri sistemi di sicurezza, dannati dall’inesauribile volume di informazioni di cui dispongono, non ne hanno ancora compreso il valore. Abbiamo una immensità di risorse per prendere criminali, terroristi o mafiosi, che ci capitano o che gli eventi che ce li indicano come protagonisti. Abbiamo tanti satelliti e strumentazioni ad alta precisione, ma per catturare un capo di Stato nemico nascosto in una buca si dimostra più efficace la vecchia tecnica della taglia utilizzata dagli sceriffi. Tra l’altro la taglia rappresenta il tipico caso di scambio entro relazione comunicativa utilitaristica. Le banche dati aggiornate in tempo reale non avevano previsto il più ovvio dei nascondigli. Figurarsi anticipare un attentato enorme e drammatico come quello di New York. Riusciamo ad individuare più facilmente il beffardo, in quanto rottura di una frequenza, di quanto possiamo percepire una catastrofe che viaggia sui vettori della normalità”[7].
Nella società della comunicazione l’intelligence è sottoposta allo stressante ed inutile tentativo di raccogliere informazioni occulte (che ci sono ma non si vedono). Un surplus eccessivo che tende a creare “scenari di verità”[1] che non sono quasi mai corrispondenti alla realtà. Una scissione simbiotica, come l’ho chiamata, tra realtà e verità.
È successo a me, precisamente venti anni fa.
Infatti, venti anni fa mi capitò, in controtendenza con l’intelligence internazionale, di prevedere l’attentato alle Twin Towers un anno prima. Era il maggio del 2000. Il Ce.A.S., il mio centro di ricerca, organizzò un convegno internazionale intitolato “Terra, Terrore, Terrorismo”. Ci fu qualche polemica e noi soffiammo sul fuoco e nel febbraio 2001 organizzammo un nuovo seminario dal titolo “Intelligence nel XXI secolo”. Io continuai a sostenere, con coraggio e testardaggine, l’ipotesi sulla minaccia terroristica e fui puntualmente aggredito e trattato con la solita sufficienza. Quasi tutti si sentivano rassicurati dal fatto che gli americani avevano speso 30 milioni di dollari per realizzare un rapporto, denominato “Megatrend 2015”, in cui si sosteneva che i terroristi non c’erano più, ridotti a commessi viaggiatori di armi nucleari tattiche ex sovietiche, decostruite per essere rese trasportabili verso la vera nuova minaccia rappresentata dagli Stati Canaglia.
L’11 settembre 2001, mentre insegnavo a un Master in Peace Keeping all’università Roma 3, fui interrotto e un video acerrimo mi mostrò il secondo aereo che entrava nella seconda torre.
Negli anni turbolenti che seguirono mi sono spesso chiesto come mai, tanti soldi spesi dall’intelligence americano, non avevano capito e visto ciò che io avevo visto e capito chiaramente nella mia stanza di Latina. Per me era evidente ciò che poteva accadere soltanto leggendo libri, giornali e servizi giornalistici in televisione. Appunto, fonti aperte.
Qualche anno dopo, viaggiando su un aereo verso il Cile per un ciclo di conferenze in Sud America e una lezione ai cadetti della polizia di quel paese, ho capito che loro non avevano sbagliato affatto.
Sbagliavo io.
Loro avevano speso tutti quei soldi per costruire una verità che orientasse la realtà, che addirittura producesse una realtà nuova.
Noi eravamo abituati a un mondo diverso, un mondo in cui la verità fosse necessaria a disvelare la realtà. Il mondo però era cambiato. La verità legittimata, cioè epistemologicamente giustificata, è diventata utile a produrre o addirittura a generare la realtà desiderata. Gli americani investirono 30 milioni di dollari nel rapporto Megatrend 2015 per orientare molti, moltissimi altri milioni di dollari verso la produzione dello “Scudo Spaziale”. Si trattava di una Iniziativa di Difesa Strategica per proteggersi, non più dai terroristi, ma dagli “Stati Canaglia”. La realtà, tuttavia, ha drammaticamente squarciati il velo confuso di verità inventate.
Ultimamente è clamorosa la previsione sulla pandemia da coronavirus di David Quammen con il suo libro “Spillover. L’evoluzione delle pandemie”[8]. Non credo che sia accaduto solo a lui. Chissà quante previsioni sono state ignorate e sono rimaste nascoste sotto l’enorme volume di informazioni inutili e insignificanti. Evidentemente l’intelligence del mondo, tra le tante cose, era notevolmente cambiato. Non c’erano più spie, spioni ed emuli di Rambo. L’intelligence della società della comunicazione era diventato un’altra cosa, sempre più fatto di analisti e scienziati.
Era l’ossessione di Nash, come ben rappresentato nel film “Beautiful Mind” di Ron Howard. L’ossessione di Nash era quella di connettere cognitivamente le informazioni da fonti aperte, per individuare verità che siano il più possibile simbiotiche con la realtà.
L’intelligence è la nuova epistemologia: un metodo logico (a varie dimensioni logiche) per trovare connessioni, selezionando informazioni e interpretando dati o news, individuando trend totalmente ignoti perché spesso appositamente soffocati dal surplus informativo, dalla sindrome di Shannon.
E questo nuovo intelligence può essere, certo, molto minaccioso. Ma, come ho più volte già scritto, può essere anche indispensabile alla democrazia nella società della comunicazione.
“Il fascino paradossale della democrazia in tutte le sue versioni storiche è che gli elementi del suo sviluppo sono, al tempo stesso, gli elementi della sua crisi. Le sue sicurezze sono anche i suoi rischi. Le sue difese sono, al tempo stesso, le sue minacce.
Il paradosso, diceva Gino Germani, sta nel fatto che «la società moderna, che ha offerto il modello necessario per lo sviluppo di forme democratiche e la possibilità di spingerle alle loro ultime conseguenze logiche, presenta anche, nella sua particolare forma di integrazione, tensioni tali da poter mettere in crisi le basi della democrazia stessa»[9]. Contraddizioni dello sviluppo, disorganizzazione dei sistemi evolutivi, caos nella complessità che produce tensioni. Tensioni che noi registriamo con il nome di entropia. Le forme, gli istituti e le istituzioni, della democrazia reclamano riorganizzazione che, in una prima fase, appare come disorganizzazione, cioè caos nella complessità del sistema sociale. Questi impatti si esprimono come tensioni sociali che noi registriamo come entropia del sistema. Per attenuare gli impatti e ridurre l’entropia prodotta dalla innovazione il sistema non può fermarsi. Non ha altra possibilità che procedere per «esplorare nuove forme democratiche che risolvano o diano una risposta alle attuali contraddizioni strutturali»[10. Sennonché il procedere, l’esplorare e poi lo sperimentare produce nuovi impatti, nuove tensioni, altra entropia. In questo senso i sistemi sociali sono sempre e soltanto, per usare la terminologia quantistica di Nicolis e Prigogine, sistemi dissipativi, cioè «i sistemi che danno luogo a processi irreversibili»[11. Sono sistemi che, a causa della elevata entropia, sembrano perdere costantemente energia. In un primo momento, ci spiegano i due scienziati, «l’irreversibilità e la dissipazione erano viste, in fisica, come degradazione» [12. Soltanto successivamente con lo studio dei processi irreversibili nella evoluzione biologica e poi, meglio, nella evoluzione sociale e, definitivamente, dalla cibernetica alle neuroscienze si è compreso che le caratteristiche dei sistemi dissipativi (irreversibilità e dissipazione) erano associati «a un aumento di complessità»[13”[14.
È quel che ancora facciamo, nella speranza che l’intelligence moderno, con una epistemologia interpretativa vera e a diverse dimensioni logiche, aiuti a sviluppare l’intelligenza democratica della società della comunicazione.
ooo/ooo
[2] CECI Alessandro, Intelligence e Democrazia, Rubettino, Soveria Mannelli 2006
[3] SHANNON C. e WEAVER W., La teoria matematica della comunicazione, Etas Kompass, Milano 1971
[4] MARTINOTTI G., Informazione e sapere, Anabasi, Milano 1992
[5] SHANNON C. e WEAVER W., La teoria matematica della comunicazione, Etas Kompass, Milano 1971
[6] CECI A. cit. 2006
[7-] CECI A. cit. 2006
[8] CECI Alessandro,Terra, Terrore, Terrorismo, Ibiskos, Empoli 2010
[9 QUAMMEN Daivid, Spillover. L’evoluzione delle pandemie, Adeplhi, Milano 2012
[10 GERMANI G., Autoritarismo e democrazia nella società moderna, in SCARTEZZINI R., GERMANI L., GITTI R. (a cura di), I limiti della democrazia, Liguori, Napoli 1990
[11 GERMANI G., Autoritarismo e democrazia nella società moderna, in SCARTEZZINI R., GERMANI L., GITTI R. (a cura di), I limiti della democrazia, Liguori, Napoli 1990
[112 NICOLIS G., PRIGOGINE I., La complessità, Einaudi, Torino 1991
[13 NICOLIS G., PRIGOGINE I., La complessità, Einaudi, Torino 1991
[14 NICOLIS G., PRIGOGINE I., La complessità, Einaudi, Torino 1991
[15 CECI A., cit. 2006
[7-] CECI A. cit. 2006
[8] CECI Alessandro,Terra, Terrore, Terrorismo, Ibiskos, Empoli 2010
[9 QUAMMEN Daivid, Spillover. L’evoluzione delle pandemie, Adeplhi, Milano 2012
[10 GERMANI G., Autoritarismo e democrazia nella società moderna, in SCARTEZZINI R., GERMANI L., GITTI R. (a cura di), I limiti della democrazia, Liguori, Napoli 1990
[11 GERMANI G., Autoritarismo e democrazia nella società moderna, in SCARTEZZINI R., GERMANI L., GITTI R. (a cura di), I limiti della democrazia, Liguori, Napoli 1990
[112 NICOLIS G., PRIGOGINE I., La complessità, Einaudi, Torino 1991
[13 NICOLIS G., PRIGOGINE I., La complessità, Einaudi, Torino 1991
[14 NICOLIS G., PRIGOGINE I., La complessità, Einaudi, Torino 1991
[15 CECI A., cit. 2006





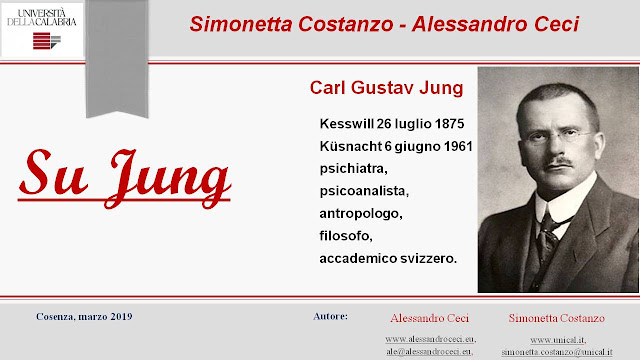
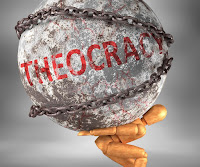

Commenti
Posta un commento