COMPLESSITA': LA CORNICE PARADIGMATICA
L’habitat epistemologico delle scienze sociali
Appunti che erano già nel 1987
marzoduemiladiciannove
“gli uomini sono agiti da idee di generalità, e
tali idee generali sono presenti come fossero
persone viventi”
Alexis de Tocqueville
Uno dei paradossi più emblematici della complessità è che, per coglierla, bisogna spezzare la cornice paradigmatica con cui, invece, la riduciamo e la interpretiamo. In altri termini, la complessità che percepiamo non è per definizione complessa: è, per definizione, una riduzione della complessità. La complessità, cioè, può essere concepita, ma non può mai essere integralmente percepita.
Questo accade perché ciò che noi vediamo non è ciò in cui viviamo, è soltanto una nostra prospettiva, una nostra verità che non è mai corrispondente alla realtà. Il mondo in cui vive un’ape, ad esempio, o il nostro cane di casa affezionato, o anche quello in cui il nostro gatto scorrazza, o la mucca che rumina in campagna, è totalmente diverso dal nostro, fatto di immagini diverse e di colori diversi. L’occhio di un’ape, ad esempio, vede un oggetto scomposto in 5.000 frammenti o punti che ne deformano l’immagine. I cani vedono un mondo sfocato, sbiadito, con pochi colori (bianco, nero, blu, giallo forte) e tutti gli altri (il rosso, l'arancione, il giallo chiaro e le varie gradazioni del verde) li confonde. Anche i gatti hanno, nella zona centrale della retina, meno cellule specializzate alla percezione dei colori dell’uomo (detti coni) e quindi vedono meglio il blu, il giallo e il violetto e peggio, molto peggio, il rosso, l’arancione o il marrone. Le mucche, infine, temono l’uomo perché lo vedono molto più grande di loro. Figurarsi quanti altri esseri viventi differenziati vedono uno stesso mondo in modo totalmente differenziato. Ciascuno è chiuso nella sua verità, ma tutti fanno parte di una comune realtà. Li possiamo concepire, anche se non li possiamo percepire.
Viceversa, per cogliere il più possibile la complessità dell’ambiente in cui viviamo dobbiamo cambiare quella prospettiva, uscire dalla gestalt visiva a cui la nostra cultura, la nostra fede paradigmatica c’impone. La complessità resta naturalmente molto più ampia di quanto noi possiamo vedere da ogni punto di osservazione. Einstein lo aveva perfettamente capito, e lo dichiarò quando concordò con Popper che “una teoria non possa essere ottenuta dai risultati dell’osservazione, ma che essa possa soltanto essere inventata”[2].
Naturalmente, per quanto possiamo estendere il nostro punto di osservazione, la complessità della realtà è molto di più, sempre, di quanto noi riusciamo empiricamente a vedere che le nostre verità ridefinite, con i nostri paradigmi riformulati. Possiamo concepirla meglio, la complessità, cambiando ottica, allargando l’angolazione della visuale a cui siamo normalmente abituati. È chiaro che più estendiamo, come avrebbe detto Gadamer, i nostri orizzonti cognitivi, più superiamo gli angusti limiti della prospettiva e maggiormente possiamo concepire o addirittura inventare migliori dimensioni della complessità. Se concepiamo nuove dimensioni della complessità fenomenologica dell’esistenza, anche senza percepirle, anche se le inventiamo, possiamo tuttavia formularle epistemologicamente con le teorie. Non è una cosa nuova. È la teoretica aristotelica con cui soltanto possiamo comprendere parti e partizioni della enorme vita che ci accoglie.
Di nuovo però c’è la consapevolezza che, senza spezzare le rigide cornici disciplinari su cui ancora purtroppo è costruita la nostra intera istruzione, senza superare i confini paradigmatici, restiamo chiusi nelle strutture rassicuranti e semplificatrici della nostra identità culturale, tradizionalmente indotta; restiamo imprigionati così in linguaggi locali o localizzati, dialetti ordinari o un gergo eccessivamente specializzato, comunque esclusivi ed escludenti, richiusi dentro il casualismo ontologico (cioè la vecchia idea che ci sia una causa per ogni fenomeno oggettivo) dell’epistemologia empirica.
Per farci bene comprendere quanto il mito della cornice paradigmatica riduca e, in qualche modo, semplifichi la complessità del reale o anche soltanto quella dei nostri mondi vitali, Karl Popper ci ha proposto un exemplum, cioè una di quelle storie che, come le parabole, spiegano più di mille libri.
La storia è, a suo modo, macraba. Già narrata da Erotodo, racconta di re Dario I che, un giorno “volle dare una lezione ai Greci residenti nel proprio regno, i cui usi imponevano loro di cremare i defunti”[3].
Secondo Erodoto, il Re “convocò gli Elleni che si trovavano nel suo regno e chiese loro a qual prezzo erano disposti a mangiare i cadaveri dei loro genitori, e quelli risposero che non lo avrebbero fatto a nessun costo. Dopo di che, Dario chiamò gli Indi detti Collati, che mangiavano i loro genitori, e chiese loro, alla presenza degli Elleni che capivano quanto veniva detto a mezzo di un interprete, a qual prezzo avrebbero accettato di bruciare i genitori morti e quelli, alzando grandi grida di protesta, lo pregarono di non parlare così.”[4]
Pertanto, sia i Greci che i Collati, per quanto sconvolti dalla indecente offerta di Dario I, uscirono da quel confronto con una cognizione della complessità del mondo più ampia di quanto non fosse quella a cui la propria identità culturale li aveva abituati, quella in cui la propria cornice li aveva rinchiusi, imprigionati. Proprio rompendo quella cornice invece estesero la propria percezione del mondo ed, entrambi, ebbero una diversa percezione di sé. Superando il limite della gestalt visiva tradizionale, empirica, indotta dalla propria identità culturale, gli Elleni concettualizzarono la possibilità di esistenza di stili di vita diversa e altrettanto fecero gli Indi. Le informazioni sulla diversità e sulla complessità dell’esistenza, anche se in modo traumatico e sotto stress, erano comunque passate. Si dice: la rottura delle cornici paradigmatiche delle verità incrementa il valore informativo della realtà.
Accade ogni giorno anche a noi quando ci riconosciamo nell’altro.
La diversità è ricchezza.
Di che cosa avete paura?
[1] STOICHITA Victor, L'invenzione del quadro. Arte, artefici e artifici nella pittura europea, il Saggiatore, Milano 1998, p.41.
[2] In POPPER R. Karl, La ricerca non ha fine. Autobiografia intellettuale, Armando Editore, Roma 1986
[3] POPPER R. Karl, Il mito della cornice, in PERA M. e PITT J. (a cura di), I modi del progresso, Il saggiatore, Milano 1985
[4] EROTODO, III, 38, trad. Giuseppe Metri,De Agostini, Novara 1962


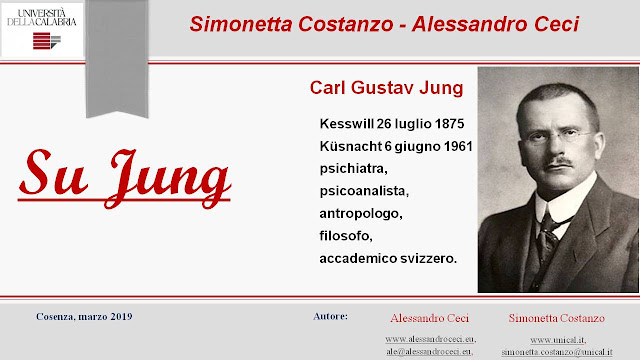
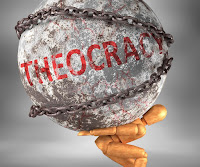

Commenti
Posta un commento