COMPLESSITA': IL SENSO POLITICAMENTE FUNZIONALE
LE SAGOME di Salvator Dalì
Ridotta per essere conosciuta.
Conosciuta per essere ridotta.
L’altro aspetto del paradosso è che la compessità non può essere compresa e interpretata, quindi analizzata e rappresentata, senza una sua inevitabile riduzione. Il progresso delle scienze sociali passa per la convinzione che “la complessità del mondo – come scriveva Luhmann – possa essere compresa solo se si riesce anche a ridurla. Solo questa legge le da la possibilità di individuare le condizioni e le prospettive di un illuminismo effettivo.”[1]
Uno dei modi e dei metodi di riduzione della complessità è il senso.
In quanto esperienza empirica e soggettiva, il senso precede la formazione del linguaggio; definendo il panorama della percezione sensitiva dei soggetti, definisce e riduce la complessità del mondo con un’attività pre-razionale.
Anche inteso come significato, il senso è un criterio di riduzione della complessità. Senso e significato è l’ethos dei sistemi e dei network, la diffusa cultura degli ambienti, il pathos interdisciplinare della scienza. Indirizzando inconsciamente il comportamento selettivo degli individui il senso limita la percezione delle possibili alternative a quelle che esclusivamente hanno un significato, o, per meglio dire, che appaiono insignificanti.
Nell’accezione di valore, il senso ripristina la comunanza degli atteggiamenti tra pari nel gruppo di riferimento e di socializzazione forzata. Per mezzo della mano invisibile del conformismo associativo, il senso-valore etero dirige l’individuo, lo governa e lo conduce all’azione sistemica. È questo un altro modo per ridurre la complessità.
Mai come in questo momento si capisce come, la riduzione della complessità sociale tramite le percezioni sensitive (e sensoriali) ha una fondamentale funzione politica nella società della comunicazione. È evidente a tutti noi che emozioni ed emotività indirizzano il processo decisionale ed elettorale nella politica dentro i mass media.
Tuttavia fin dal 1950, in America, David Riesman[2] (e prima ancora Alexis de Tocqueville) si chiese se fosse o meno il caso di considerare i mezzi di comunicazioni politica come elusivi della razionalità e della ragionevolezza politica. E si preoccupava, Rieseman, che il senso riducesse talmente la complessità da volgarizzarla, defraudarla addirittura dalla percezione della realtà. Verità banali da essere insignificanti ed incomprensibili, come accade per la moneta, secondo la nota legge di legge di Gresham[3] secondo cui la moneta di peggior qualità tende a rovinare la migliore e a restare prevalentemente in circolazione. Il senso dominante nei mezzi di comunicazione di massa tende a diffondere le idee peggiori che restano prevalentemente in circolazione e riducono talmente la complessità del reale da volgarizzarla definitivamente.
Riesman si domandava se i comuni mezzi di comunicazione, come affermavano alcuni critici contemporanei, accrescessero l’apatia politica, e incoraggiassero il pubblico a disinteressarsi a questa e ad altre realtà della vita, sostituendovi quella più piacevole degli spettacoli popolari. Reisman ripeteva che Washington, il simbolo della politica globale, non poteva assolutamente competere con Hollywood o Broadway, il luogo del divertissements che, una volta che viene proiettato sullo schermo della comunicazione, omologa la cognizione e diventa il nuovo luogo politico per antonomasia. Ciò non significa che i mass media non siano attenti alla politica. Vuol dire che la politica, troppo attenta agli strumenti del comunicare, si piega alla dimensione esclusivamente emozionale, al senso o, meglio, al sentiment, e involgarisce il contenuto della sua proposta e della sua interlocuzione.
Il tema prevalente di Riesman era che i mass media assumono de facto una funzione di guida sugli atteggiamenti degli elettori e sui comportamenti dei cittadini, addirittura del proprio piano di vita e della propria gerarchia di valori. In quest’ottica, vista la diffusione della comunicazione moderna, la decisione politica non viene presa sulla base dei contenuti espressi, quanto piuttosto sullo spazio e sul tempo che i mezzi di massa dedicano ai protagonisti. Ciò è possibile soltanto se le strategie politiche e la complessiva comunicazione controllata riesce a mantenere, con una produzione di news mistificate standardizzata, un pubblico indifferenziato e potenzialmente illimitato[4]. Utenti. Semplicemente e soltanto utenti senza segmentazione[5].
Si può frenare questo processo?
In genere si teme, ingiustamente, internet.
Internet è lo spauracchio mistificatorio delle TV generaliste. Resta la migliore rete disponibile, quella tecnologicamente più affidabile, la più frequentata, con il maggior numero di scambi comunicativi al giorno. Quando uno strumento o una tecnologia è migliore la si riconosce subito. Uno strumento o una tecnologia che funziona cresce in modo inintenzionale. Di regola tutti i nuovi ambienti comunicativi “sorgono per via irriflessa, vale a dire col semplice manifestarsi di interessi individuali, che da sé, cioè senza una precisa intenzione, conduce ad un risultato utile all’interesse generale”. Evolvono in questo modo anche le città che nascono dalla occupazione di un territorio da parte di agricoltori, in cui si stanzia il lavoro artigianale, e poi via via il primo albergatore, il primo mercante, il primo maestro…
In uno spazio, in un ambiente comunicativo crescono bisogni e relazioni tra i membri della società, finché non sorga gradualmente una organizzazione, “senza di cui non si potrebbe immaginare una normale esistenza”, e che “non è affatto il risultato di una volontà comune, diretta alla sua costituzione”. Anche la rete internet è una rete essenzialmente inintenzionale. Questa è la sua forza. Così com’è oggi, non è stata inventata da nessuno. È un ordine spontaneo come l’occhio, come il sistema nervoso, come il cervello. Da questo punto di vista la rete internet mostra di avere ogni garanzia di permanenza, perché trattasi ormai di un COSMOS COMUNICATIVO, formatosi per via spontanea. Così come per tutte le cose nella storia dell’umanità, anche internet è un ESITO, un risultato inintenzionale di azioni intenzionali.
Una rete comunicativa, un ambiente – come il linguaggio - , non può essere il prodotto di un esplicito e programmato piano di uomini che, riunitisi in un gruppo, decidono di costituirsi uno spazio. Un Ambiente non è mai, non può essere l’esito di progetti umani intenzionali. Le TV generaliste sono intenzionali, volute, costruite per il controllo e la omologazione. Programmi televisivi sempre uguali per 30 anni, con sempre gli stessi interlocutori, con sempre gli stessi conduttori, con sempre gli stessi commentatori, con sempre gli stessi esperti, con sempre gli stessi giornalisti. Spazio e tempo occupati per ridurre la complessità del reale con sensazioni che trasmentono verità confezionate. Per le TV generaliste è impossibile evitare la comoda strada dei luoghi comuni. Su questo strumento controllato e programmato fonda la nuova autocrazia nella società della comunicazione. “L’autocrazia, i dispotismi, le vecchie e nuove dittature, sono il mondo tutto di un colore; la democrazia è il mondo multicolore. Si badi: non la democrazia antica, che fu anch’essa monolitica. E’ la liberaldemocrazia che viene strutturata sulla diversità. Siamo noi e non i Greci ad aver scoperto come costruire un ordine politico attraverso il molteplice e le differenze”[6].
Giovanni Sartori, in un testo ancora troppo poco valorizzato sul metodo e la logica della scienze sociali, afferma che spesso il fare dell’uomo “è preceduto da un discorso (su quel fare). Il discorrere dell’Homo Loquax precede l’azione dell’uomo operante”[7]. La TV generalista in un network autocratico moderno rompe questa simbiosi. L’homo loquax non è più lo stesso uomo del fare che rappresenta la politica. Con la tipologia di TV generaliste italiane, l’autocrazia di una complessità ridotta e volgarizzata da sensi autoprodotti per l’eterodirezione degli utenti, esiste soltanto l’homo loquax, colui che occupa lo spazio e il tempo precodificato della comunicazione per imporre la propria sensitiva verità alla complessa logica ed epistemologia della realtà della vita (lebenswelt).
Il vero vulnus della democrazia italiana è nel blocco e nel controllo delle TV generaliste.
ooo/ooo
[1] LUHMANN Niklas, Illuminismo sociologico, Il Saggiatore, Milano 1983, p. 102
[2] David Riesman, La Folla Solitaria,Il Mulino, Bologna 1976, p. 239
[3] vedi CIPOLLA M.Carlo, Storia economica dell'Europa pre-industriale, Bologna, il Mulino, 2002
[4] vedi LEVER F., RIVOLTELLA P., ZANACCHI A., La comunicazione: il dizionario di scienze tecniche, RAIERI, Roma 2002
[5] vedi McQUAIL D., Sociologia dei media, Il Mulino, Bologna 1996
[6] Sartori Giovanni, DEMOCRAZIA E DEFINIZIONI, Il Mulino
[7] Sartori Giovanni, LA POLITICA: logica e metodo nelle scienze sociale, Sugar, Milano, 1980, pag.9


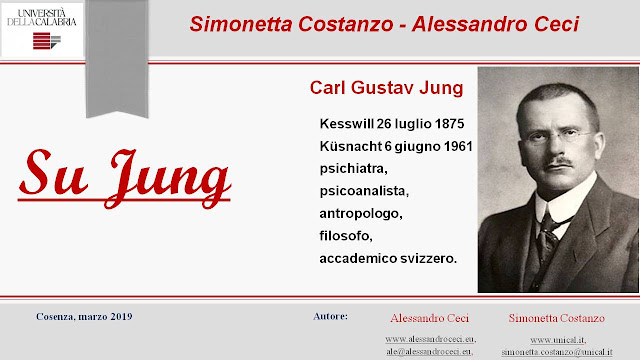
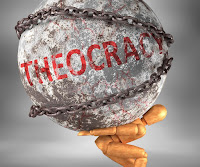

Commenti
Posta un commento